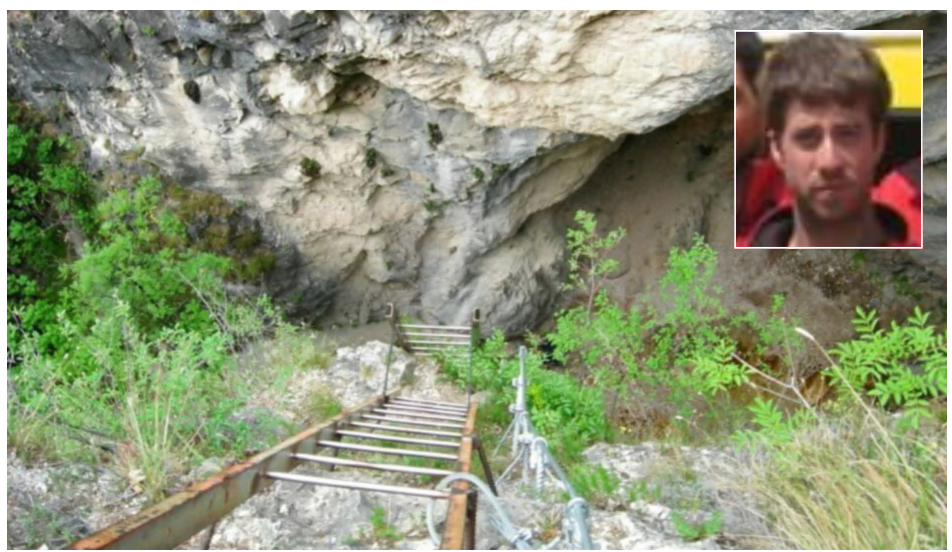l'editoriale
giovedì 11 Settembre, 2025
La funzione del buon insegnante
di Maria Prodi
Immaginare che un maggior numero di bocciature sia segno di scuola seria equivale a affermare che più incidenti si fanno sulle strade migliore è la circolazione, perché si selezionano i guidatori più abili

I decreti, le procedure, le graduatorie, le circolari, le precedenze, i punteggi, le assegnazioni. Chi osserva la macchina della scuola vede un complicatissimo ingranaggio burocratico che si sta faticosamente avviando, anche quest’anno, con tante magagne e qualche «editto» nuovo di cui discutere sui social.
Per esempio, l’esame di maturità si chiamerà di nuovo esame di maturità invece che esame di stato, pur continuando ad essere un esame di stato.
L’alternanza scuola-lavoro che era stata rinominata Ptco cambia di nuovo nome e si chiama Formazione scuola-lavoro. Chi farà scena muta all’orale sarà bocciato (mentre chi dichiarerà la sua contrarietà all’esame e reciterà la lista della spesa sarà promosso?). Ci saranno solo 4 materie oggetto di prova orale, come ai tempi dei boomers, e solo 4 commissari, così da risparmiare un terzo dei compensi. L’esame conclusivo del percorso scolastico, che quest’anno ha promosso il 99,7% degli studenti, sarà quindi un po’ più facile, merito del ministero del Merito. E da tutte le scuole del regno spariranno come per magia i cellulari, pare.
Insomma, se la scuola è una macchina in cui basta attivare comandi per raggiungere le mete desiderate, non possiamo lamentarci. Di direttive ne arrivano sempre, e sempre di più. «Facite ammuina» diceva il vecchio detto attribuito alla Marina militare napoletana. Date l’impressione di attivismo e di decisionismo, se non riuscite a cambiare le cose, almeno provvedete a qualche ritocchino, e soprattutto, cambiate nomi alle cose.
Però la scuola non è una macchina. Non solo, almeno.
Oggi in Trentino, e in ordine sparso nelle diverse regioni, sette milioni di studentesse e studenti si stanno affacciando al nuovo anno scolastico. Della scuola-macchina sanno poco, e questo è un bene. Per loro il senso primo di quel giorno sarà incontrare persone che condivideranno con loro un bel pezzo di strada, come compagni e come insegnanti, per imparare a capire, a fare, a sapere.
La buona scuola sarà quella in cui saranno riconosciuti e accolti, stimolati a camminare sulle loro gambe, ma anche sorretti se ne avranno bisogno. Che influenza hanno le direttive sparate a raffica dall’alto su quell’alchimia che avverrà o non avverrà fra persone-insegnanti e persone-allievi? Molto poca, in realtà. In alcuni casi perché le direttive-annuncio, esercitate con l’incuranza dello stato dei fatti e della realtà, ordinano cose che spesso già si fanno, e si fanno consapevolmente. Come la storia dei cellulari, già normata in quasi tutte le scuole in base all’autonomia organizzativa e didattica. E un poco perché i diktat che arrivano per via burocratica non incidono, se non molto lateralmente, sulla significanza ed efficacia dei processi di insegnamento e di apprendimento.
Un buon insegnante lo sa che non può ordinare ai suoi alunni di amare quello che fanno. Neanche con la faccia feroce o con le minacce. E sa che è difficile imparare senza motivazione e interesse. Invece pare che chi sta nella cabina di regia della scuola-macchina ignori il fatto che non è possibile riuscire a telecomandare i processi reali che avvengono nelle scuole, non nella loro sostanza. Fra essere insegnanti burocraticamente a posto ed essere insegnanti appassionati ed efficaci ci può essere un abisso. Non esiste una leva che attiva robot, almeno per adesso. Ci sono persone che esercitano un mestiere che richiede capacità educativa e nello stesso tempo lucida conoscenza dei contenuti da trasmettere o, meglio, da far scoprire.
Perché la scuola è una comunità di persone, il cui gesto fondante è la relazione fra la persona che apprende e quella che insegna, non è perciò una macchina. Nessun miglioramento della scuola può avvenire se non passa per questa relazione, nessuna riforma organizzativa può sostituire l’irriducibile contributo che danno le persone.
Non si ottiene la crescita di una persona decretando punizioni o usando la minaccia. Si può ottenere qualche imparaticcio momentaneo, evanescente, che si cancella quando sfuma la paura. Ma che per imparare davvero, per capire, occorre volerlo. E incrociare questa motivazione, sollecitarla, alimentarla è quello che un bravo insegnante prova a fare. A volte non ha successo, anche se è bravissimo perché, se fosse un automatismo avrebbe davanti un burattino, e non una persona. A volte riesce a contagiare con la sapienza disciplinare e con la passione per la sua materia, a volte convince dell’utilità di quelle competenze, a volte gioca la carta di un impegno personale. A volte esercita anche il suo potere di sanzionare o di punire, che però è reso efficace dal tessuto di stima e di riconoscimento reciproco che ha saputo creare. Lo strappo è visibile se c’è una trama relazionale, e se si manifesta, assieme alla sanzione, la volontà di ricucirla, quella trama. Lo strappo su di una tela lacerata non produce effetto.
La discussione sulle bocciature del Trentino è partita con il piede sbagliato. Immaginare che un maggior numero di bocciature sia segno di scuola seria equivale a affermare che più incidenti si fanno sulle strade migliore è la circolazione, perché si selezionano i guidatori più abili. O che un allenatore che mette fuori uso i suoi atleti sia più capace di uno che li conduce ai risultati che sono alla loro portata.
In questi giorni si cerca di completare la lunga sequela di passaggi che servono a «coprire le cattedre». Né le esigenze progettuali e didattiche delle scuole né i talenti o i profili dei docenti incidono sulla logica, centrata su punteggi e graduatorie, di un complicato gioco dei quattro cantoni che assegna i docenti alle scuole. Gli insegnanti sono fungibili, indistinti, portatori di titoli, di anzianità, di precedenze.
Quello che auguro alle studentesse e agli studenti è invece di incontrare negli insegnanti persone significative e adulte, che non si sentano rotelle di un sistema, ma educatori capaci di rischiare in proprio. Agli insegnanti di disporsi alla traversata di un altro anno in mezzo a bonaccia e tempeste, sapendo che il carico dei loro ragazzi è il più prezioso che ci sia.
L'editoriale
Una comunità basata sulla cura
di Gianluca Salvatori
Ci troviamo a fare i conti con la crescita della domanda di assistenza di lungo periodo, la persistente carenza di personale sanitario e sociosanitario, e l’aumento dei costi pubblici e privati per le cure. Tutto ciò in un contesto di profonde disuguaglianze territoriali