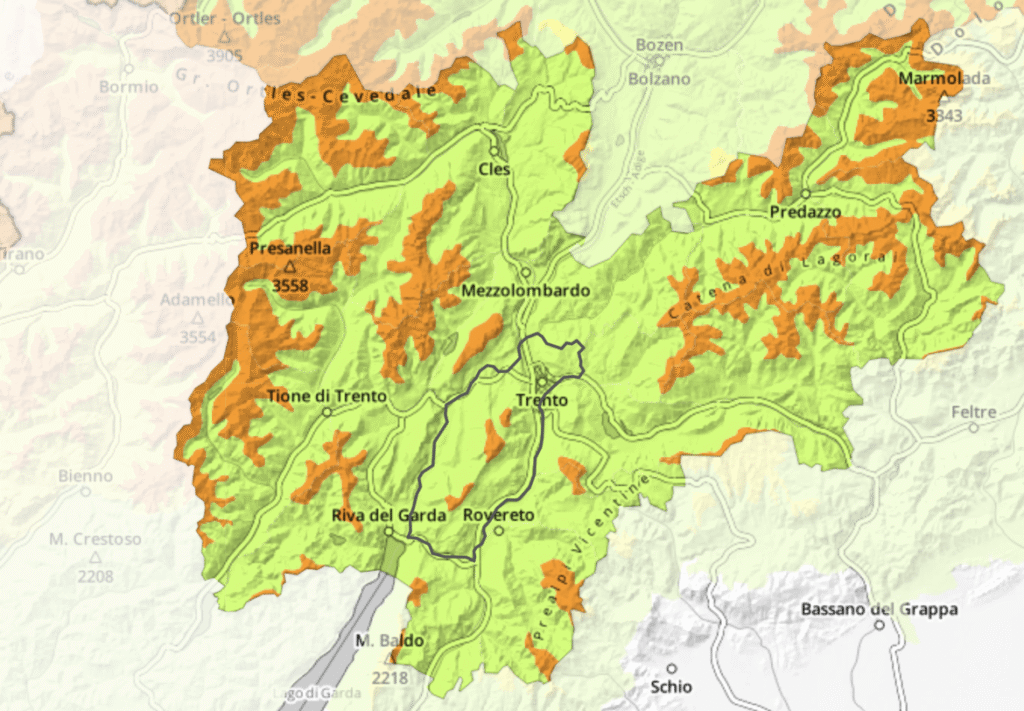terre altre
venerdì 13 Giugno, 2025
Castel Condino, il paese senza smartphone dove resiste l’umanità
di Alberto Folgheraiter
Dal Marocco al Ghana, anche i migranti raccontano che in questa realtà di 214 abitanti si vive bene. Il barista Pizzini: «Attività chiuse perché bastonate dalle leggi»

Uno dei più piccoli comuni della provincia di Trento (214 abitanti appena), alla consultazione referendaria di domenica e lunedì Castel Condino ha fatto registrare una partecipazione di prima grandezza (pur nel mancato quorum): 40,3%. Terza posizione tra i 166 comuni del Trentino. E sì che motivi di protesta ne avrebbero più d’uno gli abitanti di questo villaggio nella media valle del Chiese. A cominciare dal telefono cellulare. Che è muto da sempre.
Peraltro smentendo lo slogan che «una telefonata ti allunga la vita» come recitava (1994) un fortunato spot pubblicitario della SIP, poi Telecom, poi TIM. Infatti, i pochi abitanti vantano una invidiabile longevità. Certo, si muore anche qui (3 funerali lo scorso anno) e si nasce con il contagocce (una sola bambina nel 2024).
In codesto villaggio, allungato a mezza costa sulla montagna, la popolazione pare davvero felice. Non trovi una persona immusonita a cercarla con il lanternino. A cominciare dall’immigrato dal Marocco, Itairi Mür (1955), colto a lato della strada che da Cimego si arrampica sul dos Foglar. Intento a recitare le sue orazioni di musulmano devoto, inginocchiato su una stuoia, le scarpe sistemate accanto al furgone parcheggiato in una piazzola. La famiglia in Marocco, un figlio a San Lorenzo in Banale. Ha praticato il commercio ambulante di stoffe in varie zone d’Italia per una quarantina di anni. «Prego cinque volte al giorno, a cominciare dalle 2.30 di notte. Quella è la più pesante». A fine estate tornerà definitivamente in Marocco, vicino a Marrakesh. «Qui mi sono sempre trovato bene».
E sorride felice pure un altro immigrato, Bakka, 27 anni. Originario del Ghana è arrivato in Italia 19 anni fa, con i genitori che oggi vivono in Sicilia. «Sono venuto qui a Castello alla fine di settembre dello scorso anno. Mi piace, si sta bene. Ho imparato a fare il cuoco a Palermo; a Napoli ho frequentato un corso di cucina». Bakka fa il cuoco e l’aiuto barista nella «Locanda dei Castellani» dove, in questi giorni, alloggia una comitiva di pensionati da Cesena. «Paese splendido anche se un po’ fuori mano», dicono. «Si respira aria buona, qui come sulla montagna, a Boniprati dove ci sono tre punti di ristoro».
Castel Condino è davvero uno strano villaggio. Le abitazioni di cinque, sei piani, fabbricate su robusti muraglioni ancorati alla roccia. Molte sono sprangate. I cartelli «vendesi» sono una costante come in altri villaggi della montagna trentina. «Non c’è una statistica sulle case in vendita, ma buona parte del paese ha fabbricati senza inquilino», rivela il vicesindaco Lorenzo Bagozzi (2001).
Castello fu terra di emigrazione fin dai tempi in cui la Serenissima dominava anche il Trentino meridionale (XV-XVI secolo). Nel 1629, quando a Venezia divampò la peste che avrebbe causato 500 mila morti, quaranta emigrati da Castello tornarono in valle del Chiese. Nel timore, rivelatosi fondato, che fossero infetti, i disgraziati furono confinati, per la quarantena, a «Baitone delle Braghe», in una stretta valle, di là da un rio.
In un primo tempo, i quaranta «sospetti» ricevettero i viveri dai congiunti rimasti in paese. Manifestatasi la pandemia, gli emi-grati furono abbandonati al loro tragico destino. Morirono di peste e di fame, com’era accaduto secoli prima agli abitanti di Merlino e di altre contrade delle Giudicarie. Nel 1836, in presenza di un nuovo contagio (in questo caso di colera) i capifamiglia di Castel Condino fabbricarono in quel luogo una cappella votiva, detta «chiesetta dei morti». In memoria dei morti di peste del 1630. Gli abitanti ci vanno in processione la quarta domenica di agosto. Quel giorno tornano anche gli emigrati, coloro che ancora oggi risiedono in Svizzera o comunque in Europa. Già varie famiglie sono rientrate dall’estero negli ultimi decenni. Come quella di Lorenzo Bagozzi.
Alle recenti elezioni comunali, il giovane vicesindaco di Castel Condino ha ottenuto 51 voti, primo nelle preferenze espresse dai 147 votanti (65,3%) di un comune che ha appena 225 aventi diritto al voto (dei quali 38 residenti all’estero). Laureando in Studi Internazionali, Lorenzo (Bagozzi è il cognome maggiormente diffuso in paese tant’è che lo portano 6 dei 10 consiglieri comunali, sindaco compreso), ha le idee chiare: «Gli abitanti del mio comune sanno che il paese presenta delle scomodità, sanno che offre possibilità minori rispetto ad abitati maggiori, eppure sono totalmente legati al proprio territorio e alla propria storia. Sono resilienti, al punto che affrontano queste sfide con il sorriso e tengono viva la comunità». Un villaggio prevalentemente di persone anziane. «Questa è un’altra caratteristica. Ma il bello è che tra le vecchie generazioni e noi giovani ci si frequenta, magari ci si incontra al bar, si chiacchiera… C’è un trasferimento di tradizioni e di saperi. Ciascuno è coinvolto in un percorso comunitario. Nessuno è abbandonato a sé stesso».
Intanto, vicesindaco Bagozzi, qui il segnale del telefono funziona a singhiozzo e solo in qualche angolo dell’abitato. «Quando i dispositivi tecnologici difettano, o non ci sono, la fa ancora da padrone l’umanità».
Sulla montagna, sopra Castel Condino, nella piana di Mangio (1290 m) un Cincinnato della politica trentina fa il contadino. Remo Andreolli (1951), dieci anni da consigliere provinciale (1998-2007), già segretario dei DS (poi PD): «Un contadino che lo fa da pensionato. Si fa fatica fisica, certo, ma è molto piacevole perché è rilassante. Da tre anni, con la pensione, mi dedico alla coltivazione delle patate, allo sfalcio del fieno. Quest’anno ho realizzato anche un piccolo vigneto, a quota 630 metri. Faccio il pendolare tra Sorni di Lavis e Castel Condino dove risiedo da sempre». Come i bambini e i ragazzi, una decina, costretti a frequentare le elementari a Condino, le medie a Pieve di Bono.
Le case sono a più piani perché sulla cima c’era il fienile, qui chiamato «grà». Racconta Armida Bagozzi, (1934), che sulla grà, oltre al fieno, si mettevano i covoni del frumento e, a novembre, il grano saraceno. «Il frumento era in tutti i campi. C’erano cinque molini e ciascuno si faceva la farina da sé». Tagliate le spighe del frumento si seminava il «formentàc». In tal modo si avevano due raccolti di granaglie.
La polenta di grano saraceno (“de marìn”) era il pasto quotidiano dell’inverno. A fine febbraio si seminavano le patate perché i campi di Castello sono sempre stati sulla costa solatia. Qui l’inverno era mite».
Fiorino Bagozzi, 85 anni: «A Castello la primavera è in anticipo almeno di un paio di settimane rispetto al fondovalle. Una volta si coltivava anche la vite. Ma era tanto tempo fa. Poi venne la grande guerra, qui c’era il fronte con l’Italia, e la popolazione fu sfollata in val Rendena e nel Bleggio».
La costa è tutta boscata ma un tempo da Cimego a Castello era solo campagna. Giorgio Pizzini, 81 anni, proprietario dell’unico bar del paese: «A Castello c’erano vari esercizi commerciali, poi sono stati chiusi perché le attività sono state bastonate dalle leggi. La Finanza e i Vigili erano qui una volta al mese a controllare tutto. Se nel frigorifero avevi sistemato carne e salame prendevi la multa perché ci volevano due frigoriferi distinti. Allora piuttosto che pagare… hanno chiuso». Invece di chiudere il paese, il vicesindaco Bagozzi dice che si sta pensando a progetti di sfruttamento turistico. «Vorremmo sviluppare la zona di montagna (Boniprati) e stiamo studiando alcune soluzioni per trattenere i giovani (una quarantina da 15 a 30 anni). Come in tutti i borghi periferici del Trentino l’inverno demografico rischia di essere permanente». Eppure qui sono felici. Anche senza telefono, o forse proprio per questo.
Sicurezza
Telecamere «intelligenti» con l'AI e braccialetti per contrastare le aggressioni al personale: al via la sperimentazione al Santa Chiara
di Redazione
La direttrice della Provincia Furlani: «Rispettate tutte le normative europee in materia di protezione dei dati». Ferro: «Nel 2025 episodi in calo»