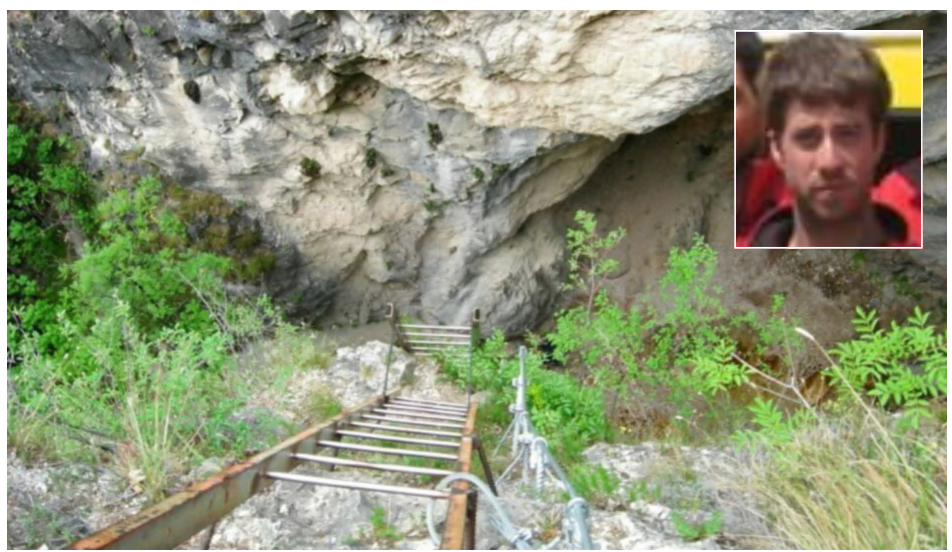l'editoriale
lunedì 15 Settembre, 2025
Fine vita, un dibattito da affrontare
di Simone Casalini
Dal genere alla sessualità, dalla malattia (la follia, la devianza) alla morte, il corpo è sempre stato il bersaglio di interdizioni e di esclusioni, di collocazioni e costruzioni nel tentativo di normarlo

Al centro o fuori dai riflettori il tema del fine vita avanza nella quotidianità della sofferenza e nell’inazione politica. Per limitate situazioni, circoscritte dall’intervento della Corte costituzionale, il suicidio medicalmente assistito è una possibilità già esistente in Italia e le proposte di legge di iniziativa popolare dell’Associazione Coscioni lo stanno portando nelle Regioni per declinare in procedura i principi fissati dalla Consulta. Ergo, meglio attrezzarsi per un dibattito serio che limitarsi ad osservare la sua applicazione forzata.
Il dilemma della morte interroga l’umanità da sempre. E ancora di più quando questa è provocata da un gesto volontario o da una richiesta di interruzione del percorso di vita.
Qualcuno aggiungerebbe anche l’aggettivo «naturale», ma nel mondo plasmato dalla tecnologia di naturale è rimasto ben poco e la soglia tra vita e morte si è radicalmente spostata. Si è fatta largo la categoria della sopravvivenza, dell’esserci in modo precario e afono, doloroso e senza prospettive, pur di allontanare l’ultimo passo.
La filosofia – che oggi è diventata rilettura – si è misurata da sempre sul suicidio. Per rispondere ad una domanda: a chi appartiene la vita? Nelle «Lezioni di etica» Kant affermava che «noi uomini siamo quaggiù delle sentinelle, che non possono abbandonare il loro posto». Hume, invece, nel testo «Sul suicidio» consapevole che «l’età, le malattie o le sventure possono far della vita un peso e renderla anche peggiore dell’annichilimento» sosteneva che l’essere umano potesse svincolarsi dalla sacralità dell’esistenza: «Vinca coraggiosamente i territori naturali della morte ed esca da questa scena crudele». La sovranità completa su vita e morte da parte dell’individuo appartiene a Nietzsche: «Muori al momento giusto: così insegna Zarathustra. Vi faccio l’elogio della mia morte, la libera morte, che viene a me perché io voglio».
Nella sua puntuale ricostruzione del tema («Il diritto di andarsene. Filosofia e diritto del fine vita tra presente e futuro», Utet) il filosofo Giovanni Fornero ci rammenta che il campo politico/culturale si è sempre diviso tra la posizione di indisponibilità della vita e quella di disponibilità. Le obiezioni del primo nucleo (indisponibilità) non sono solo di natura religiosa o metafisica (la vita è irrinunciabile perché appartiene a Dio), ma anche pubblicistica (la vita è dello Stato e della comunità) e personalista (la vita è un bene prezioso e non esiste una legittimità alla sua rinuncia). I sostenitori della disponibilità assegnano alla persona l’ultima parola in una morale che riconosce all’esistenza un valore fino a quando decide che sia così. «L’individuo non ha solo la disponibilità dei propri modi d’essere, ma anche del proprio essere e non essere (nel senso dell’amletico to be or not to be)» scrive Fornero.
La posizione religiosa nel dibattito pubblico si è sfumata molto negli ultimi vent’anni. Dal caso di Piergiorgio Welby (2006) – a cui vennero negati i funerali in chiesa – ad oggi in cui la dottrina si è allentata nella direzione di una comprensione delle ragioni che agitano il fine vita. Ancora meno resistente appare il pensiero pubblicista in una fase storica di società frantumate e Stati solo retoricamente risorgenti.
Questa danza intorno al corpo non è sorprendente. Dal genere alla sessualità, dalla malattia (la follia, la devianza) alla morte, il corpo è sempre stato il bersaglio di interdizioni e di esclusioni, di collocazioni e costruzioni nel tentativo di normarlo. Pensiamo alla malattia mentale, al desiderio di rinchiuderla che agita ogni società, anche quelle che hanno decostruito le istituzioni manicomiali per riconsegnare alla vita il folle e liberarlo, almeno parzialmente, dal pregiudizio discorsivo che era stato eretto intorno alla sua figura.
Il suicidio assistito è oggi riconosciuto in Italia grazie a una sentenza della Corte costituzionale del 2019 che lo consente a persone tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale, affette da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze, ma pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale. Una sentenza che colma il vuoto lasciato dal parlamento, ora diviso su una proposta del governo che disattende alcuni principi fissati dalla stessa Consulta. Dopo la Regione Toscana che ha legiferato in merito, l’associazione Luca Coscioni ha proposto disegni di legge di iniziativa popolare in altre realtà. In Trentino, proprio in questi giorni, è stato raggiunto il quorum delle firme necessarie (2.500) e quindi il testo sarà portato all’attenzione del Consiglio provinciale. Norma semplicemente il dettato della Corte costituzionale disponendo le modalità di organizzazione del suicidio medicalmente assistito con il coinvolgimento dell’Azienda sanitaria, l’istituzione di una commissione di specialisti, una procedura di verifica dei requisiti per chi presenta domanda che si deve concludere entro un mese.
Sul fine vita le posizioni politiche e partitiche sono oggi molto più attenuate che in passato perché ci sono sensibilità che trasversalmente sostengono la necessità di disciplinare una facoltà che è molto delicata. Forse se ascoltassimo di più le sofferenze e le omissioni dei corpi sopravviventi e meno i precetti ideologici o teologici, se analizzassimo con più profondità le ragioni per le quali oggi il tema è così sollecitato, ci renderemmo conto che le nostre posizioni personali talvolta rischiano di essere insensibili.
Il Consiglio provinciale, l’Autonomia nel suo insieme (partendo dalla Chiesa e dalle articolazioni della società) hanno di fronte l’occasione di un dibattito alto e sensibile – depurato dagli interessi di parte – che può contribuire a scrivere un capitolo della nostra vita insieme.
L'editoriale
Una comunità basata sulla cura
di Gianluca Salvatori
Ci troviamo a fare i conti con la crescita della domanda di assistenza di lungo periodo, la persistente carenza di personale sanitario e sociosanitario, e l’aumento dei costi pubblici e privati per le cure. Tutto ciò in un contesto di profonde disuguaglianze territoriali