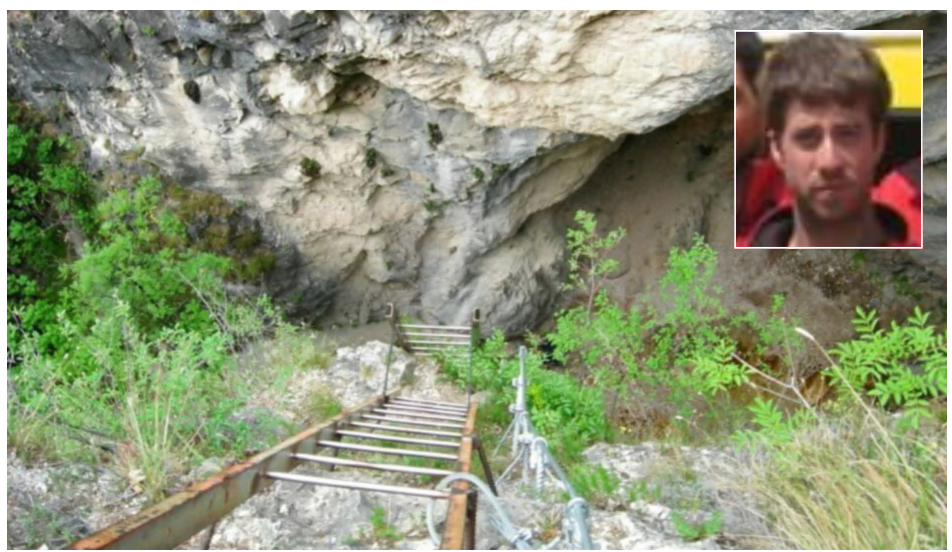L'editoriale
sabato 13 Settembre, 2025
Gli effetti della crisi francese
di Andrea Fracasso
Una parte della stampa e della politica italiana interpreta le difficoltà di Parigi come una rivincita, ma c'è poco da esultare: i rischi all'orizzonte sono molteplici

In questi giorni in Francia si è consumata una crisi di governo che ruota intorno alla mancata approvazione di drastiche misure richieste dal premier Bayrou per correggere la crescita dell’indebitamento pubblico. Il debito pubblico francese in rapporto al prodotto interno lordo (Pil) è aumentato rapidamente passando dal 100% nel 2019 al 114% nella primavera 2025. È il terzo maggior livello nella zona euro dopo la Grecia (152% circa) e l’Italia (137% circa). Questo andamento riflette lo sforzo profuso per fronteggiare le conseguenze della pandemia e della crisi energetica, la progressiva riduzione delle entrate a partire dal 2017 e l’elevata spesa per uno stato sociale inclusivo. Oltre all’andamento del debito, a preoccupare è il perdurare di un elevato disavanzo annuale. Nel 2024 il deficit è stato pari al 5,8% sul Pil e i timidi miglioramenti attesi per il 2025 non sembrano alla portata. La spesa per interessi è aumentata di due volte e mezza dal 2020 e ora vale il 2% del Pil.
Diversi esecutivi si sono alternati nel tentativo di proporre al Parlamento misure per contenere il disavanzo, ma forze politiche e popolazione hanno opposto resistenza. La lenta e difficile riforma del sistema pensionistico, adottata nel 2023, è un caso paradigmatico della difficoltà di fare riforme strutturali. Questo quadro suona familiare a italiani e italiane che hanno visto crisi di governo collegate a difficoltà nelle finanze pubbliche, e viceversa. Dopo le fatiche per soddisfare i parametri di convergenza della moneta unica e dopo le misure per rientrare dalla crisi del debito dieci anni fa, l’Italia ha vissuto un periodo di relativa stabilità finanziaria. A questo hanno contribuito la serietà nella programmazione economica, i massicci acquisti di titoli della Banca centrale europea e gli interventi finanziati dal NextGenerationEU (debito europeo).
Nonostante l’Italia rimanga in una posizione di maggior vulnerabilità ed esposizione debitoria della Francia, è innegabile come quest’ultima abbia ridotto lo storico vantaggio in termini di stabilità percepita. Una parte della stampa e della classe politica italiana ha interpretato le difficoltà francesi con uno spirito di rivincita o quantomeno con il sollievo di non essere i soli, tra i Paesi fondatori, ad affrontare tensioni sui mercati finanziari. Pur comprensibili, queste posizioni non sembrano appropriate.
È vero che il debito italiano viene percepito come relativamente meno rischioso, quindi più appetibile, quando altri peggiorano. La spiccata riduzione del differenziale (spread) di rendimento sui titoli pubblici a dieci anni tra Italia e Francia è dovuta tanto al «peggioramento» francese quanto al miglioramento italiano. Non si deve però perdere di vista il fatto che è il valore assoluto dei rendimenti a influenzare la sostenibilità del debito, il costo del credito a lungo termine e lo spazio che rimane, dopo il pagamento degli interessi, per la spesa sociale. I titoli a dieci anni dell’Italia rendono circa il 3,5% annuo. Nonostante i notevoli progressi in questi anni, è un valore superiore a quello dei titoli di Spagna e Portogallo, costrette a ricorrere all’assistenza finanziaria europea dieci anni fa. Fa quindi bene il ministro Giorgetti a rivendicare l’utilità di una politica economica prudente e la necessità di preservarla nel tempo. La spesa per interessi in Francia è, in rapporto al Pil, la metà di quella italiana nonostante il debito francese sia quattro quinti di quello italiano, e questo è merito dei più bassi rendimenti francesi negli anni.
Molteplici i rischi all’orizzonte. Si osserva un aumento dei rendimenti internazionali a causa di una crescita (osservata e attesa) dell’indebitamento pubblico. Gli investimenti per affrontare il cambiamento climatico e la decarbonizzazione, così come l’aumento delle spese militari, contribuiranno a mantenere elevata la spesa pubblica. L’invecchiamento della popolazione comporterà sia spesa aggiuntiva, sia minor reddito. Il mondo produttivo chiede maggiori sostegni pubblici (specie dopo lo sdoganamento degli aiuti di Stato nell’Ue). Anche se le pesanti implicazioni del Superbonus edilizio sulle finanze pubbliche italiane consigliano prudenza, è comunque probabile aumentino gli interventi di politica industriale (si spera diretti alla crescita della produttività).
Un altro motivo per guardare con preoccupazione ai problemi francesi riguarda i riflessi della maggior rischiosità percepita del debito francese sull’Italia. L’esperienza insegna che quando un grande Paese incontra gravi problemi nelle finanze pubbliche, gli operatori finanziari modificano l’esposizione anche verso quelli che gli assomigliano (a prescindere dall’effettivo merito di credito). L’Italia assomiglia a sufficienza alla Francia per non essere esente dal rischio contagio. Salvo un serio aggravarsi della crisi politica ed economica in Francia, tuttavia, questo scenario è poco probabile grazie agli strumenti di difesa di cui si è dotata la Banca centrale europea.
Un secondo effetto indiretto riguarda i rendimenti dei titoli emessi dall’Unione. L’Ue è diventata un importante emittente con rating AAA sui mercati obbligazionari e questo status deriva principalmente dalla solidità dei Paesi. Se i rendimenti dei Paesi oggi più sicuri aumentassero e il rating diminuisse, anche i titoli dell’Unione soffrirebbero. Un ulteriore intralcio, questo, nell’auspicato percorso di condivisione delle risorse per la fornitura di beni pubblici europei.
Tanti i motivi per dispiacersi delle difficoltà francesi. Meglio sperare la crisi non si aggravi e la trepidazione sui mercati rientri. La Francia non è un paese sull’orlo del fallimento, ma necessita di riforme e cambiamenti nel patto sociale che la sostiene. L’incapacità di governare il cambiamento è certamente il peggior nemico francese. Ma, in fondo, è il peggior nemico di ogni Paese.
*Professore ordinario di Politica economica all’Università di Trento
L'editoriale
Una comunità basata sulla cura
di Gianluca Salvatori
Ci troviamo a fare i conti con la crescita della domanda di assistenza di lungo periodo, la persistente carenza di personale sanitario e sociosanitario, e l’aumento dei costi pubblici e privati per le cure. Tutto ciò in un contesto di profonde disuguaglianze territoriali