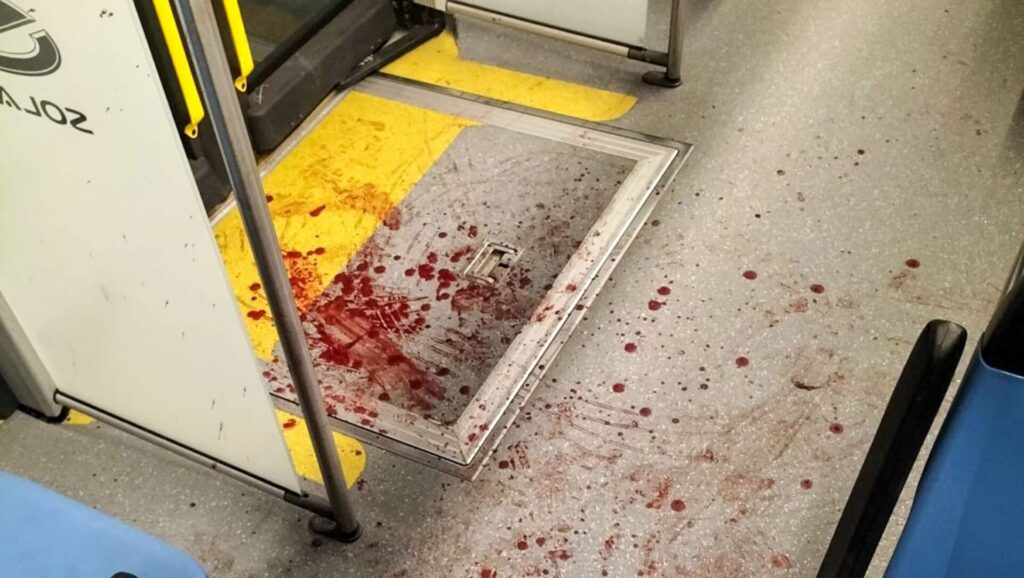l'editoriale
lunedì 8 Settembre, 2025
Un nuovo referendum su Fugatti
di Simone Casalini
Ora siamo all’esplorazione del piano B – il ritorno ad un sistema proporzionale – che consentirebbe di ottenere il medesimo risultato ma con la diluizione del potere del governatore che non sarebbe più eletto direttamente

Mai nella storia dell’Autonomia si era verificata una propensione, come accade oggi, a preparare un’elezione che dista ancora più di tre anni. Le prossime Provinciali sono dallo scorso gennaio – intervista al governatore Fugatti che aprì il fronte del terzo mandato – al centro del dibattito politico, occupando una parte della sua agenda. Questione che sarebbe già stata risolta, almeno per l’attuale maggioranza, se il governo Meloni non avesse impugnato la legge che estendeva da due a tre mandati la durata in carica del presidente della Provincia autonoma di Trento.
Ora siamo all’esplorazione del piano B – il ritorno ad un sistema proporzionale – che consentirebbe di ottenere il medesimo risultato ma con la diluizione del potere del governatore che non sarebbe più eletto direttamente, ossia l’assunto giuridico che impegnerà la Corte costituzionale a novembre nella sentenza sul terzo mandato. Dall’altra parte della staccionata politica si contesta il metodo, piegare il sistema elettorale alle esigenze di rielezione di Fugatti, e si addensano le ambizioni di chi vorrebbe correre in una competizione dove sia esaurita la scia di consenso e di potere dell’attuale presidente leghista.
Sebbene il Patt abbia da tempo sollecitato un cambio del sistema di governo e, dunque, della legge elettorale con un ritorno al proporzionale (vedremo, nella proposta che sarà depositata, con quali caratteristiche) nessuno in maggioranza sembra occultare la realtà. Cioè, che la parte prevalente del ragionamento è quella di non privarsi della leadership di Fugatti poiché aprirebbe scenari di incertezza nella coalizione di centrodestra, a partire dalla riconferma dell’alleanza con le Stelle alpine. E quindi il messaggio è: «Decidano i cittadini chi vogliono come presidente». L’argomento non è, dunque, il sistema politico ma allentare le regole del gioco sulle previsioni che le leggi elettorali assegnano ai ruoli apicali per evitare concentrazioni di potere e rendite di posizione. Del resto nel passaggio dal terzo mandato (iper-verticalizzazione del potere in un sistema che assegna un cospicuo premio di maggioranza a chi vince) al proporzionale c’è la tesi e la sua antitesi. Con un unico filo conduttore che è la figura di Fugatti.
Così facendo si ripropone anche il referendum sulla sua persona che – se la Consulta boccerà la legge sul terzo mandato e la proposta proporzionale proseguirà il suo iter in Consiglio – potrebbe avere entro l’anno un nuovo capitolo nell’assemblea dell’Autonomia. Sullo sfondo, ma fino ad un certo punto, rimane anche la geografia politica che non è estranea alla disciplina elettorale. Da tempo Fugatti (con la lista del presidente) e una parte della sua coalizione (l’assessore Gottardi&Co) stanno promuovendo un tentativo di espansione in un’area di consenso de-ideologizzata e centrista, quell’elettorato mobile che non ha remore a ricollocarsi nel limen tra centro della destra e centro della sinistra. È, per semplificare, quella che all’indomani del voto del 2023 definimmo la fase due del «fugattismo», ossia la transizione da una vittoria ottenuta nel radicalismo politico (2018) ad una con accenti più popolari (2023) che ora vuole essere consolidata.
Va da sé che l’impostazione di un dibattito su interessi di parte è sempre sbagliata e insidiosa. Perché il tema dei sistemi politici sono le istituzioni e il potenziamento democratico, non le persone. Chi ha ruoli di responsabilità sa che ha il suo miglio da compiere per il bene generale. Ed è già un’impresa. E poi che gioco promuoviamo se le regole basiche non sono l’esito di una negoziazione in cui si rispecchi una parte della comunità?
Spogliato delle sue contingenze, il dibattito sulla legge elettorale e il sistema di governo dell’Autonomia avrebbe invece più di una ragione di essere. In primo luogo, partendo da una riflessione – al momento assente in ciò che resta dei partiti – sulla china che la democrazia ha assunto nel mondo e anche nel nostro speciale territorio. Perché l’erosione della partecipazione è un fenomeno consolidato e anche la disaffezione crescente di leadership e classi dirigenti per l’opzione democratica. Possiamo continuare a sottovalutarli?
In secondo luogo, perché maggioritario e proporzionale sono due sistemi elettorali che presentano pro e contro. Nessuno dei due è la risoluzione del problema politico né la sua costituzione. L’abbandono del proporzionale è avvenuto dopo la fine della Prima Repubblica, a suggello della soppressione della «partitocrazia» e dell’instabilità che si era manifestata. È un modello che segue però la Costituzione quando, all’articolo 49, stabilisce che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Pone al centro la rappresentanza e un’idea collettiva, più che personale, della politica. Il maggioritario garantisce all’elettorato di determinare le funzioni apicali (governatore o sindaco) e la governabilità, rafforzando le maggioranze e gli esecutivi con premi nella distribuzione dei seggi. Il suo aspetto degenerativo è il leaderismo, la verticalizzazione del potere che toglie ossigeno alle assemblee, ai movimenti politici e alla società. Paradossalmente nella stabilità politica si è acutizzata la crisi democratica.
L’Autonomia serve se risponde a questi grandi quesiti che riguardano la nostra vita e la nostra quotidianità, sapendo che una legge elettorale non modifica il dna di una società. Altrimenti si riduce ad un gioco di leadership e di ambizioni personali, a prescindere dal fronte che si guarda, che interesseranno sempre meno persone come hanno drammaticamente testimoniato le ultime elezioni Comunali. Günther Pallaver, nell’intervista pubblicata ieri dal T, ha affermato che non esiste Autonomia senza democrazia. Forse può essere il punto di partenza della riflessione.