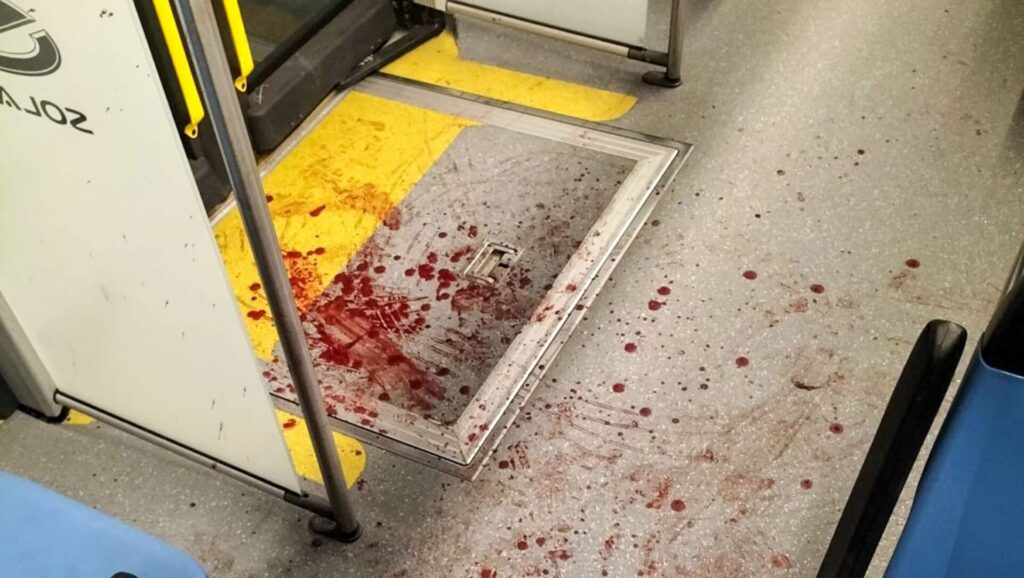L'editoriale
lunedì 1 Settembre, 2025
Gli effetti del virus antidemocratico
di Simone Casalini
La democrazia non è (era) un’organizzazione del campo politico e sociale assegnata per sempre. Se l’invasione della Russia in Ucraina si concluderà con l’annessione dei territori occupati con la violenza e se Israele darà seguito al disegno di espulsione dei palestinesi da Gaza e da parte della Cisgiordania, come atto conclusivo del genocidio in essere, saremo di fronte alla distruzione del diritto internazionale

Se l’invasione della Russia in Ucraina si concluderà con l’annessione dei territori occupati con la violenza e se Israele darà seguito al disegno di espulsione dei palestinesi da Gaza e da parte della Cisgiordania, come atto conclusivo del genocidio in essere, saremo di fronte alla distruzione del diritto internazionale, al superamento dell’Onu e all’apertura di una nuova fase in cui la violenza istituzionale non avrà regole. La legge del più forte.
Questa violenza senza regole è anche l’esito del ritrarsi dei processi democratici nel mondo che hanno abbassato la soglia del sottile equilibrio tra diritti, libertà e giustizia. È la maturazione del concetto di «postdemocrazia» in cui i sistemi liberali degenerano nell’autocrazia, nel leaderismo politico, nella preminenza dell’interesse economico veicolato dalle lobbies e, spesso, dal potere politico stesso (vedi Donald Trump).
La democrazia non è (era) un’organizzazione del campo politico e sociale assegnata per sempre. È una variabile politico-culturale e storica. E se c’è un elemento di sottovalutazione nei sovranismi/nazionalismi e nella cultura, anche popolare, che li sostiene è la profondità con cui essi perseguono, talvolta sottilmente, talvolta platealmente, la progressiva erosione delle libertà e delle tutele delle minoranze, la recrudescenza della nozione di «normalità» usata contro presunte difformità (culturali, affettive, religiose, valoriali), la compressione dei diritti mascherata da esigenza di sicurezza. Sottovalutato perché considerato come un’espressione di momentanea rabbia e ora perfettamente incardinato nelle istituzioni e impegnato nella loro decostruzione. Una rete ormai ampia – dagli Stati Uniti all’Argentina, dall’Ungheria alla Repubblica ceca – che affianca regimi autoritari (dalla Russia alla Cina) e in transizione (Turchia) e che sta ridisegnando la mappa del mondo e dell’ordine internazionale. E quindi il linguaggio, la diplomazia, le regole.
L’Europa, che con tutti i suoi limiti rimane l’ultimo avamposto della dialettica democratica, è come quelle persone che appaiono terribilmente fuori dal loro tempo. Costretta a negoziazioni al ribasso, ridotta alla questua alla Casa Bianca, impossibilitata a rappresentare un’alternativa poiché affetta dallo stesso virus e divisa. Tra chi si offre di allineare il continente all’America trumpiana (Meloni) e chi non scarterebbe probabilmente l’opzione di una guerra su vasta scala (Macron) anche come manifestazione della propria esistenza. Ma quella militare non sembra in questo momento essere un’opzione di deterrenza in possesso dell’Europa, altrimenti Putin e la Russia (tenuti in piedi dalla Cina) non agirebbero come quotidianamente osserviamo. E contiamo, in termini di vittime (ucraine).
C’è un altro aspetto che segnala il decorso della patologia antidemocratica. L’eliminazione sistematica dei giornalisti. Lunedì ne sono stati uccisi cinque (Mariam Abu Dagga, Moaz Abu Taha, Mohamed Salama, Ahmed Abu Aziz e Hussma al-Masri) in un affondo dell’esercito israeliano contro l’ospedale Nasser di Khan Yunis. La tecnica è quella del «double tap», doppio tocco. Si colpisce il bersaglio la prima volta, si attende l’intervento dei soccorsi che ripopolano l’area inquadrata e poi si rifà fuoco. I cronisti che hanno perso la vita a Gaza in 22 mesi di conflitto sono quasi duecento. In vent’anni di guerra in Vietnam ne morirono 64. Di norma Israele giustifica la loro trasformazione in obiettivi associandoli ai terroristi di Hamas, anche se tanti di loro lavoravano per media occidentali. È accaduto anche per l’eliminazione di Anas al Sharif, uno dei corrispondenti di punta di Al Jazeera, assassinato con un drone. Una versione, quella di essere un affiliato di Hamas, ripresa da molti media. Sul quotidiano israeliano Haaretz Gideon Levy ha scritto che non è stato offerto «un briciolo di prove per questa affermazione» e che «un milione di volte più coraggioso di qualsiasi giornalista israeliano, e meno schiavo della propaganda del suo stato, al Sharif avrebbe potuto insegnare le basi del giornalismo ai colleghi israeliani». Poi ha aggiunto che «quando è morto il giornalismo sono morte anche la verità e la solidarietà».
L’Onu (Integrated Food Security Phase Classification) ha certificato che oltre mezzo milioni di gazawi (il 25%) sono ridotti alla fame, dove la carestia è usata come arma di guerra. È un conflitto in cui non esiste proporzione tra offesa e risposta, che si trascina da anni nell’impossibilità di trovare una «verità convivente», dove la distribuzione di ragioni e torti resterà sempre più forte di qualsiasi semplificazione. Ma dove un popolo ormai esangue, quello palestinese, lasciato al suo destino anche dai Paesi arabi, danza sul filo dell’estinzione.
La libertà di stampa non è solo bersaglio di morte. Ma anche di restrizioni e censure che peggiorano di anno in anno il suo stato di salute (come rileva il World Press Freedom Index). Trump lo fa quotidianamente, escludendo dalla Casa Bianca le testate scomode (dal Wall Street Journal ad Associated Press in un elenco senza fine) che cambiano al voltar delle giornate. Non sono ammesse critiche, ma è in buona compagnia. Chi esercita le tre funzioni cardine della democrazia (controllo, informazione e rappresentazione) oggi è debole. La crisi dei media tradizionali – delegata sempre all’avvento di internet e della tecnologia – è in verità la crisi della democrazia. In elezioni dove gli elettori effettivi alle urne sono meno del 50% non c’è bisogno di informarsi. Meglio le narrazioni dei tycoon e dei nuovi affabulatori che sanno costruire con linguaggi personalizzati un itinerario psicoanalitico, nel nome del terrapiattismo, al termine del quale c’è il santo graal: la desertificazione istituzionale e del senso.
È una nuova narrativa che sta polarizzando anche una parte della stampa che invece di difendere la propria autonomia di fronte ai fatti preferisce diventare strumento di propaganda o smarrisce comunque la capacità di analisi. Accade in situazioni estreme (guerra) e ordinarie (pace). Non mi riferisco ad un orientamento politico-culturale, che è proprio di una linea editoriale e che viene declinato con indipendenza, ma alla necessità di molti media di essere parte e di confondersi spesso con le maschere politiche. Anche questo non aiuta a rinsaldare la fragile democrazia contemporanea.