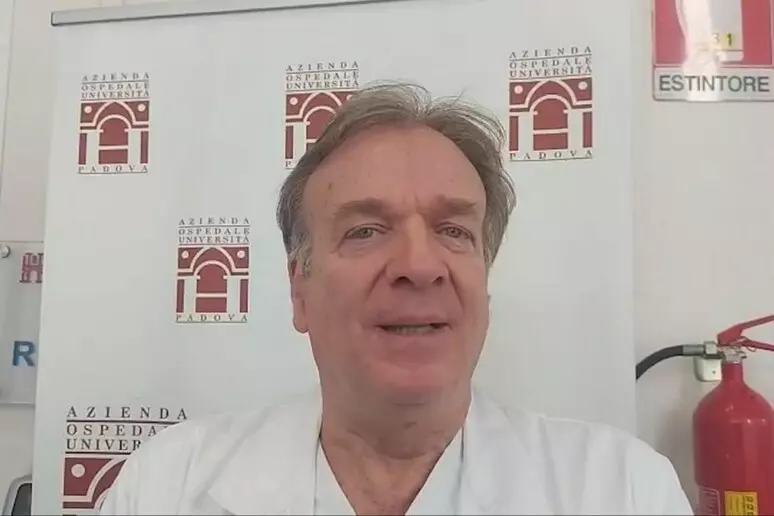L'editoriale
sabato 23 Agosto, 2025
Le buone pratiche dell’abitare
di Flaviano Zandonai
I bisogni crescono, le soluzioni ci sono ma faticano ad affermarsi: serve una nuova generazione di intermediari fra domanda e offerta

Guardando alle vicende legate all’abitare – che, a scanso di equivoci, riguardano non solo l’accesso alla casa ma anche a servizi di supporto e relazioni comunitarie – sembra persistere un paradosso. Da una parte i bisogni crescono, ma dall’altra le soluzioni faticano ad affermarsi o addirittura determinano ulteriori squilibri tra domanda e offerta. Questo stato di fatto è ben rappresentato in un report da poco pubblicato dal centro di ricerca Euricse ricco sia di dati sulla crisi abitativa (uno su tutti: circa il 35% delle famiglie trentine spende più del 40% del proprio reddito per spese legate alla casa), sia di buone pratiche da poter trasferire o ulteriormente diffondere anche in Trentino e accomunate dalla ricerca di una maggiore «socialità» dell’abitare. In buona sostanza ciò che caratterizza queste innovazioni sociali consiste nel declinare in chiave collettiva tutti i verbi dell’abitare: progettare, gestire e governare luoghi di vita grazie a relazioni sociali intenzionalmente costruite che fanno da amalgama tra gli abitanti e tra questi e l’ambiente in cui vivono.
Perché queste soluzioni faticano ad affermarsi? Va ricordato infatti che molte delle proposte – a iniziare dalle cooperative di abitazione fino alle esperienze di cohousing caratterizzate da mix di soggetti diversi – sono presenti ormai da tempo ma all’interno di nicchie di popolazioni, in determinati periodi storici oppure in particolari contesti territoriali e istituzionali. Per sbloccare l’innovazione dell’abitare servirebbe quindi un’azione di consapevolezza e mobilitazione della popolazione che porti a un cambiamento dell’assetto attuale. Si tratterebbe, in buona sostanza, di portare a compimento la crisi abitativa in atto che si manifesta in modo sempre più evidente attraverso le sue contraddizioni come l’overtourism che aumenta le rendite ma espelle le risorse abitanti locali (persone, economie, socialità). Tutto questo al prezzo di un conflitto sociale determinato dal fatto che i possessori del «capitale abitativo» sono gli stessi cittadini visto che l’82% dei trentini è proprietario della casa in cui vive e quindi potrebbero trovarsi su posizioni opposte in termini di interessi e aspettative.
Un’altra modalità di intervento, meno radicale e più negoziata, potrebbe consistere in un ripensamento della natura e delle funzioni degli intermediari. L’abitare infatti è un ambito nel quale l’incontro tra domanda e offerta è molto determinato dalla presenza di soggetti che accompagnano e mediano. Anche le famose piattaforme digitali come Airb&b che amano definirsi «disintermediatrici» sono in realtà strutture che si sono inventate una diversa modalità per fare incontrare domanda e offerta non solo di strutture abitative ma, ancora una volta, di servizi di manutenzione e, non da ultimo, di «esperienze» che consentono di conoscere meglio il territorio e le persone che lo abitano. Tutti questi vecchi e nuovi intermediari – dalle agenzie immobiliari private a quelle dell’edilizia pubblica fino alle già citate piattaforme e alle iniziative dell’economia sociale – sono però chiamati a ritrovare il loro baricentro tra una domanda e un’offerta che richiede di essere sempre più soluzioni su misura. Viviamo infatti in una società fluida anche per quanto riguarda le scelte abitative che sono determinate da una pluralità di fattori: le strutture familiari, le scelte migratorie, le condizioni climatiche, gli stili di vita e le attese di benessere. Tutto questo sollecita le risorse legate dall’abitare affinché siano rigenerate non solo dal punto di vista infrastrutturale e ambientale ma anche della connettività sociale: relazioni di vicinato, economie e servizi di prossimità, mobilità e trasporti.
Se sul fronte strutturale investimenti e incentivi, per quanto in forme e modalità a volte discutibili, ci sono, sulla parte «soft» molto resta da fare, soprattutto a livello di diffusione delle innovazioni sperimentate in questi anni. Sarebbe, quindi, necessario sostenere l’accreditamento per via pubblica di una nuova generazione di intermediari capace non solo di far emergere una domanda di abitare da parte di nuovi segmenti della società ma che sappia anche interloquire con i possessori di abitazioni, con i soggetti economici locali, con le comunità territoriali. Perché senza questo nuovo baricentro di mediazione i divari tra domanda e offerta dell’abitare saranno probabilmente destinati a raggiungere un punto di rottura con conseguenze piuttosto gravi e persistenti nel tempo.
*Sociologo, Open Innovation Manager del Gruppo cooperativo Cgm
l'editoriale
L’ascensore sociale si è rotto
di Gianluca Salvatori
Il sentimento più diffuso, specie nei Paesi a reddito più alto, è che si sia rotto il sistema che aveva consentito ad una maggioranza di elevare costantemente la propria condizione sociale ed economica. Con il rischio concreto, per qualcuno è già una certezza, che la posizione nella scala sociale nel prossimo futuro non possa che peggiorare
l'edioriale
Giovani e disagio, la fatica di crescere
di Maria Prodi
Difficile per gli adulti capirli, perché per insinuarsi nella dimensione di queste vite dovrebbero abbandonare le proprie coordinate e infilarsi nelle bolle social in cui si si dipanano esistenze sbilanciate fra il reale ed il virtuale