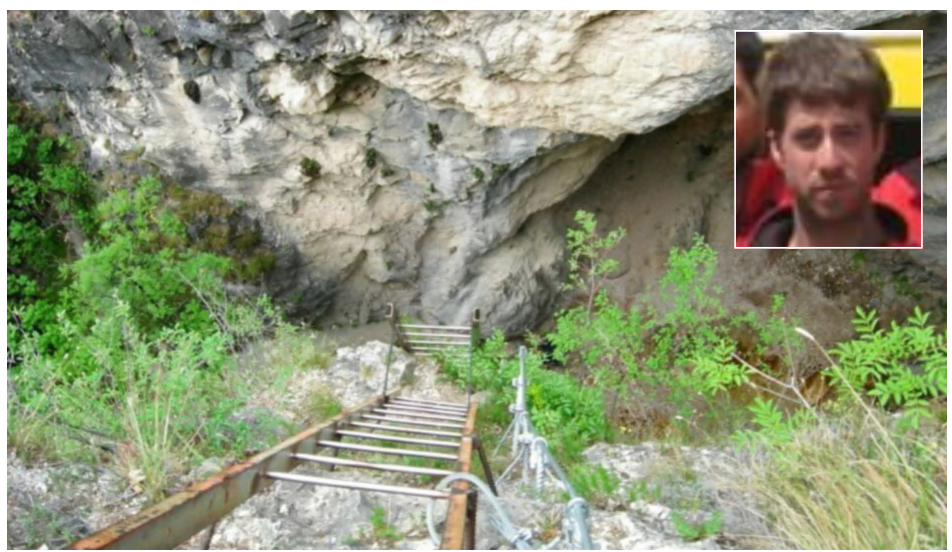Società
lunedì 24 Novembre, 2025
L’analisi spietata del Festival della Famiglia sulla demografia: «Due terzi dei genitori rimpiangono di aver avuto pochi figli»
di Davide Orsato
Da Alessandro Rosina ad Agnese Vitali, i suggerimenti degli esperti: «I sostegni alla natalità vanni aumentati di un valore pari all'1% di Pil»

Ha ereditato orma la nomea di «scienza triste», un tempo appannaggio dell’economia. È difficile restare ottimisti, di questi tempi, studiando le dinamiche demografiche, che mettono l’Italia tra gli ultimi paesi al mondo, con una media di 1,2 figli per donna e una proiezione, per la fine del secolo, che parla di un possibile dimezzamento della popolazione. Con tutte le conseguenze del caso, anche sul welfare. Il Trentino è messo meglio, ma di pochissimo: il numero medio di figli è di 1,26, in ogni caso molto di sotto al tasso di sostituzione.
Gli organizzatori del Festival della Famiglia, i cui eventi sono iniziati giovedì a Trento, hanno avuto il coraggio di partire da questo tema, in assoluto il più spinoso e urgente. E anche, allo stesso tempo, il più frustrante. Tanto che chi è chiamato a fare scelte preferisce spesso lavarsene le mani. Ne è un esempio l’aneddoto raccontato, lo scorso venerdì, da uno dei relatori del panel di apertura, Alessandro Rosina, professore di Demografia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. «Ne abbiamo parlato di recente in un convegno dedicato alla previdenza a Roma. Un esponente politico ha detto: “Sì, è vero, potremmo alzare la spesa per le famiglie di un’1% di Pil, ma sappiamo già che servirà a poco, perché al massimo, dicono le proiezioni, si arriverà a un tasso di 1,6 figli per donna”. Ma da 1,2 a 1,6 cambia già moltissimo: tornare a due figli sembra impossibile in tutti i Paesi che abbiamo analizzato». I numeri citati non sono casuali: 1,6 è il tasso di fecondità della Francia, che spende, per l’appunto, una somma pari all’1% del Pil in più dell’Italia.
Per i relatori, «il Trentino ha avuto il merito di aver introdotto in anticipo il problema in Italia», ma a livello nazionale si rischia di restare al palo. «Il vero problema dell’Italia — suggerisce Agnese Vitali, professoressa di Demografia dell’Università di Trento — è che qui la dinamica è iniziata con largo anticipo, ed è sempre stata ignorata: sono cinquant’anni che siamo in calo demografico».
Eppure una buona percentuale di persone, si parla di circa un terzo (36%), arrivate alla fine dell’età riproduttiva, rimpiange di non aver avuto più figli. Come fare, dunque, per aiutarli? Francesca Fiori (professore a Glasgow) e Giulia Ferrari (ricercatrice a Parigi) hanno portato degli esempi da Scozia e Francia. «Il kit fornito ai genitori scozzesi, con il materiale necessario ai primi mesi di vita e una culla sicura — ha spiegato Fiori — è una misura egualitaria che si è rivelata efficace. È emerso, però, che i genitori avrebbero bisogno di ulteriori 12 mesi di permesso da spartirsi tra papà e mamma». Dalla Francia, secondo Ferrari, può arrivare un esempio concreto dalla copertura degli asili nido, che soddisfano il 60% delle esigenze contro il 28% dell’Italia. Un altro mondo.
Sempre venerdì, nel pomeriggio, l’incontro – moderato da Francesco Terreri, caposervizio de il T Quotidiano – ha messo a fuoco i cambiamenti in atto attraverso dati, analisi e letture pedagogiche e demografiche del fenomeno, grazie agli interventi di Martina Lo Conte (Istat), Jessica Magrini (pedagogista), Elena Pirani (Università di Firenze) e Roberto Impicciatore (Università di Bologna).
Nel suo intervento, Lo Conte ha illustrato l’evoluzione delle famiglie italiane: se nel 2002-2003 quattro famiglie su dieci erano costituite da coppie con figli, oggi la quota è scesa sotto il 30%, mentre le famiglie unipersonali sono aumentate dal 25% al 36%. Entro il 2050 i nuclei cresceranno in numero, ma saranno sempre più piccoli e composti da persone sole. Dinamiche – è stato detto – che influenzeranno sistemi come welfare, pensioni, sanità, cas.
Sul valore delle reti familiari e intergenerazionali è intervenuta Pirani, che ha ricordato come la famiglia non sia un’istituzione statica, ma parte di un sistema di legami in evoluzione. Oggi gli italiani possono contare mediamente su cinque parenti nell’arco della vita, un dato in diminuzione rispetto al passato e che riflette riduzioni nel numero di fratelli e sorelle, compensate in parte dalla presenza più prolungata di nonni.
Magrini, invece, ha portato l’attenzione sui primi mille giorni di vita, momento delicato in cui non solo nasce un bambino, ma prende forma una nuova famiglia. Ha ricordato come i servizi educativi per la prima infanzia svolgano un ruolo cruciale non solo nella conciliazione vita–lavoro, ma anche nell’equità educativa e nella riduzione delle disuguaglianze, specie per i nuclei più fragili.
Economia
Turismo, contratto da rinnovare per 30mila lavoratori in Trentino. I sindacati: «Si trovi un accordo prima delle Olimpiadi invernali»
di Redazione
Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS chiedono il rinnovo del contratto provinciale puntando a stabilizzazione, destagionalizzazione e valorizzazione delle professionalità