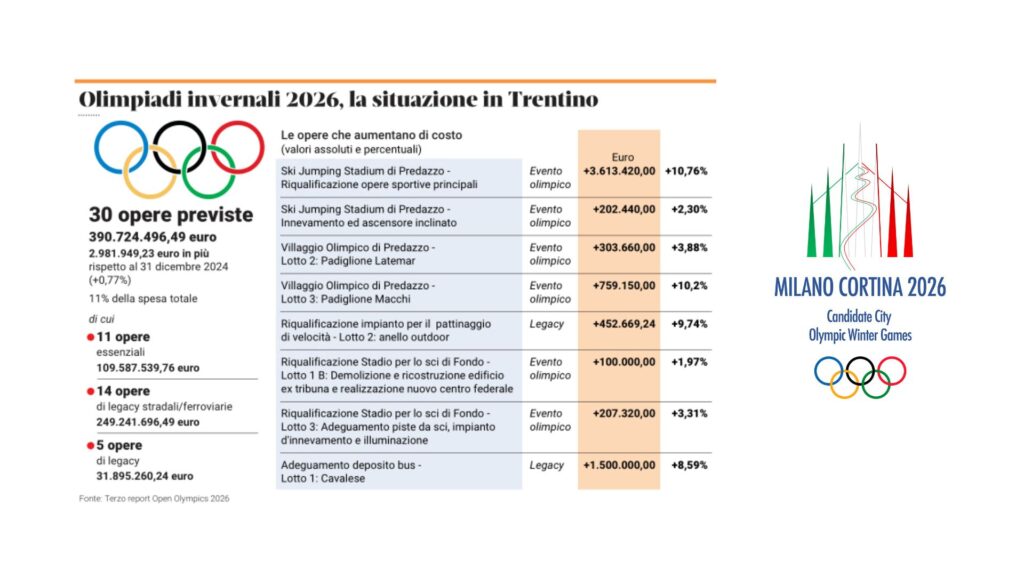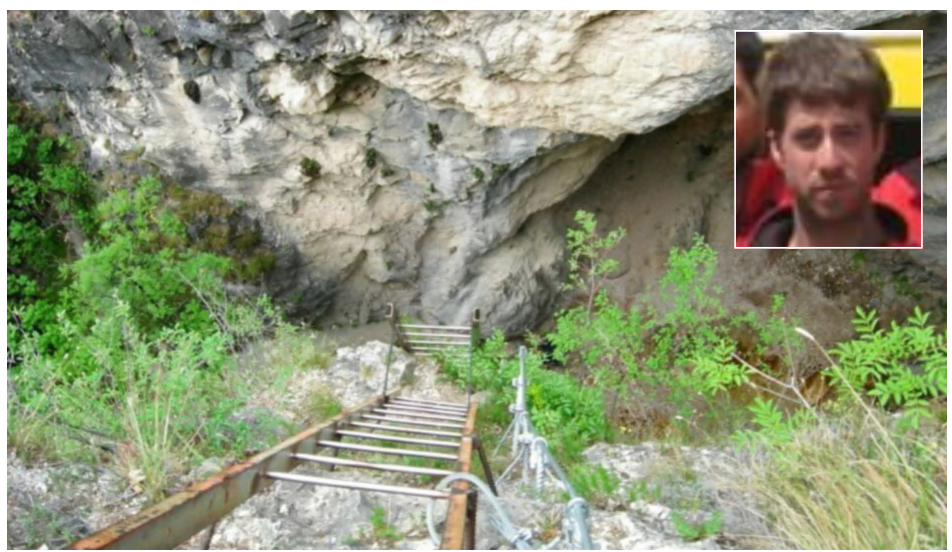Cultura
giovedì 30 Ottobre, 2025
La montagna a colori e in bianco e nero: a Trento la mostra degli scatti di Silvio Pedrotti e quelle del nipote Pietro Cappelletti
di Gabriella Brugnara
«Gli occhi sulla montagna» mette a confronto le immagini di due generazioni di fotografi per raccontare l’ecosistema alpino, tra bellezza, storia e fragilità ambientale

«Gli occhi sulla montagna», un’espressione che definisce uno sguardo: non solo l’atto di osservare, ma la responsabilità di farlo. La specificazione «La fotografia di ieri e di oggi per raccontare l’ecosistema alpino» apre poi il campo d’indagine, proponendo lo stesso paesaggio letto in due epoche diverse, con strumenti diversi, ma con la stessa attenzione. Questo dialogo è al centro di «Gli occhi sulla montagna. La fotografia di ieri e di oggi per raccontare l’ecosistema alpino», la mostra che si inaugura oggi alle 17.30 a Trento, a Palazzo Roccabruna, con la partecipazione del Coro della Sat (fino al 22 novembre). Le fotografie di Silvio Pedrotti (Trento, 1909-1999) e quelle del nipote Pietro Cappelletti mostrano la montagna come memoria e, insieme, come ambiente fragile. Pedrotti la raccontava in bianco e nero come luogo di armonia tra uomo e natura, con lo spirito con cui, nel 1926, nacque il Coro della Sat: un canto corale che celebra bellezza e fatica delle vette.
L’evento rientra tra gli appuntamenti della 26esima Bitm – Le Giornate del Turismo Montano, in programma al Muse dal 12 al 14 novembre. Curata da Francesca Caprini e Alessandro Franceschini, la mostra propone un percorso tra ghiacciai, alpeggi e sentieri della Sat, dove fotografia e memoria si intrecciano per raccontare turismo sostenibile, cultura e identità, restituendo la montagna come esperienza collettiva e culturale, fatta di immagini, voci e responsabilità.
Pietro Cappelletti, partiamo dal titolo della mostra, in cui ogni parola porta con sé un significato. Quale sente più urgente raccontare con le sue immagini?
«Il progetto nasce da un incontro di sguardi: quello di mio nonno e il mio. Dalle sue fotografie, i titoli e le annotazioni si capisce quanto la montagna fosse per lui qualcosa da guardare con attenzione, fin nei piccoli dettagli. Questa è l’idea che ho cercato di portare avanti, il muoversi con un passo lento, concedersi il tempo di osservare. È una scelta che si oppone a una certa fame di vetta, al turismo che corre, consuma e riparte».
Fotografia e memoria si intrecciano per raccontare turismo sostenibile, cultura e identità. Come non incorrere nel rischio che la montagna diventi cartolina?
«Nel percorso espositivo si incontrano paesaggi suggestivi, ma anche immagini che mostrano la tecnologia che oggi attraversa la montagna. Per esempio, un rotore di seggiovia in primo piano, mentre nelle foto di mio nonno si vedevano gli sciatori scendere dal Cornetto in libera, senza impianti. Da una parte la bellezza del paesaggio, dall’altra i mezzi per raggiungerlo, che nel tempo hanno cambiato anche il nostro modo di viverlo. Ho fotografato anche amici che vanno in quota con lo stesso spirito dei miei nonni, quello di camminare, divertirsi, respirare la montagna senza fretta».
Che cosa significa per lei esporre le sue fotografie accanto a quelle del nonno?
«È un dialogo che continua nel tempo. Lavoriamo con strumenti diversi, io con il digitale e il colore, lui con l’analogico e il bianco e nero. Ma la sua impronta resta fortissima. Era molto attento alla luce, alla finezza con cui trattava bianchi e neri in stampa. Oggi cerco di portare quella stessa attenzione dentro il colore, provando a mantenere una continuità di sguardo, anche se le tecniche sono cambiate».
Come si sviluppa l’esposizione nelle sale di Palazzo Roccabruna?
«Abbiamo lavorato su una progressione in tre passaggi. Nella prima sala il pubblico trova un confronto diretto, che propone a sinistra le fotografie di mio nonno, a destra le mie. Gli stessi luoghi sono raccontati con tecniche e sensibilità diverse. Un esempio è il Cornetto, con il Brenta sullo sfondo: nelle sue immagini c’è una montagna di luce e silenzio, e io ho cercato di mantenere quello stesso respiro. La seconda sala è interamente dedicata a lui. Oltre alle fotografie sono esposti alcuni dei suoi oggetti personali: gli sci, il violoncello, e alcune immagini autografate, come quelle con Coppi e Bartali. Qui emerge non solo il fotografo, ma la persona. L’ultima sala ospita sedici mie fotografie di grande formato».
Ci descrive qualche immagine simbolica presente in mostra?
«Si incontra, ad esempio, uno scatto del rifugio Mandron, e un’altra con gli alberi innevati e i fili della seggiovia carichi di neve, dove si percepisce la trasformazione della montagna. Ci sono poi fotografie del periodo della Seconda guerra mondiale, quando mio nonno militava nel Battaglione Val Fassa. Una, intitolata “All’alba si avanza”, ritrae un prete che benedice i soldati prima della partenza, mentre nella successiva alcuni compagni trasportano un ferito. E c’è l’immagine famosa dello spazzacamino. Il soggetto è Serafin, lo stesso del canto popolare “Serafin l’è ’n bel moro”, che il Coro della Sat ha eseguito per anni. Un volto e una canzone che appartengono alla memoria collettiva delle valli trentine».
Ci racconta qualcosa del suo legame con il nonno? Lo ha conosciuto bene?
«Ho avuto questa fortuna perché, dopo la morte di mia nonna, è vissuto a casa nostra dalla metà degli anni Ottanta fino alla sua scomparsa, nel 1999. Con lui si parlava di musica e di fotografia, ma il tratto che mi è rimasto più impresso è il suo grande senso dell’umorismo. Raccontava spesso la prima esibizione, nel 1926, del Coro della Sat, fondato con i suoi tre fratelli e da lui diretto per cinquant’anni: si vergognava a tal punto da cantare dietro il sipario. Quando si aprì, fu una sorpresa per tutti. Crescere con lui in casa ha voluto dire entrare ogni giorno in quel modo di guardare il mondo, con la montagna vissuta con rispetto, ma anche come luogo di svago per la famiglia e gli amici».
La mostra mette in relazione due epoche. Qual è, per lei, il messaggio più urgente di questo confronto generazionale?
«Credo che il messaggio più urgente sia la necessità di preservare la montagna da un overtourism poco responsabile. Nelle mie fotografie dei ghiacciai è evidente il ritiro rispetto agli scatti del passato. Mio nonno raccontava una montagna ancora integra. Io la guardo con la stessa passione, ma con la consapevolezza di oggi, che non può ignorare la fragilità dell’ambiente. È questa differenza di sguardo che, secondo me, arriva più forte al visitatore».