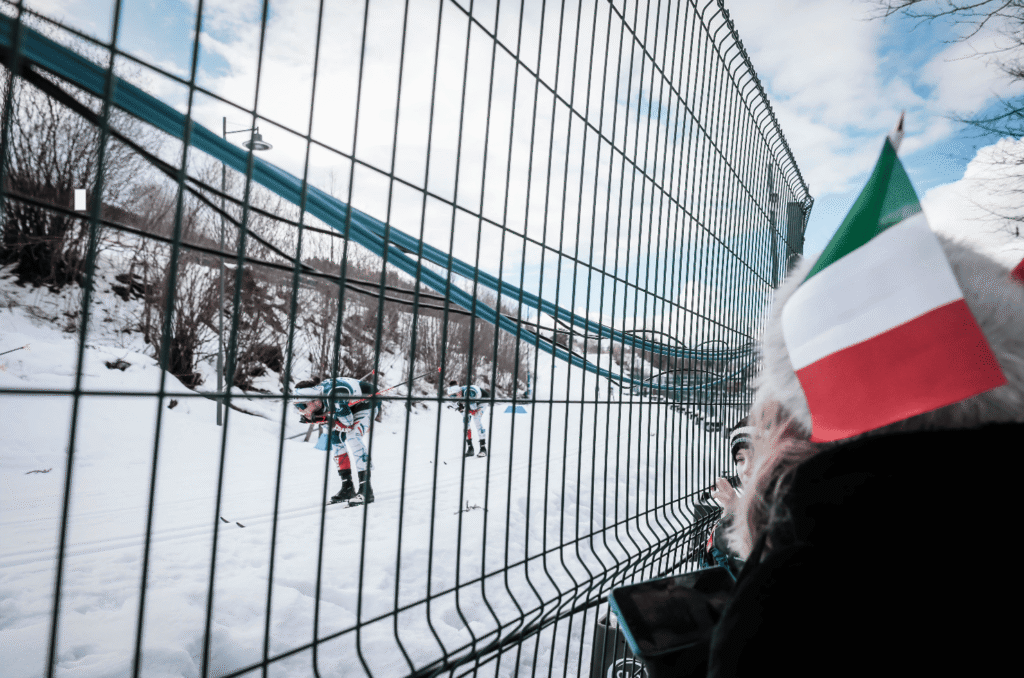La rubrica
giovedì 24 Luglio, 2025
Il rilancio (poco riuscito) di «So cosa hai fatto», le emozioni di «Sotto le foglie», il docu (che funziona) dedicato a Still I Rise: cosa c’è al cinema
di Michele Bellio
Tre pellicole selezionate e recensite e una perla da recuperare in streaming: l'intramontabile «Ciociara»

SO COSA HAI FATTO
(I Know What You Did Last Summer, USA 2025, 111 min.) Regia di Jennifer Kaytin Robinson, con Madeline Clyne, Chase Sui Wonders, Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr.

A distanza di quasi trent’anni dal primo So cosa hai fatto, arriva in sala questo tentativo di rilancio/sequel del classico teen horror anni ’90. Già all’epoca l’originale – tratto dal romanzo di Lois Duncan – non era stato accolto come un capolavoro del genere, ma aveva saputo intercettare le mode dell’horror post-Scream (con il quale condivide lo sceneggiatore, Kevin Williamson), guadagnandosi un posto d’onore nella memoria degli adolescenti dell’epoca (e nella parodia di Scary Movie, che ne utilizzava praticamente la trama come filo conduttore insieme a quella del film di Wes Craven). Questo nuovo So cosa hai fatto cerca di attualizzare quel modello, ma finisce per restituirne una versione più sbiadita e poco convincente. Paradossalmente è una battuta pronunciata da una delle protagoniste del film originale – «La nostalgia è sopravvalutata» – a sintetizzare l’inutilità dell’operazione. La tensione latita per buona parte del film, le scene horror sono dosate col contagocce e spesso mal gestite sul piano registico, con un utilizzo sorprendentemente poco efficace delle ambientazioni, che avrebbero in realtà ben altro potenziale.
Il ritmo è irregolare, i personaggi giovani appaiono poco credibili (o peggio: antipatici) e il cast originale è relegato a ruoli marginali. A questo si aggiunge una discutibile scelta narrativa: se nell’originale i protagonisti erano responsabili diretti della morte dell’uomo investito (e della successiva copertura), qui l’incidente appare quasi accidentale, con l’automobilista che esce di strada da solo. Una parziale “assoluzione” che toglie forza all’idea stessa del senso di colpa, cuore pulsante del film del ’97. Non mancano intuizioni potenzialmente interessanti: il recupero dell’ambientazione patriottico-festiva del 4 luglio (che però resta sullo sfondo senza mai diventare elemento drammaturgico), o lo slogan sulla città – «Non cercare di cambiare Newport, lascia che Newport cambi te» – che poteva avere un’eco ironica o disturbante più efficace. Discorso simile per la sottotrama sulla speculazione edilizia e la cancellazione del passato da parte di un immobiliarista miliardario: suggestione valida sulla carta, ma sviluppata in modo frettoloso e risaputo. Anche il tono vagamente femminista risulta più dichiarato che strutturato, e non basta a trasformare un thriller piuttosto scolastico in un racconto di reale rivendicazione. Lo stesso vale per l’accennata bisessualità di Ava, mai realmente integrata nella narrazione. Qualche trovata visiva si salva (come la bomba da bagno nella scena del primo omicidio), ma nel complesso il film si muove su binari già visti, senza reinventarli né omaggiarli con autentico stile. L’intreccio è prevedibile e il gioco del “chi è l’assassino” – che almeno ha coinvolto i più giovani in sala, impegnati a parteggiare per questo o quel personaggio – finisce per diventare l’unico vero elemento di partecipazione. Insomma: sia che non si conosca l’originale, sia che lo si ricordi con nostalgia, si può anche passare una serata leggera senza troppe pretese, che in fondo è l’obiettivo ultimo del film. Ma la sensazione è quella di un’occasione sprecata.
SPECIALE CINEMA CAPOVOLTO – MARTEDÌ 29 LUGLIO
SOTTO LE FOGLIE
(Quand vient l’automne, Francia 2024, 102 min.) Regia di François Ozon, con Hélène Vincent, Josiane Balasko, Ludivine Sagnier

Autore interessante, talvolta discontinuo, anche a causa della volontà coraggiosa di cimentarsi con diversi generi, Ozon è un regista che, quando trova l’equilibrio necessario, sa regalare opere struggenti e meravigliose. Così era per l’indimenticabile «Sotto la sabbia» e così accade nuovamente per questo delicato e poetico «Sotto le foglie», il cui titolo italiano rimanda furbescamente al capolavoro del 2000, ma che in originale offre con raffinatezza un riferimento alla stagione autunnale come ultima parte dell’esistenza umana. Siamo in Francia, nella campagna della Borgogna. Qui vive l’anziana Michelle, il cui passato difficile è ancora motivo di scontro con la figlia Valérie, che porta dalla nonna l’amato nipotino Lucas per le vacanze. Complice una quiche di funghi avvelenata, il rapporto fra le due donne si rompe definitivamente. Finché tempo dopo Valérie muore in circostanze poco chiare e Lucas si trasferisce a vivere dalla nonna, la quale non ha dubbi: la felicità del nipote è la vera priorità della sua vita. E qui sta il nucleo del film, che è fatto di relazioni, di promesse d’amore, di famiglie non convenzionali che permettono di ritrovare la tanto agognata felicità. Dipingendo ambientazioni e personaggi con mano degna di un grande narratore, Ozon realizza una perla di cui purtroppo in pochi si sono accorti, non comprendendo che la trama gialla legata alla morte di Valérie altro non è che un pretesto, per affrontare, soprattutto in un delicato e poetico finale, un bisogno di riconciliazione, di serenità. Per questo alcuni passaggi apparentemente poco verosimili sono in realtà il timbro del regista, che ci guida per ellissi e non detti a concentraci su ciò che conta realmente. E se ci si affida il risultato è davvero emozionante.
EVENTO SPECIALE
SCHOOL OF LIFE
(Italia 2025, 87 min.) Regia di Giuseppe Marco Albano, con Nicolò Govoni
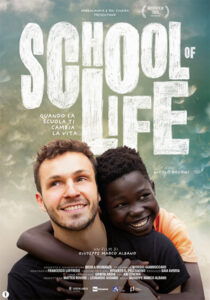
Realizzare un documentario sull’attività benefica di un’organizzazione senza cadere nella retorica o nell’agiografia è sempre un’impresa difficile. School of Life riesce piuttosto abilmente a evitarne le insidie raccontando la nascita e la crescita di Still I Rise, organizzazione fondata nel 2018 da Nicolò Govoni, oggi trentaduenne, originario di Cremona. Attraverso materiali d’archivio – forniti dalla stessa associazione e dal protagonista – e riprese girate ad hoc in Kenya, India, Colombia, Grecia e Italia, il film restituisce il ritratto sfaccettato di un giovane che, dopo due bocciature, faticava a trovare un posto nel nostro sistema scolastico e che si definiva «quel ragazzo che non vorresti mai far frequentare a tuo figlio». A 19 anni sceglie di partire per l’India, per un’esperienza di volontariato che avrebbe dovuto durare tre mesi, ma che si trasforma in quattro anni fondamentali. Poi arriva l’impatto con la drammatica realtà del campo per rifugiati di Samos, in Grecia, dove prende forma il progetto di una scuola gratuita per i minori più vulnerabili. Da lì in avanti, Still I Rise cresce tra mille difficoltà, costruendo scuole nei luoghi più dimenticati e pericolosi del mondo: dal quartiere più povero di Nairobi alla Repubblica Democratica del Congo, dallo Yemen alla Colombia. Ogni scuola si prende cura dell’infanzia abbandonata, offrendo un’istruzione di alta qualità fondata sull’International Baccalaureate, accessibile gratuitamente e sostenuta quasi esclusivamente da donazioni private. Un progetto unico nel suo genere, capace di offrire una visione concreta di futuro.
Il documentario sceglie consapevolmente di concentrarsi sulla figura del fondatore, e proprio qui trova uno dei suoi punti di forza: Nicolò Govoni non è tendenzialmente idealizzato oltre il necessario. Se i familiari oscillano tra l’orgoglio e la preoccupazione (ed è emblematico il fratello che scherza sulla sua “percentuale di stronzaggine”), altre testimonianze restituiscono un ritratto più complesso. C’è chi inizialmente lo ha scambiato per il classico figlio di papà con il mito del volontariato, per poi ricredersi di fronte alla determinazione con cui affronta le sfide. E poi c’è lui stesso, con le sue ansie, i momenti di rabbia, la frustrazione per i progetti che non decollano, la fatica fisica e mentale. Questo rende il film credibile e umano, e fa emergere con forza la sincerità dei valori che Still I Rise difende. School of Life è un film semplice, con qualche ingenuità nelle scene più costruite, ma potente nelle testimonianze dirette degli studenti, nei momenti in cui si percepisce il cambiamento concreto portato da una rete educativa pensata davvero per e con i più fragili. Un progetto candidato al Nobel per la Pace, che ha già coinvolto migliaia di persone. Da vedere, se non altro per conoscere una realtà affascinante che – come dimostrano le sale piene e gli applausi convinti in tutta Italia – sa anche parlare al proprio pubblico.
STREAMING – PERLE DA RECUPERARE
LA CIOCIARA
DISPONIBILE SU RAIPLAY
(Italia/Francia 1960, 100 min.) Regia di Vittorio De Sica, con Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo
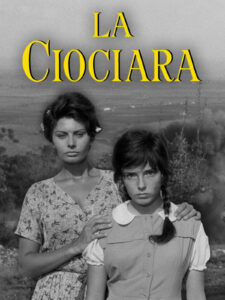
Un doppio traguardo storico ci impone di recuperare un titolo significativo della nostra cinematografia, uscito 65 anni fa e in grado di far vincere a Sophia Loren, che oggi ha 90 anni, il premio Oscar come miglior attrice protagonista. Tratto dall’omonimo romanzo di Alberto Moravia, il film è ambientato sul finire della Seconda Guerra Mondiale, nell’estate del 1943. Cesira è una giovane vedova che vive a Roma con la figlia dodicenne, Rosetta. Per scampare ai bombardamenti, e dopo non poche difficoltà, le due donne si allontanano dalla città, sistemandosi nei pressi di Fondi.
Qui Cesira s’innamora ricambiata di un giovane intellettuale antifascista, che viene però sequestrato come guida da un gruppo di soldati tedeschi. Con l’arrivo degli Alleati, Cesira sceglie di far ritorno a Roma, ma per lei e la figlia le disavventure non sono purtroppo finite, e la guerra si rivelerà in tutta la sua crudele tragicità. A firmare la regia è il grande Vittorio De Sica, che affida la sceneggiatura a Cesare Zavattini. Due fra i padri del neorealismo cinematografico affrontano questa volta un progetto produttivamente più elaborato e commercialmente ambizioso, riuscendo comunque a coniugare una profonda sensibilità per i personaggi e un lirismo che si fa via via sempre più cupo, fino al durissimo epilogo. La ciociara è uno di quei film capaci di fondere la Storia con le storie, facendo emergere la dimensione più intima e drammatica di un evento collettivo. L’interpretazione di Sophia Loren è ciò su cui è costruito il film: corpo materno, voce ferma, occhi che sanno essere duri e liquidi nel giro di pochi istanti.
A distanza di decenni la sua performance continua ad emozionare. La grandezza del film, però, sta anche nel modo in cui riesce a parlare di trauma. La violenza, che giunge improvvisa e brutale in una delle sequenze più tragiche del nostro cinema, non è compiaciuta: è una ferita inferta allo spettatore, uno schiaffo morale che ci costringe a fare i conti con l’orrore del conflitto e con la perdita dell’innocenza. Rosetta non è più solo una figlia da proteggere, ma una presenza che testimonia la crudeltà del mondo adulto. E Cesira, da madre forte e risoluta, si ritrova impotente di fronte a una realtà che la supera, nella quale l’amore e la speranza sembrano non bastare più. Da rivedere.
La storia
Il sogno olimpico della Nta Dance School: «Siamo partiti dai piccoli paesi per arrivare a San Siro»
di Adele Oriana Orlando
Tra rigidi protocolli di sicurezza e dieci giorni di prove blindate, tre allievi della scuola di Trento sono stati protagonisti della cerimonia a San Siro. La direttrice Giulia Primon rivela i segreti del Villaggio della Cerimonia
Spettacoli
Anche la Nta Dance School di Trento alle Olimpiadi: danzatrici e danzatori alla cerimonia inaugurale di Milano-Cortina 2026
di Adele Oriana Orlando
I danzatori dell'accademia trentina selezionati per i Giochi. La direttrice Giulia Primon: «Questo traguardo non è solo un riconoscimento del talento individuale, ma del percorso formativo e artistico condiviso dalla nostra scuola che investe nella crescita dei ragazzi»
La rubrica
Weekend di spettacoli in Trentino: da Jerry Calà a The Wall, tutti gli appuntamenti
di Jessica Pellegrino
Cresce l'attesa per il fine settimana culturale tra Trento, Rovereto e Cavalese: tra la comicità dei grandi monologhi, la sperimentazione di Rezza e Mastrella e la danza tributo ai Pink Floyd, ecco la guida agli eventi da non perdere