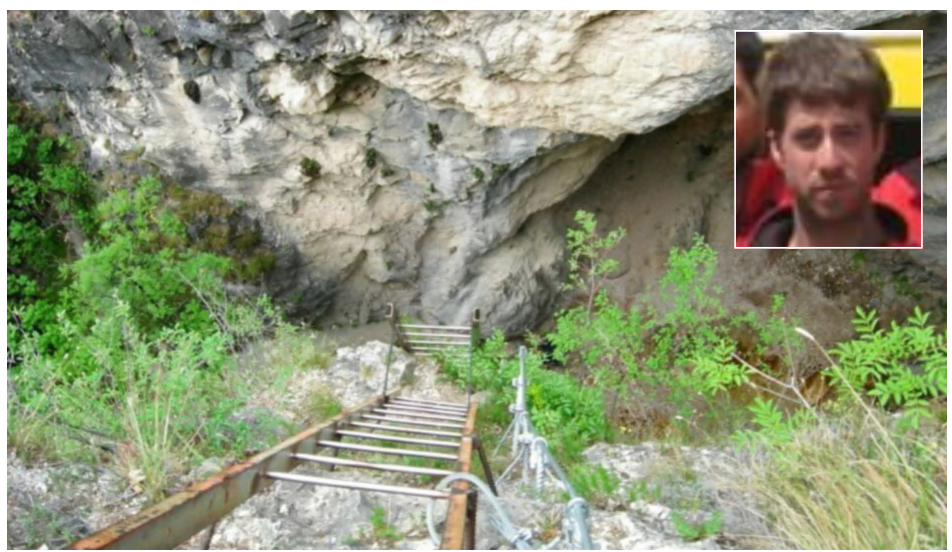L'editoriale
sabato 20 Settembre, 2025
Il nuovo esame di maturità
di Maria Prodi*
Un cambiamento che pone molti interrogativi (e che si presta a qualche trucco)

Le classi all’ultimo anno di scuola superiore e i loro professori stanno cercando di prendere le misure dell’anno appena iniziato, e soprattutto dell’evento conclusivo, l’esame. Come sarà questa nuova maturità? Al di là delle dichiarazioni e delle intenzioni, come funzionerà in concreto? L’aspetto più eclatante è la riduzione a sole quattro discipline da preparare per il colloquio. Ma sarà un semplice ridimensionamento quantitativo dei costi che il ministero paga per i commissari e dell’impegno di studio degli studenti o avrà anche un impatto qualitativo sulla natura dell’esame? La prima osservazione è che ci saranno quattro commissari, due interni e due esterni. Quelli esterni (che prima erano tre) sono sempre stati assegnati alle scuole dal ministero, che contestualmente fissava le materie a questi affidate in sede di esame orale.
Quelli interni, e quindi le loro materie, venivano scelti dal consiglio di classe, in base a considerazioni didattiche, ma anche tenendo presenti possibili motivi di esonero (non è obbligato a fare da commissario chi è part-time, chi è supplente momentaneo, chi ha la 104…) o incompatibilità (un insegnante che ha più di due quinte classi non può essere presente in tutte).
Adesso il ministro fisserà tutte le quattro materie e quindi non determinerà solo i membri esterni, ma anche quelli interni. Cosa succederà se in una classe per un membro interno o per tutti e due sarà possibile l’esonero dagli esami? Verranno sostituiti; quindi saranno «esterni» anche loro, cosa che renderà poco equa la situazione di quella classe rispetto a quella di coloro che invece avranno davanti persone che li conoscono e da cui sono conosciuti.
Fra i magnifici quattro certamente un commissario sarà di italiano, dovendo esserci almeno qualcuno che corregga la prima prova. Il secondo commissario sarà certamente quello relativo alla seconda prova scritta: latino o greco per il classico, matematica e/o fisica per lo scientifico, eccetera. Non è ovvio che all’orale tale commissario possa interrogare su una seconda materia, dipende dalla sua abilitazione (qualcuno insegna latino, ma non greco, qualcuno matematica ma non fisica ecc…). Potrebbe quindi essere la stessa materia dello scritto. Restano due discipline, una affidata ad un interno e una ad un esterno.
Le materie comunque, oltre a essere in buona parte prevedibili, verranno annunciate a gennaio: la tendenza a lasciar perdere le discipline non coinvolte nell’esame, se non sostenute da un insegnante irresistibilmente attrattivo, sarà altamente diffusa. Tanto varrebbe rivedere completamente la portata dell’ultimo anno concentrandolo solo su poche materie. Che ruolo avranno i consigli di classe di una dozzina di docenti, se a giocare in campo poi saranno solo quattro materie? Ci saranno insegnanti-spettatori umiliati per la loro irrilevanza? Una conseguenza potrebbe essere lo spostamento sullo scrutinio finale del compito di verifica decisiva degli esiti dell’anno scolastico, lasciando all’esame solo la funzione cerimoniale di rito, coronato di fiori e bollicine, come usa adesso.
La modalità del colloquio sarà diversa: sparisce il materiale tematico che faceva da fil rouge per l’esposizione. Sparisce proprio l’esposizione: il colloquio deve «verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale», ma si presenta più come una interrogazione materia per materia che come una presentazione strutturata in autonomia dal candidato. Insomma, dovrà valutare la maturità, ma non permetterà che a guidare il tragitto sia lo studente. Per molti insegnanti sarà l’agognato ritorno alla comfort zone in cui loro domandano e gli studenti rispondono. Quindi non un anticipo di quello che si farà nella vita e nelle professioni (relazioni, esposizioni, presentazioni, stesura di documenti), ma una apoteosi della classica interrogazione scolastica, a domanda risposta.
La formula precedente, consistente in un excursus fra diverse materie guidati da un tema o soggetto, non era perfetta: mentre per alcuni studenti brillanti il colloquio come si è svolto fin’ora era l’occasione per dimostrare capacità espositive e di sintesi, per gli studenti meno autonomi poteva ingenerare accostamenti e associazioni di idee decisamente improbabili, e il rischio della genericità e della scarsa messa a fuoco era sempre in agguato. Ma speriamo che i docenti non tornino alla interrogazione in stile rischiatutto e che permettano agli studenti di dimostrarla, quella maturità che sarà citata nel loro diploma.
Quanto alla proibizione di fare scena muta al colloquio, che ha surclassato nelle dichiarazione del ministro e nell’attenzione dell’opinione pubblica una tale drastica riforma dell’esame, prevedo che, una volta dimostrato che il megafono delle news non si sottrae a chi vuol far parlare di sé o dei suoi argomenti con proteste irrituali, la rincorsa a proibire finisca per sollecitare solo la messa in campo di nuove trovate. Vedremo se invece della scena muta si scoveranno altri modi legalmente consentiti per boicottare l’esame. Non me lo auguro, e non per lesa maestà. Ma perché l’occasione di esporre il proprio pensiero, pur limitato dalla struttura dell’interrogazione, non va mai persa e anche perché ci sono un’enorme quantità di ingiustizie da far emergere dall’indifferenza e da contestare, prima dell’esame di stato.
*Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo del Primiero
L'editoriale
Una comunità basata sulla cura
di Gianluca Salvatori
Ci troviamo a fare i conti con la crescita della domanda di assistenza di lungo periodo, la persistente carenza di personale sanitario e sociosanitario, e l’aumento dei costi pubblici e privati per le cure. Tutto ciò in un contesto di profonde disuguaglianze territoriali