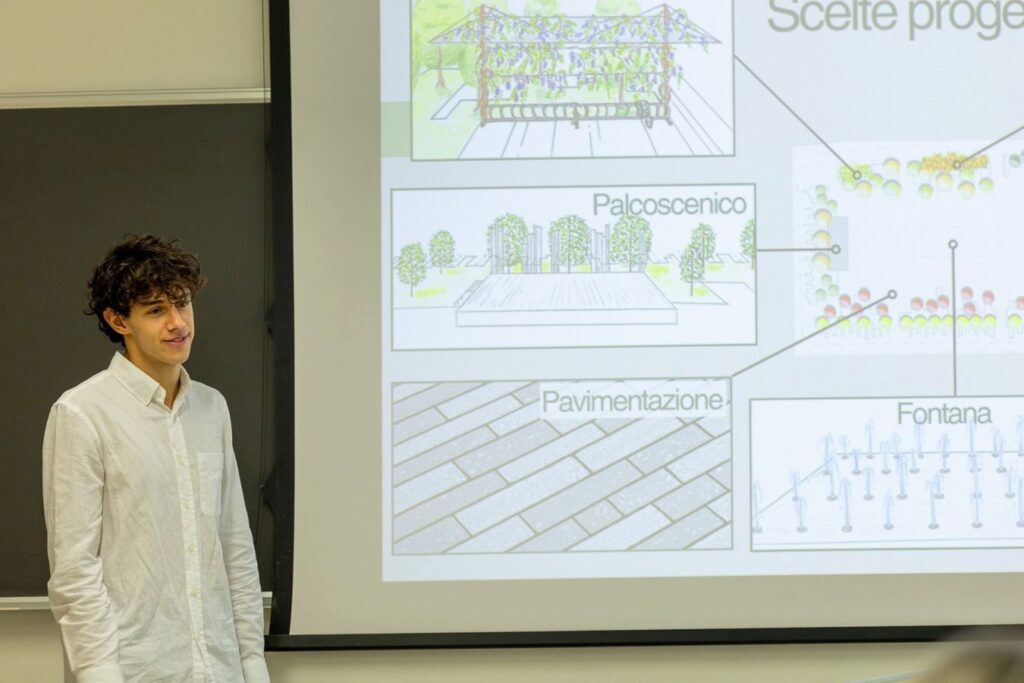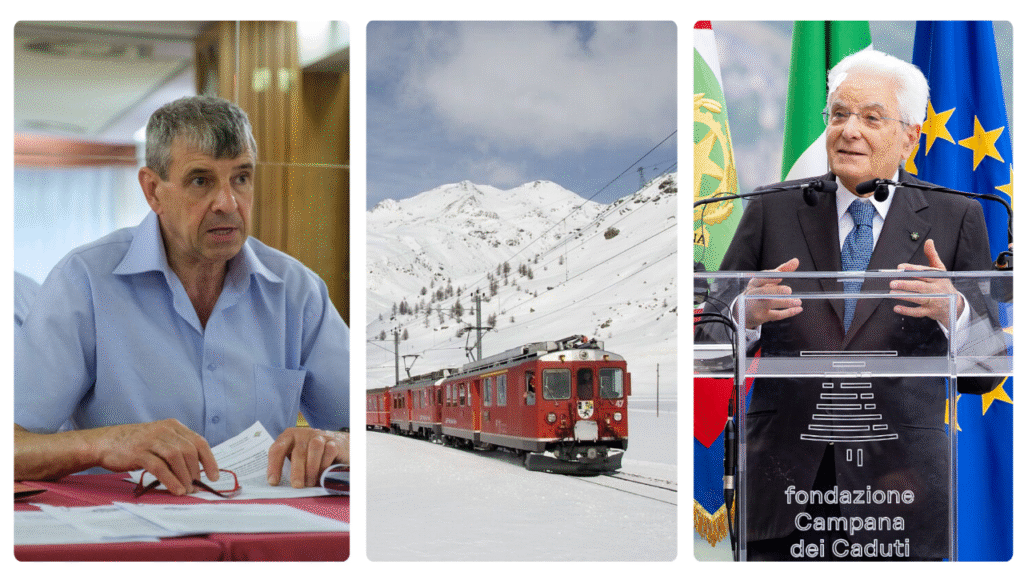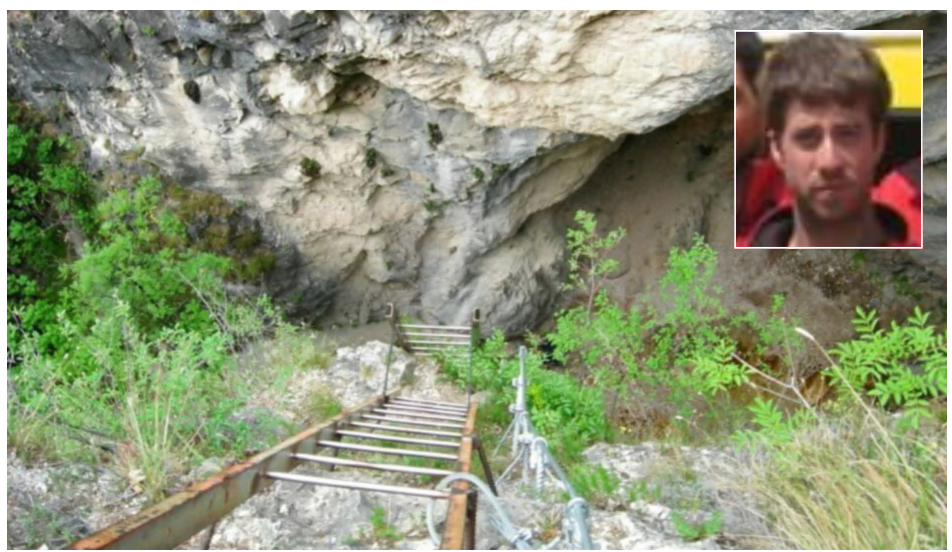Terra madre
venerdì 7 Novembre, 2025
«Il codice del bosco», il documentario che racconta il Paneveggio dopo Vaia e gli «alberi che parlano»
di Manuela Crepaz
La storia di un progetto scientifico che ha captato i segnali elettrici delle piante minacciate dal bostrico

Non è fantascienza: le piante comunicano davvero. Lo dimostra «Il codice del bosco», documentario di Alessandro Bernard e Paolo Ceretto che sarà proposto dal gruppo DonseNaMan domani sera (sabato 8 novembre) alle 21 al centro civico di Mezzano, alla presenza dell’ecologa Monica Gagliano, pioniera della bioacustica vegetale e docente alla Southern Cross University in Australia. Protagonista assieme al fisico Alessandro Chiolerio, Gagliano ha aperto un nuovo campo di ricerca dimostrando sperimentalmente che le piante emettono proprie voci e reagiscono ai suoni dell’ambiente. Con un approccio che intreccia scienza e filosofia, ecologia e arti, diritto e saggezza indigena, Gagliano invita a riscoprire il senso di meraviglia per il pianeta, immaginando una nuova «ecologia della mente» e un modo più armonioso di coabitare con la natura. Il film traduce questa visione in immagini, conducendo lo spettatore in un viaggio ipnotico e visionario nel cuore del bosco di Paneveggio, tra la Val di Fiemme e il Primiero. La narrazione segue i due scienziati nel cuore di una foresta devastata da Vaia e minacciata dal bostrico, alla ricerca di un nuovo linguaggio capace di dialogare con la vita che li circonda. Chiolerio, scienziato visionario che unisce ricerca e intuizione poetica, ha installato nel bosco i cybertree, dispositivi da lui ideati per captare i segnali elettrici delle piante: una chimera che fonde biologia e tecnologia, avvicinando la possibilità di una comunicazione interspecie. Al suo fianco, Monica Gagliano dimostra che la natura parla, se la si sa ascoltare. Ma mentre i due studiosi tentano di entrare in contatto con la foresta, un altro linguaggio si manifesta: quello dell’Ips typographus, il temuto bostrico, minuscolo insetto che, scavando sotto la corteccia degli alberi, incide segni intricati simili a geroglifici. È l’enigma che attraversa tutto il film: la natura sembra voler comunicare e l’uomo deve imparare di nuovo a comprenderla. Abbiamo voluto intervistare gli autori Alessandro Bernard e Paolo Ceretto.
Il film è frutto di un lavoro durato quattro anni. Qual è stata la difficoltà più grande nel lavorare in una foresta viva?
«Le difficoltà a girare a quasi 2000 metri sono state molte, anche se non le abbiamo mai davvero viste come difficoltà. Il film partiva dall’idea di raccontare la scienza che esce dai laboratori e si confronta con la complessità della natura. E la complessità della natura è fatta di pioggia, vento, cambi repentini. La pioggia si sostituiva ai nostri piani di produzione e decideva al posto nostro i ritmi della giornata. All’inizio cerchi di trovare soluzioni, ti incaponisci, ma poi lentamente capisci e ti fai guidare. E oggi possiamo dire che la pioggia, ad esempio, ha cadenzato non solo le riprese, ma anche il ritmo, il respiro del film».
L’esperimento di Chiolerio ha una forte componente tecnologica, fatta di sensori, dati e dispositivi complessi. Come avete tradotto tutto questo sul piano visivo, senza perdere il fascino del mistero?
«Questa volta cavi e computer erano collegati a un bosco, erano l’interfaccia con cui tentare il dialogo. Il mistero, il fascino, ma anche il cambio di paradigma, era lì. Passare dall’idea di una tecnologia che ci porta a immaginare scenari distonici, post umani, a una tecnologia che prova a riconnetterci alla natura».
Avete lavorato accanto a scienziati abituati a un linguaggio razionale, lineare, mentre il cinema vive di intuizioni, ritmo, suggestione. È stato difficile far convivere questi due modi di pensare?
«Anche questo è stato un percorso naturale, perché alla fine la scienza in qualche modo si è aperta all’irrazionale, all’intuizione, ricordandoci che la razionalità non è l’unica strada possibile per la scoperta, anche scientifica. In fondo, il documentario è sempre il punto d’incontro, il dialogo, tra quello che tu ti immagini nella tua testa e quello che la realtà offre, e da questo punto di vista la scienza, quella che parte senza preconcetti o tesi prestabilite, non è molto diversa».
A un certo punto del film, il confine tra osservatore e osservato si dissolve. Come si gestisce, da registi, questo momento in cui si smette di riprendere e si inizia a partecipare?
«È stato il tempo passato lì che ci ha permesso di fare questo passaggio. Ma anche il tempo trascorso tra una sessione di riprese e l’altra dove trovi lo spazio di rivedere le tue posizioni, cambiare idea, spostare il focus. In questo film sicuramente la partecipazione è stata maggiore rispetto ad altri che abbiamo fatto. È stato un film, ma anche un’esperienza trasformativa».
C’è stato un momento durante le riprese in cui l’imprevisto ha cambiato completamente la direzione del progetto?
«Il film voleva raccontare la scienza senza ricercare l’effetto wow, ma nella sua dimensione quotidiana. Fatta di attesa, ritualità, routine, anche noia. In questo, il ritmo ciclico del bosco ha aiutato e ha dato molto al ritmo del racconto. E l’imprevisto è arrivato da lì, dal bosco stesso, sotto forma di un piccolo insetto che si è insinuato lentamente nel racconto: il bostrico. Alla fine, il senso del film ce lo ha portato l’insetto che ci ricorda una cosa tutto sommato semplice: che di fronte alla complessità della natura noi umani siamo piccolissimi».
Il film alterna momenti di osservazione lenta a immagini potenti, quasi metafisiche. Come avete costruito il ritmo, la colonna sonora del silenzio, per restituire l’intelligenza del bosco?
«Ascoltando i suoni di quel bosco. Abbiamo anche messo microfoni sottoterra, sotto le cortecce per provare a capire cosa si sentisse da quello che chiamavamo il sopra sotto. La musica invece doveva rispecchiare lo spirito del film che unisce scienza, tecnologia, natura, folklore e pratiche antiche».
Pensate che il cinema possa essere uno strumento capace di rendere visibili queste connessioni invisibili meglio dei linguaggi scientifici tradizionali?
«Di sicuro oggi la distanza tra le conoscenze di chi lavora nel campo scientifico e il resto della società è sempre più profonda. Le scoperte scientifiche mettono in discussione il principio e la percezione stessa che abbiamo della realtà, ma non si riflettono in alcun modo nelle nostre vite, non hanno plasmato immaginari nuovi, o almeno non abbastanza. Il compito del cinema è provare a colmare questo divario».
Dopo aver trascorso anni dentro un ecosistema, in che modo questa esperienza ha cambiato il vostro modo personale di guardare la natura e di fare cinema?
«Più che guardare la natura, forse questa esperienza ci ha insegnato ad ascoltarla. Viviamo nella società delle immagini convinti che guardare sia l’esperienza più arricchente, ma se vuoi capire davvero il mondo della natura, o almeno provare a costruire un legame, un dialogo, guardare non basta».