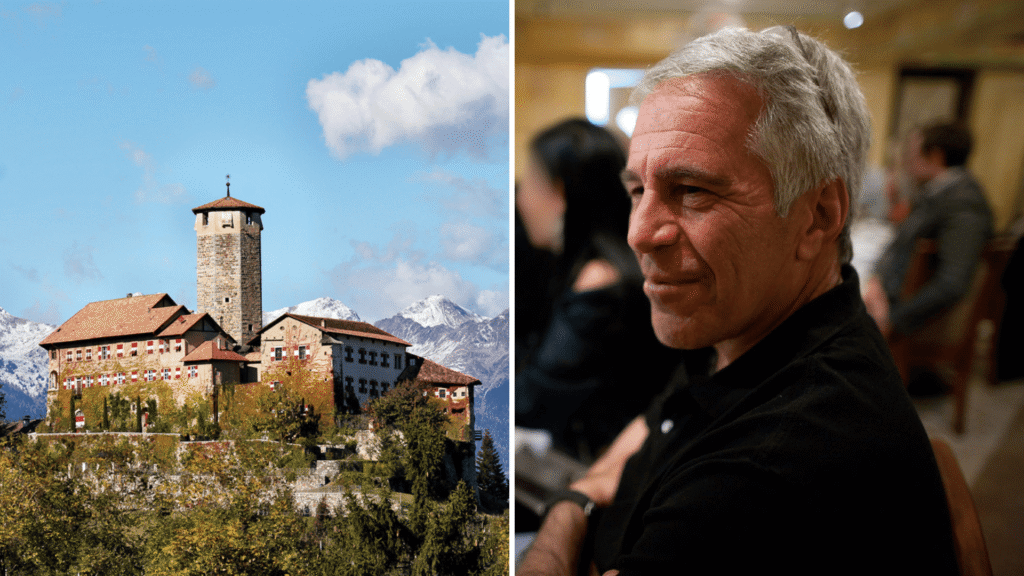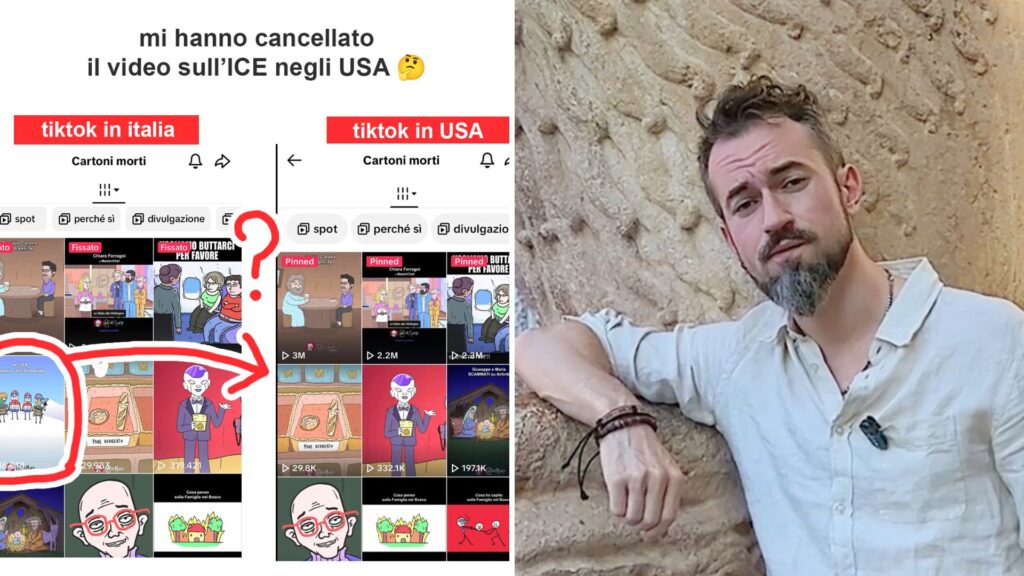Campi Liberi
martedì 5 Agosto, 2025
«Ho visto cadere il muro di Berlino: ero di guardia e avevo un AK 74»
di Mattia Eccheli
Il racconto di Andreas Beil, oggi fotografo affermato con un passato nella Stasi: «Non tornerei indietro, ma la mia gioventù è stata felice»

Indossava l’uniforme quella sera del 9 novembre del 1989 perché era di guardia, come sempre, a uno degli edifici governativi della DDR, la Deutsche Democratische Republik, la Germania dell’est. Aveva studiato come installatore di impianti in acciaio e completato anche il ciclo di apprendistato, alternando per un paio di anni una settimana di scuola a due di lavoro. Poi la leva obbligatoria, che all’epoca durava un anno e mezzo, ma lui aveva firmato per tre: un impegno che garantiva uno stipendio più alto e qualche certezza in più per il futuro, inclusa la precedenza per l’assegnazione di un’abitazione.
Dall’uniforme alle foto
Indossava l’uniforme, come i suoi altri tre colleghi, ed era armato: in dotazione aveva un AK 74, il Kalashnikov, e tre caricatori. Sfidando le leggi dell’epoca, soprattutto in un reparto che faceva parte della Stasi, l’onnipresente servizio segreto dello stato comunista, uno aveva sintonizzato la radio su una stazione di Berlino ovest: «Ma noi non avevamo il distintivo speciale e, del resto, non c’erano solo spie, ma anche soldati come noi, cuochi e via elencando». Nel giorno che ha cambiato la storia, Andreas Beil, classe ’68, nato in un paesino vicino a Lipsia e oggi affermato fotografo che gira per il mondo vendendo scatti che riguardano il motorsport, a cominciare dalla Formula 1 (tra le sue immagini più famose c’è quella di Michael Schumacher mentre arrampica nello Utah), era in servizio.
Senza armi
«La nostra fortuna – ricorda – è stata quella di avere un superiore intelligente. Quando già le auto cominciavano a transitare lungo corso Varsavia, lui ci disse di aspettare il cambio del turno e poi di uscire, disarmati». Un’idea saggia: «Nella DDR la gente portava rispetto alla divisa – aggiunge – ma quel giorno non era chiaro cosa sarebbe potuto succedere. E io avevo detto subito: “Non esco con un AK 47 con centoventi colpi”». «Quello che mi ha impressionato – riflette oggi a 36 anni di distanza dalla caduta del muro, ma anche a 64 dall’inizio della sua costruzione, ossia il 13 agosto del 1961 – è la velocità con la quale uno stato così strutturato sia letteralmente imploso». Nel giro di meno di due settimane il suo reparto era già stato sciolto e nessuno offriva più un lavoro perché nessuno sapeva cosa sarebbe successo.
Vita da «ossi»
Il paese è franato. In gennaio Beil se n’era già andato al porto di Brema, nell’“altra” Germania, a 400 chilometri di distanza. Ci è rimasto due anni: «Facevo il lavoro per il quale avevo studiato – aggiunge – ma non mi piacevano né quello né l’accondiscendenza con cui venivo trattato. Ero un “ossi”, che immagino sia l’equivalente di “terroni” con i quali per gli italiani del nord definiscono quelli del sud: ero considerato un tedesco di serie “b”». La nuova vita è cominciata allora, perché quella precedente era stata completamente diversa, anche da come gli occidentali l’hanno sempre sentita raccontare: «Ho avuto una gioventù felice – garantisce – da piccolo non ti fai molte domande sulla libertà e tutto il resto. Ma io ho avuto quello che uno pensa di volere quando è adolescente. Ho anche viaggiato, naturalmente solo nei paesi orientali: Cecoslovacchia, Polonia, Ungheria. Non sono mai stato in Russia, però sono cresciuto con i programmi della televisione dell’ovest».
«Gli elettori di Afd? Tedeschi dell’est che non si sono adattati»
Beil racconta che l’Occidente non era un tabù nemmeno a scuola: in classe veniva spiegato che con il capitalismo c’erano più cose, ma che non tutti stavano bene: «Nella DDR la povertà non esisteva – continua – non c’erano mendicanti, accattoni e senzatetto. Tutti beneficiavano dell’assistenza sanitaria e tutti avevano una casa e un lavoro. Per venire licenziato dovevi praticamente ammazzare qualcuno. Mi rendevo conto che oltrecortina c’erano più auto, c’erano più beni alimentari e, in generale, c’era più scelta». Quel retaggio culturale ha segnato generazioni di tedeschi: «Quelli che oggi votano Alternative für Deutschland – insiste – sono quelli che non sono riusciti ad adattarsi. Sono quelli che non hanno saputo vedere le grandi opportunità che si aprivano». L’esempio che cita è quasi disarmante: «Non tornerei mai indietro. Mai – anticipa – I motori e la fotografia sono sempre state le mie passioni, ma ho sempre pensato che non avrei mai potuto fare l’ingegnere in una scuderia, perché all’Ovest avrebbero preso solo gli eccellenti, che in qualche modo si dovesse essere “migliori”. Con tutto il dovuto rispetto, ho capito che non è così. Basta aver voglia di imparare». E Beil lo ha fatto: grazie agli incentivi per la, come dire, “conversione professionale” introdotta con l’unificazione, ha studiato come maneggiare un obiettivo ed è finito a immortalare le gare automobilistiche: è già stato 18 volte in Australia, 6 in Nuova Zelanda e dei viaggi negli Stati Uniti ha perso il conto. «Ho fatto delle mie passioni il mio lavoro», sorride. Le geometrie dei suoi scatti sono impresssionanti: in qualche modo riesce ad animare gli edifici e perfino i bolidi che fotografa, sempre pronto anche a vedere chi parla con chi e, magari, anche a intercettare quello che viene detto.
Una Trabant e una Lada
Il padre era capo ingegnere della squadre di manutenzione delle macchine per la lavorazione del carbone e, a un certo punto, ha avuto anche un ruolo nel partito, ma la famiglia non era privilegiata per quello: «Con un fratello maggiore e una sorella minore, eravamo un nucleo modello – precisa -Di quelle che ottenevano sempre un posto al campeggio. Anche per questo ho potuto fare quello che ogni giovane sognava di fare, naturalmente commisurato a quello che potevi fare nella DDR. Scappare? Avrei potuto, ma farlo avrebbe significato far condannare tutta la mia famiglia. Non ne valeva la pena». Seppur usate, in casa c’erano state prima una Trabant e poi una più “lussuosa”, la Lada. Beil dice che i segni del malcontento e dell’insofferenza erano sempre più evidenti prima della caduta del Muro: «Qualcosa era nell’aria perché la propaganda occidentale si avvertiva: era più forte e insistente. E poi cominciavano a mancare pezzi di ricambio, c’era sempre meno disponibilità nei supermercati e cose del genere, anche se personalmente, in caserma, non me ne accorgevo». «All’inizio quasi non ci credevamo, noi quattro, davanti al palazzo che stavano sorvegliando – prosegue – affinché nessuno entrasse: ma da lì la gente voleva andar via. Poi è risultato chiaro: era la notte della fine della DDR».
«Cittadini ancora esclusi»
A anni distanza, la Germania è ancora quasi solo formalmente una sola: nelle cinque “nuove regioni” (i cosiddetti “neuen Länder“, ossia Brandeburgo, Meclemburgo-Vorpommern, Sassonia, Sachsen-Anhalt e Turingia) i salari sono ancora del 20% più bassi rispetto all’ovest, ad eccezione che nella pubblica amministrazione. Anche le pensioni sono più basse, ma le differenze dipendono anche da zona e zona. Una sola università della Germania ha un rettore che arriva dall’est e nessuno degli amministratori delegati delle aziende quotate al Dax di Francoforte viene da quelle regioni. Anche per questo la AfD raccoglie voti su voti, un’onda nera xenofoba e insofferente la cui “pancia” non viene più intercettata dai partiti tradizionali. Dalle parole di Beil, che è tutt’altro che un nostalgico, emerge una bocciatura morale per l’Occidente: «Quelli bravi nella ex DDR hanno dimostrato di esserlo anche nella Germania unificata – conclude – Io però all’epoca credevo che le relazioni fossero importanti solo nel paese in cui sono nato, in una sorta di logica del baratto, di economia parallela e sommersa. Poi mi sono reso conto che all’Ovest era peggio, solo su un altro livello. Non mi piace questa società del marketing e dei social media: è quello che rappresenta l’Occidente, dove vedi tutto a colori, prima di scoprire che stai guardando la facciata. All’est era tutto grigio fuori, ma dietro quella tinta c’era più umanità». L’ex installatore oggi fotografo, però, non ha il minimo dubbio: «Indietro non torno». Si è abituato all’apparenza, provando a mantenere la sostanza. E non è così arrogante da sostenere di esserci completamente riuscito.