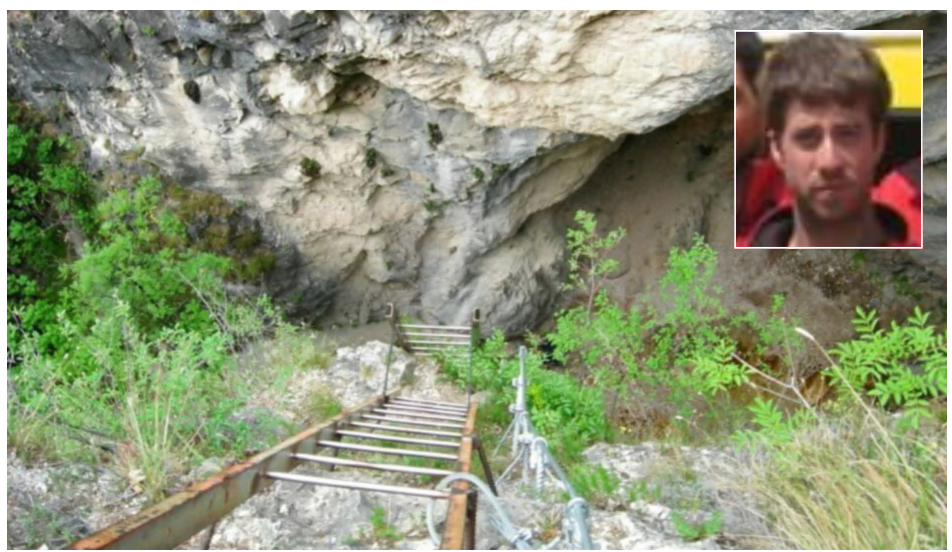l'edioriale
giovedì 20 Novembre, 2025
Giovani e disagio, la fatica di crescere
di Maria Prodi
Difficile per gli adulti capirli, perché per insinuarsi nella dimensione di queste vite dovrebbero abbandonare le proprie coordinate e infilarsi nelle bolle social in cui si si dipanano esistenze sbilanciate fra il reale ed il virtuale

Jessica non esce di casa da mesi, ha una intensa attività su Instagram, si interessa alla causa di Gaza, legge molti fantasy, a volte si mette la tuta e apre la finestra sul balcone. Ma non scende fino al portone di casa. Marco gioca tantissimo online, comunica in inglese con ragazzi di mezzo mondo, le ore notturne passano così, piene di adrenalina. È alla mattina che per lui il mondo diventa noioso e lento, la classe è un luogo opaco e insignificante dove muore di sonno. Romina ha una sorella bravissima, che infila un esame dopo l’altro a giurisprudenza. Lei non sa cosa fare, non ha nessuna specialità, nessun interesse. Oscilla fra la sufficienza scarsa e l’insufficienza, non si sente bella anche se non è brutta, non sa mai cosa dire ai suoi compagni e pensa di non avere amici. Invidia tutte quelle meravigliose influencer su TikTok, ma sa che non sarà mai come loro e ne è costantemente umiliata. Chiara prende, appena arrivata a scuola, un cappuccino dalla macchinetta. Tutta la mattinata il bicchiere starà sul suo banco. Lei ogni tanto metterà in bocca lo stecchino di legno, poi a fine scuola butterà via tutto. Il suo pranzo sarà un pomodoro scondito, a cena una costa di sedano e qualche patatina fritta, contandone le calorie e postandole sulla chat delle digiunatrici.
Difficile per gli adulti capirli, perché per insinuarsi nella dimensione di queste vite dovrebbero abbandonare le proprie coordinate e infilarsi nelle bolle social in cui si si dipanano esistenze sbilanciate fra il reale ed il virtuale. E perché quando tutti si spostano sul virtuale è il reale che diventa virtuale.
Dove stanno i ragazzi che occupano i banchi di scuola, che si siedono a cena in famiglia, che si posano a gruppi sulle panchine con gli occhi sul proprio cellulare? In quale dimensione pensano, sognano, si immaginano loro stessi, cercano conforto?
Se i compiti di crescita consistono nel rafforzamento dell’autonomia, consapevolezza di sé, solidità nel consegnarsi la propria identità, resistenza rispetto ai condizionamenti esterni, capacità di assumersi responsabilità verso il mondo, e mantenerne fedelmente la barra, allora le prove contro questa generazione fragile si accumulano. Sono estemporanei, non mantengono gli impegni presi, faticano a leggere un testo, non sanno incassare le sconfitte. Se poi il compito di crescita è raggiungere una felicità nutrita dalla piena realizzazione dei sentimenti amorosi e da una gratificante operosità la meta si fa ancora più difficile da immaginare.
Nelle fiabe i passaggi di iniziazione alla maturità sono rappresentati da prove iterate e faticose. Il protagonista affronta peripezie e sopporta estenuanti prove e solo superando queste sfide riesce a raggiungere uno stato di piena soddisfazione conquistando il lieto fine (generalmente un matrimonio, ma può essere anche il trono o un tesoro).
Non avendo da proporre nessun lieto fine gioioso e duraturo, facciamo fatica a imporre prove faticose ai nostri ragazzi. Di quale felicità siamo testimoni, quale appagante conquista di maturità e pienezza rappresenta la generazione dei genitori? Quali promesse di futuro compongono l’orizzonte verso cui dovrebbe rivolgersi la generazione in formazione? Basta condividere con loro una discreto livello di consumi o, come capita sempre più spesso, la frustrazione per una società dei consumi che dai beni anche essenziali esclude sempre più persone?
Gli insegnanti si barcamenano: scrivono nei consigli di classe documenti i cui acronimi corrispondono a termini burocratici che non ricordano, mettono in atto strumenti e misure, e così si cautelano. A
lcuni sono comprensivi e caratterialmente inclusivi, altri sono disturbati da queste vulnerabilità ed esigono che la scuola torni a essere quella di una volta (quale volta però non lo sanno nemmeno loro). Se gli stimoli sensoriali a cui sono abituati i ragazzi hanno alzato la soglia la scuola deve diventare uno show attrattivo, contratto nei tempi e eclatante nelle presentazioni? La digitalizzazione massiccia della scuola rispondeva in fondo ad una logica competitiva nei confronti della concorrenza dello svago online. Ma alla fine non basta cambiare veste alla comunicazione scolastica rendendola più colorata e veloce. Si comprime, semplifica, riduce anche la portata del pensiero connesso agli apprendimenti. Oppure ci si barrica dietro alla mitologia del gessetto, la fatica e la deprivazione sono le bandiere di una scuola indigesta dove si impara a forza e a dispetto della propria passione. Ma è proprio il desiderio di fare le cose che può innervare la crescita, non la sua soppressione. I casi di ansia, depressione, dipendenza dal gioco o dai social, isolamento sociale sono solo una parte della medicalizzazione dell’educazione: le difficoltà di vario genere negli apprendimenti sono giustificate da diagnosi e certificazioni che spesso invece di alzare la creatività e l’inventiva didattica per rendere più intuitivi i contenuti, li livellano a prestazioni più esecutive e mnemoniche.
Si segnalano le necessità di intervento, ma i servizi di neuropsichiatria infantile concedono un visita frettolosa dopo mesi.
In molti casi le famiglie hanno una scarsa tenuta e alle spalle dei ragazzi stanno adulti alla ricerca di consenso e gratificazione da parte dei loro figli, agnostici riguardo a indicazioni morali ed esistenziali, insoddisfatti e confusi sulle proprie stesse scelte. A volte ci sono famiglie coese e sagge che scoprono con spavento l’aprirsi del baratro nella capacità di vivere e di gioire dei loro figli.
Che si tratti di affinamento diagnostico o di una reale moltiplicazione dei casi, che l’aumento nel consumo di farmaci dipenda dalla progressiva disponibilità degli stessi, o da un aumento delle patologie, che la tesi di Haidt sulla correlazione fra diffusione dei social e intensificazione del disagio mentale presso preadolescenti e adolescenti sia reale, lo lasciamo decidere alla ricerca scientifica.
I casi di ansia, depressione, dipendenza dal gioco o dai social, isolamento sociale sono solo una parte della medicalizzazione dell’educazione: le difficoltà di vario genere negli apprendimenti sono giustificate da diagnosi e certificazioni che spesso invece di alzare la creatività e l’inventiva didattica per rendere più intuitivi i contenuti, li livellano a prestazioni più esecutive e mnemoniche.
L'editoriale
Una comunità basata sulla cura
di Gianluca Salvatori
Ci troviamo a fare i conti con la crescita della domanda di assistenza di lungo periodo, la persistente carenza di personale sanitario e sociosanitario, e l’aumento dei costi pubblici e privati per le cure. Tutto ciò in un contesto di profonde disuguaglianze territoriali