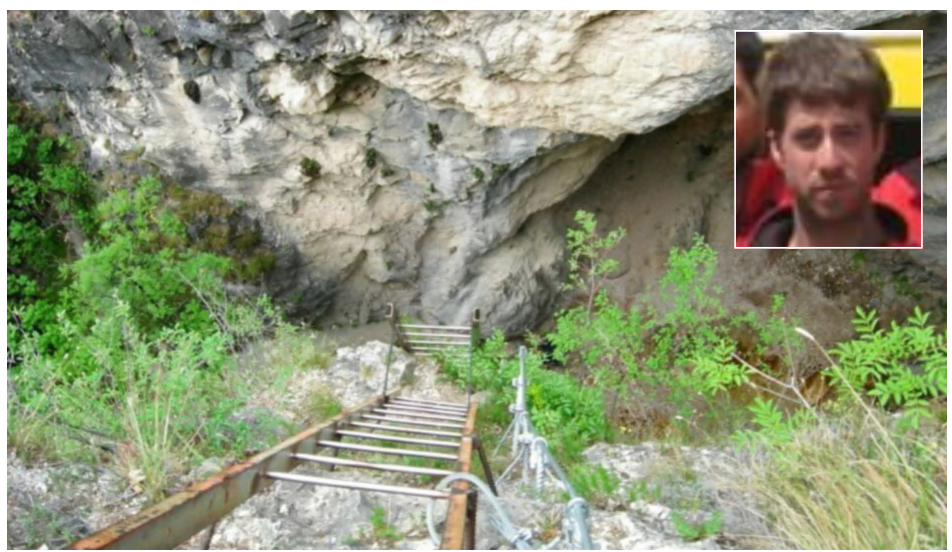l'editoriale
lunedì 10 Novembre, 2025
Dopo Fugatti coalizione a rischio
di Simone Casalini

La Corte costituzionale ha chiuso la partita del terzo mandato e non ci saranno tempi supplementari. Il dispositivo della sentenza, infatti, difficilmente conterrà valutazioni giuridiche che riaprano la questione o che lascino margini a interventi legislativi correttivi. Le motivazioni indicheranno piuttosto se il principio di giudizio è stato la lesione dei parametri democratici o la volontà di riaffermare il centralismo statale contro l’Autonomia. Quindi, game over e si apre un nuovo ciclo politico? Sì e no.
Il paradosso della pronuncia della Consulta sulla legge elettorale che istituiva il terzo mandato presidenziale è che rischia di rendere ancora più indispensabile la figura di Maurizio Fugatti.
È manifesto dallo scompiglio che ha generato nell’alleanza di centrodestra autonomista al punto che lo scenario più verosimile, in questo momento, non è la sostituzione del presidente leghista ma la dissoluzione della coalizione. Il Patt non può accettare una leadership di Fratelli d’Italia, i meloniani rivendicano la vicepresidenza sottratta e la guida delle operazioni per il 2028, la lista Fugatti perderebbe la sua ragione sociale, i Civici possono coltivare ambizioni ma solo se il patto politico non crolla. E comunque privo dell’immagine di Fugatti l’ipotesi già remota di un Polo territoriale, autonomista e moderato senza FdI decade. Un quadro fragile, fragilissimo che l’esasperazione del conflitto Fratelli d’Italia-Lega non aiuta a raddrizzare.
La centralità di Fugatti, in questa fase, risponde anche all’iper-personalizzazione della politica che conduce alla disintermediazione delle relazioni e a consegnare nelle mani di chi riesce ad essere leader un potere non delegabile, quello del consenso ad personam. Il leader onnivoro che è singolo e collettivo nello stesso tempo, consegnando al superfluo il resto.
Quindi il primo problema che hanno il centrodestra e il Patt è quello di convincere Fugatti ad esserci nella competizione elettorale del 2028, rinunciando ad una candidatura alle Politiche del 2027 che avrebbe la controindicazione di una legislatura ponte di un anno e lascerebbe la sensazione di una migrazione egoista. Della presenza dell’attuale governatore leghista ne ha bisogno anche la Lega (e il segretario Salvini) che non può permettersi una débâcle alle urne o di essere scavalcata da Fratelli d’Italia. E ne hanno bisogno, paradosso dei paradossi, gli stessi Fratelli d’Italia, pena il rischio azzoppamento. Quindi, come insegna la vicenda del governatore veneto Zaia, che guiderà la lista del Carroccio non potendosi ricandidare per la presidenza, anche il suo omologo trentino potrebbe maturare condizioni e slogan elettorali simili: «Dopo Fugatti scrivi Fugatti».
Ricandidarsi in lista nel 2028 sarebbe, in fondo, per Fugatti anche un modo per dimostrare, con tutte le incertezze del caso ovviamente, che il popolo lo avrebbe ancora voluto. Era la ratio del cambio elettorale, la volontà del popolo. O almeno era la giustificazione-paravento sulle paure autodistruttive del centrodestra. E potrebbe anche essere un credito, quello di una candidatura al servizio di Lega e coalizione, da spendere in un tempo successivo per aggiudicarsi un ruolo in un eventuale governo bis del centrodestra a livello nazionale. Fantapolitica? No, se il disegno politico precede l’interesse personale. La questione è comunque destinata a transitare anche dai tavoli nazionali.
Ciò che non appare ora praticabile è un nuovo dibattito sulla legge elettorale in senso proporzionale (proposta dal Patt), slegata soprattutto – come sarebbe – da una riflessione più ampia di sistema e sulla caducità democratica. Se si intende privilegiare uno strumento di voto che pone l’accento sulla rappresentanza e sulla mediazione politica occorre ripopolare un campo che in questo momento è sguarnito, non presidiato, con un elettorato in ritirata. La controprova è l’Alto Adige/Südtirol che vota con il proporzionale senza avere una vitalità politica superiore. Ma davvero è un ragionamento da compiere insieme per evitare le scorciatoie del terzo mandato o il sospetto di un uso di parte.
Un’ultima osservazione riguarda, infine, il merito della vicenda. Il passaggio da due a tre mandati non è quello tra democrazia e dittatura. L’Italia, in quelli che sono definiti «principi generali», presenta un insieme normativo piuttosto variegato. Per esempio, i sindaci dei municipi con meno di 5mila abitanti possono ambire ad un numero di mandati potenzialmente infinito. Come se in una piccola comunità non esistesse il problema della concentrazione del potere, del familismo e della democrazia. Ma appare molto opinabile anche la potenziale elezione senza limiti di un/una presidente del Consiglio solo perché avviene all’interno di una procedura parlamentare. Come se la legittimazione popolare a monte venisse in qualche modo attenuata dal tragitto istituzionale. Il punto debole del confronto sul terzo mandato non è stato la legittimità o l’opportunità, ma la coincidenza con i destini di leader politici (Zaia in Veneto, Fugatti in Trentino) in scadenza e senza possibilità di proroga.
Le motivazioni della Corte costituzionale ci diranno, inoltre, se davvero è in questione la democrazia o se invece lo sono i rapporti tra Stato e Autonomie. Un nodo, quest’ultimo, che sembra aver allarmato molto di più l’Alto Adige/Südtirol del Trentino rispetto a quelle che sono le prerogative delle Speciali. La premier Meloni, quando ha comandato il ricorso contro la legge trentina, oltre a sgambettare la Lega e Salvini messi in minoranza nel Consiglio dei ministri, ha voluto anche che fosse riconosciuto come «principio generale» dell’ordinamento giuridico della Repubblica il limite dei mandati. Punto su cui non c’è l’unanimità dei giuristi.
Insomma, lungi dal chiudere davvero definitivamente il discorso, la sentenza della Consulta sembra aver aperto una serie di scenari e interrogativi che il dibattito politico e giuridico dovranno vagliare e indirizzare da qui alla fine della legislatura.
L'editoriale
Una comunità basata sulla cura
di Gianluca Salvatori
Ci troviamo a fare i conti con la crescita della domanda di assistenza di lungo periodo, la persistente carenza di personale sanitario e sociosanitario, e l’aumento dei costi pubblici e privati per le cure. Tutto ciò in un contesto di profonde disuguaglianze territoriali