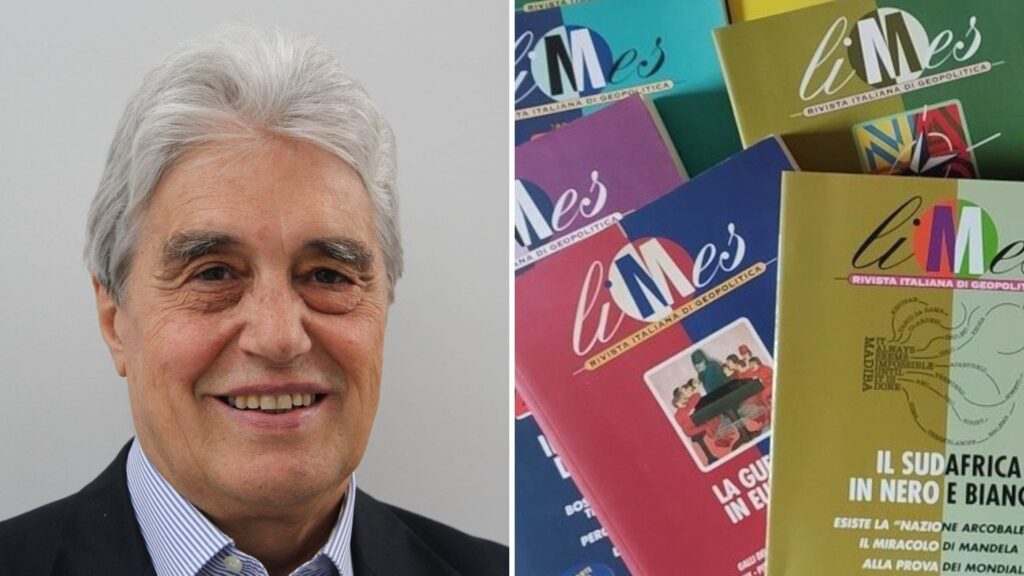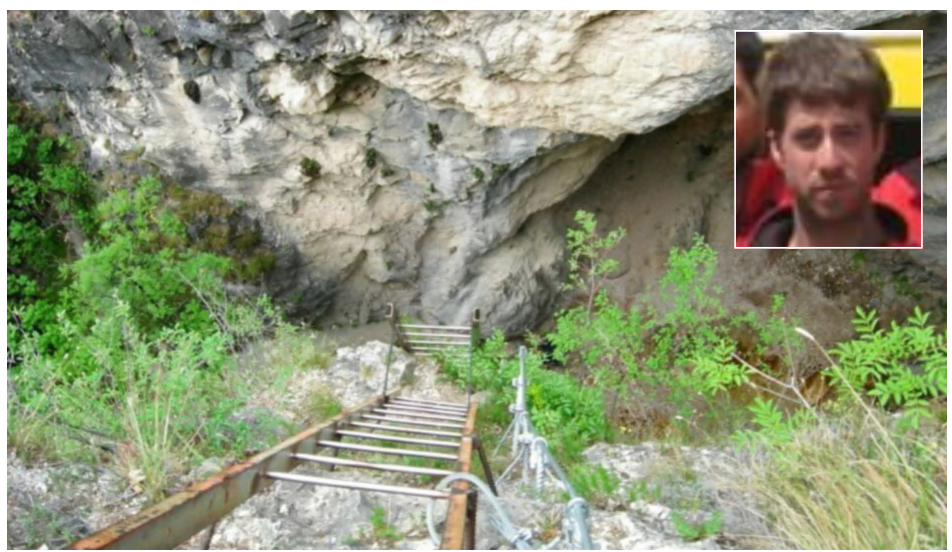L'intervista
domenica 9 Novembre, 2025
Cure palliative, la missione di Lonati: «L’empatia è intuire il dolore dell’altro come se fosse mio»
di Alberto Folgheraiter
La direttrice sociosanitaria di Vidas chiuderà martedì al castello del Buonconsiglio il festival Mortali

Medico milanese, dal 1995 Giada Lonati si occupa di cure palliative (dal latino «pallium», mantello, che fornisce protezione). Dal 2010 è direttrice sociosanitaria per Milano e provincia di Vidas (Volontari italiani domiciliari assistenza ai sofferenti) che a Milano gestisce anche due Hospice per malati terminali. Fondata da Giovanna Cavazzoni nel 1982, questa associazione di volontariato laica, «offre assistenza sociosanitaria completa e gratuita a bambini, adulti e anziani affetti da malattie inguaribili».
Lonati ha pubblicato un libro «Prendersi cura – per il bene di tutti, nostro e degli altri» nel quale affronta i nodi della sua professione. Martedì alle 17, al castello del Buonconsiglio, chiude la seconda edizione del festival «Mortali», una settimana densa di incontri, riflessioni, cultura e musica sul tema della morte con appuntamenti a Trento, Rovereto, Mori e Bolzano.
In che cosa consiste il lavoro di «medico palliativista»?
«Le cure palliative sono una presa in carico globale della persona affetta da una malattia inguaribile, prevalentemente nella fase finale della vita ma anche in un periodo più anticipato. Con lei ci si prende carico anche della sua famiglia».
Esattamente che cosa fa?
«In un contesto estremamente complicato che è la sofferenza, la fine della vita, il medico palliativista si inserisce all’interno di una équipe, strutturata e multidisciplinare, per portare il suo contributo di competenze nel rispondere ai bisogni del nucleo paziente-famiglia».
Con quali mezzi?
«Con una risposta che naturalmente è di tipo farmacologico, perché alla fine della vita ci sono dei sintomi importanti, ma è una risposta integrata. Perché non è rivolta solo al dolore fisico ma la presa in carico di quel dolore globale che accompagna la sofferenza estrema».
Perché ha scelto questo percorso professionale?
«Per un incontro felice. Io venivo dall’oncologia, ero molto giovane, appena laureata… In un ospedale di provincia, a Milano, cercavano un medico che praticasse le cure palliative. Era una medicina che ancora non esisteva e così, un giorno, ho seguito a domicilio colui il quale sarebbe diventato il mio primario…».
E che cosa l’ha folgorata?
«Ho incontrato una donna che era gravemente malata e che aveva bisogno di capire che cosa le stava succedendo… Io venivo da una comunicazione con regole dettate dall’organizzazione dell’ospedale: in un quarto d’ora dovevi dire a una persona che non poteva più fare un trattamento chemioterapico… In qualche modo era una condanna a morte senza appello e senza la possibilità di parlarne. In quel momento ho capito che esisteva una medicina in cui il tempo era il tempo del paziente, il tempo della relazione».
Che tipo di relazione?
«Ho capito che ci si poteva sedere sul divano e dedicare a quella persona tutto il tempo che era necessario».
La legge 219 del 2017, sul consenso informato, dice che «il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura».
«Quella cosa lì l’ho intuita facendo visita a quella signora e ho capito che per me non valeva la pena scommettere la mia vita per qualcosa di meno».
Pertanto, si può dire che le cure palliative, oltre ad aver sdoganato l’uso degli oppioidi per lenire il dolore, hanno sollecitato anche il ricorso all’empatia?
«Diciamo che nelle cure palliative l’empatia, ma ancor più la compassione, svolgono un ruolo importante. L’empatia è intuire il dolore dell’altro come se fosse mio. Dal mio punto di vista la compassione ha, in più, un effetto pro-sociale».
In che senso?
«Nel senso che la compassione ti spinge a muoverti per lenire la sofferenza dell’altro. Insomma, l’empatia e la compassione sono elementi strutturali delle cure palliative».
Qualche anno fa lei ha pubblicato «Prendersi cura» (Corbaccio editore) un libro sulla sua esperienza umana e professionale. Prendersi cura degli altri serve anche a sé stessi?
«Totalmente. Credo che la cura abbia un potere trasformativo perché, dopo aver incontrato un altro sofferente, non si è più uguali. Credo anche che riconoscersi capaci di cura sia un lavoro prezioso sull’autostima perché è molto bello prendersi cura degli altri. Ed è bello anche riconoscersi bisognosi di cura. Mette ordine».
Nessuno si salva da solo.
«Una collega mi diceva: quando hai il dubbio di essere malata non ti chiedi “perché proprio a me?” ma ti chiedi “perché non a me”? Siamo fratelli in questa sofferenza per cui credo che la cura degli altri possa diventare anche un percorso spirituale».
Dottoressa Lonati, lei intende dire che le cure palliative sono un dono?
«Certamente sono un dono. E le dirò di più: lo sono per chi le riceve, perché molte volte riceviamo una gratitudine dalle persone che curiamo e che ci carica di energia. Ma lo sono anche per chi le fa. I nostri volontari spesso ci dicono: credevo di dare ma ho ricevuto molto più di quello che ho dato. E questa è un’esperienza che facciamo anche noi come curanti».
Le cure palliative sono un’alternativa all’eutanasia (dal greco eu-bene e thanatos-morte, ossia la «buona morte»)?
«Assolutamente no, perché nascono da una domanda diversa. L’eutanasia nasce da una richiesta di morte; le cure palliative rispondono alla richiesta di lenire la sofferenza».
Si parla molto del fine-vita, delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat).
«Le Dat sono un’estensione del consenso informato. Se in questo momento io e lei abbiamo un evento acuto che richiede di sottoporci a un intervento o trattamento di qualsiasi genere, abbiamo il diritto, sancito dalla Costituzione, di esprimere il nostro consenso».
Le disposizioni anticipate consentono di esprimerlo pro futuro.
«Infatti. Si dice oggi a chi dovrà decidere per nostro conto, qualora non fossimo in grado di poterci esprimere, che cosa fare o non fare: dall’accettare o meno una trasfusione, dalla prosecuzione o alla sospensione dell’alimentazione».
Nel merito abbiamo pubblicato sul nostro giornale un’intervista a Beppino Englaro, il papà di Eluana, che ha combattuto 14 anni per vedere riconosciuto un diritto costituzionale.
«Le disposizioni anticipate di trattamento sono un’estensione del nostro consenso che è espressione del modo in cui noi vediamo la vita e del nostro concetto di salute».
Quanti pazienti ha visto morire?
«Francamente non glielo so dire. Mi verrebbe da dire un buon numero. Non ho mai provato a quantificarlo».
Più che della morte, ineluttabile, molti dicono di avere paura della sofferenza. Si muore ancora fra lancinanti dolori fisici?
«Molto, molto meno anche rispetto a pochi decenni fa. Il dolore fisico è controllabile nella quasi totalità dei pazienti. Grazie anche all’uso dei tanto vituperati oppioidi. Qualche volta, certo, a scapito della conservazione della coscienza. Quello che facciamo fatica a controllare sono altri sintomi: la debolezza, la cachessia, la magrezza estrema…».
Che mappa si può tracciare, oggi in Italia, delle cure palliative?
«A macchia di leopardo. Sono sviluppate in modo bizzarro. Si dice che siano raggiunti dalle cure palliative circa il 35-40% degli adulti e il 15% dei minori che ne hanno bisogno. Ma con una distribuzione territoriale molto disomogenea. Non con un gradiente nord-sud, perché in Sicilia e nel Lazio ci sono centri di cure palliative molto sviluppati. In altre regioni c’è una carenza marcata».
Che cosa resta di noi, dopo di noi?
«Non lo so. Recentemente ho letto un libro molto bello, “Fissando il sole”, di Irvin D. Yalom, uno psichiatra-psicoterapeuta americano di origini ebraiche. Tutto nasce dalla considerazione che ci sono due cose che non riusciamo a fissare a lungo: il sole e la morte. Ai suoi pazienti che hanno il terrore della morte, Irvin Yalom spiega che il bene che facciamo in vita potrebbe allontanarsi da noi seguendo dei cerchi concentrici che noi non conosciamo. Diventando magari parole che saranno pronunciate da altri. E questo ci responsabilizza molto sulla cura delle parole. Perché questo potrebbe succedere anche con le cattive parole. Dice anche che il contributo che abbiamo di cambiare il mondo è invisibile ma determinante».
Campi liberi
Cento anni fa le leggi fascistissime: così il regime strinse la presa. Alcide Degasperi dovette lasciare la direzione del «Nuovo Trentino»
di Alberto Folgheraiter
Il 1926 segnò una svolta drammatica nella storia italiana: libertà di stampa cancellata, podestà nei Comuni, scioglimento dei partiti e persecuzione degli oppositori
L'intervista
Enrico Deaglio rilegge la storia d'Italia: «Tra mafia e terrorismo, gli anni Ottanta furono una guerra civile silenziosa»
di Paolo Morando
Il giornalista e scrittore ripercorre il decennio del riflusso e della violenza, tra morti invisibili, traffici illeciti e un Paese che sembrava non accorgersi di nulla
Campi Liberi
Il caso Limes secondo Gianni Bonvincini (Istituto affari internazionali): «Rivista antieuropeista. I beni russi congelati? Trump si oppone all'uso perché ha accordi con Mosca per la ricostruzione»
di Lorenzo Fabiano
L'esperto trentino di relazioni internazionali: «L'Europa sotto doppio ricatto da parte di Russia e Usa»