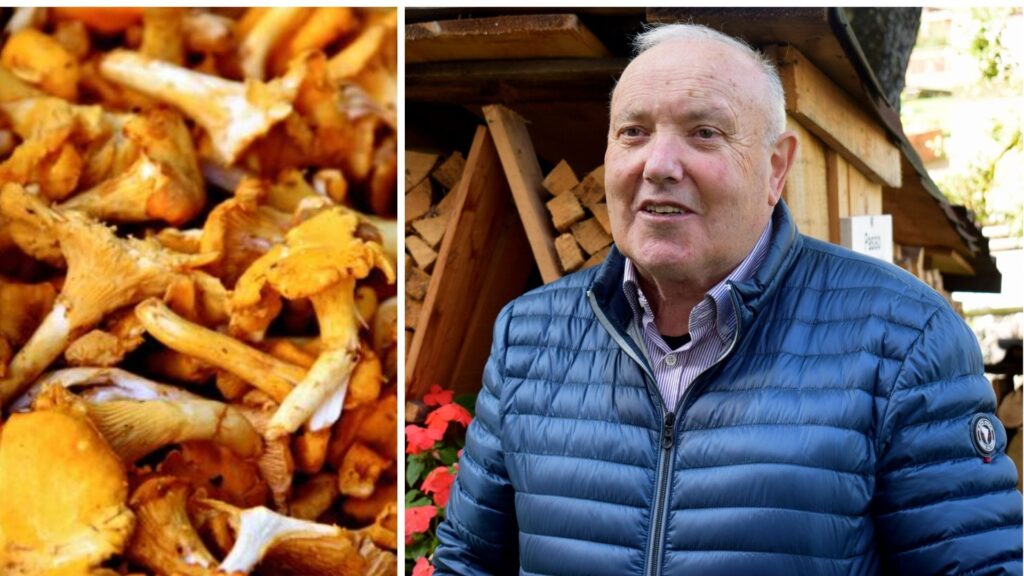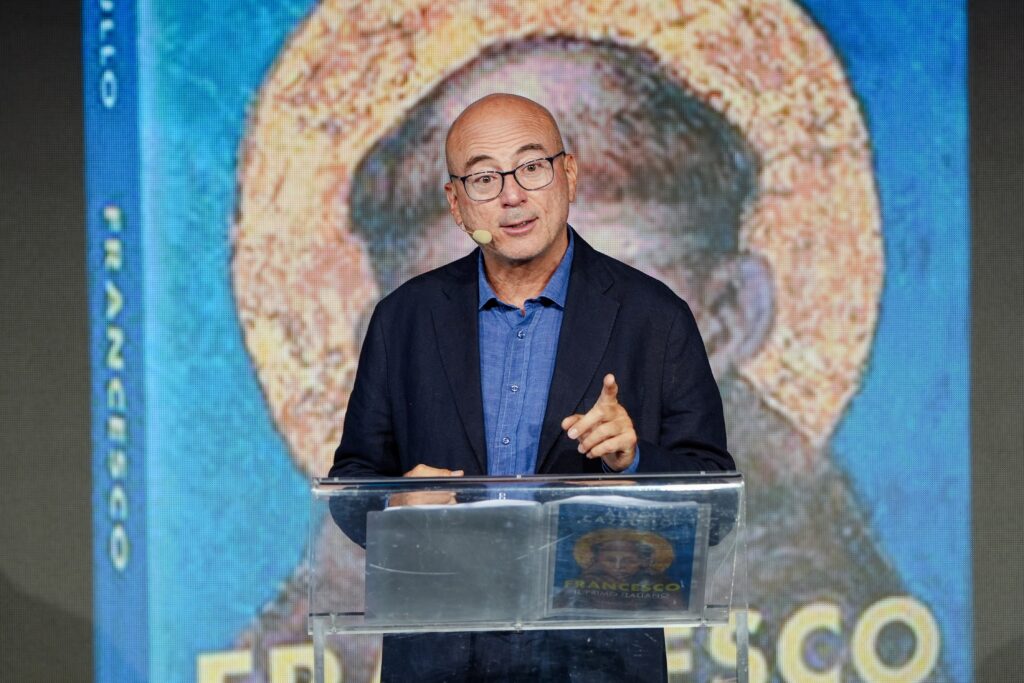La conferenza sul clima
venerdì 21 Novembre, 2025
Cop30 di Belém: Elisa Calliari, la negoziatrice trentina che lavora dietro le quinte per il futuro del clima
di Annika Zamboni
Cittadina di Volano e ricercatrice climatica, guida i negoziati italiani su perdite e danni durante la conferenza Onu, tra diplomazia, compromessi e ore di lavoro serrate

La Cop30 di Belém è stata definita da molti come una conferenza delle persone: vivace, partecipata, animata dalla società civile, dalle comunità indigene e da spazi di dialogo aperto. Ma dietro le immagini colorate e gli eventi pubblici esiste un’altra Cop, meno visibile ma cruciale: quella dei negoziatori, coloro che per due settimane lavorano giorno e notte per tradurre discussioni complesse e interessi geopolitici in accordi climatici condivisi.
Tra queste persone c’è anche una trentina: Elisa Calliari, originaria di Volano, ricercatrice e negoziatrice per il governo italiano. Laureata in Scienze internazionali e diplomatiche e con un dottorato sui cambiamenti climatici conseguito a Venezia, Calliari fa parte della delegazione che, sul piano tecnico, supporta il ministero dell’Ambiente nei negoziati Onu. Il suo percorso è iniziato nel 2014, quando partecipò al progetto «Racconta il clima alla Cop20», promosso dall’associazione Viração&Jangada: un’esperienza che le ha aperto la strada verso il mondo delle conferenze sul clima.
Calliari ci spiega che la delegazione dell’Italia è basata su un modello misto che unisce funzionari ministeriali ed esperti provenienti da centri di ricerca come il Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc) e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). Un gruppo di lavoro ibrido che lavora in sinergia.
Dentro la Cop, le trattative si muovono lungo tre grandi pilastri: mitigazione (ridurre le emissioni), adattamento (prepararsi agli impatti climatici) e finanza. Elisa si occupa di perdite e danni, gli impatti più severi del cambiamento climatico che superano la capacità delle persone e degli ecosistemi di adattarsi.
Elisa ci racconta che i negoziati su perdite e danni procedono soprattutto sul piano operativo: rendere attivo il nuovo fondo approvato nelle Cop precedenti e definire i meccanismi di supporto tecnico ai Paesi più vulnerabili. Un lavoro lungo e complesso: solo su questo documento si sono accumulate più di settanta ore di discussione in dieci giorni.
Nonostante questa Cop fosse quella dell’adattamento, Calliari è concentrata sul tema delle perdite e danni. Le giornate dei negoziatori sono serratissime: si parte alle nove con il coordinamento tra i delegati europei; alle dieci iniziano i negoziati ufficiali che proseguono spesso fino a tarda sera. Nei temi più delicati, per velocizzare il processo, si entra in stanze più ristrette tra i gruppi negoziali dove si lavora riga per riga sul testo.
Ma la tecnica non basta. A ogni passo, le dinamiche geopolitiche si intrecciano con le procedure. Alle Cop vale il principio del consenso: ogni Paese ha lo stesso potere di veto. In pratica, però, a fare la differenza sono le dimensioni e le risorse delle delegazioni. Alcuni Stati possono seguire decine di tavoli; altri, molto piccoli, faticano a coprirne diversi. Per questo figure come Calliari, esperti che affiancano la diplomazia, sono cruciali.
Accanto alle differenze di capacità, ci sono poi alleanze e blocchi negoziali: dal G77+Cina alle piccole isole, fino al gruppo arabo, spesso critico quando nei documenti in discussione si parla di diritti umani.
Cosa rende allora possibile arrivare a un accordo? Quest’anno la presidenza brasiliana sta puntando su un approccio a pacchetto, ereditato dalla prima Conferenza di Rio del 1992: tenere insieme tutti i pezzi del negoziato, in modo che non sia possibile far saltare un punto senza far crollare l’intero equilibrio.
L’obiettivo, ci racconta Calliari, non è che tutti siano soddisfatti, ma che nessuno sia così insoddisfatto da bloccare tutto. Dietro le grandi dichiarazioni, insomma, la Cop è fatta di lavoro paziente, compromessi, ore di confronto e diplomazia climatica che vive di dettagli, virgole e relazioni umane. E da questo lavoro nascono gli accordi globali che, nel bene o nel male, definiscono il futuro del clima.
Terra Madre
La montagna chiede ascolto e il Trentino apre il cantiere «2050» per ripensare territori e comunità
di Tommaso Martini
Dalla critica al modello isotropico di Farinelli ai tavoli partecipativi di Slow Food: un viaggio nelle Terre Alte che rivendicano diritti, voce e nuove visioni per il futuro
Il diario
Cop30, l’ombra climatica degli eserciti: emissioni militari pari al 5,5% del totale globale e nessun obbligo di rendicontazione
di Marzio Fait
Mentre i negoziatori discutono di decarbonizzazione, un settore resta fuori dai radar ufficiali: quello militare. Secondo il Ceobs, guerre e apparati di difesa generano emissioni paragonabili a quelle delle grandi economie, dalla guerra in Ucraina ai bombardamenti su Gaza, fino alla corsa al riarmo europeo