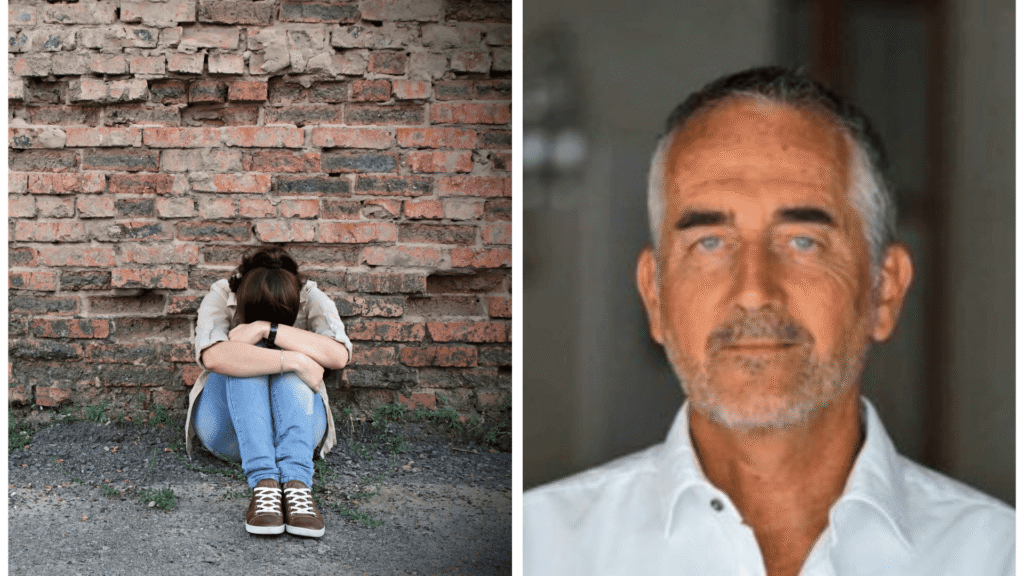L'intervista
lunedì 1 Settembre, 2025
Boris Vitlačil, il cooperante italo-bosniaco che salperà con la Sumud Flotilla. «Rivivo a Gaza l’assedio di Sarajevo. Le safe zone? Come Srebrenica»
di Lorenzo Fabiano
Da quindici anni lavora per un’organizzazione internazionale che opera a Gaza e ora si prepara alla partenza

Un po’ come fece Churchill nel 1940, ma quella fu una vera a propria operazione di evacuazione navale, quando inviò 850 barche di ogni tipo a trarre in salvo i soldati britannici e francesi intrappolati dai nazisti a Dunkerque. Sono salpate domenica da Genova e salperanno il 4 settembre dalla Sicilia, ma anche dalla Tunisia, dalla Grecia e da Barcellona: si tratta della Global Sumud Flotilla, la più grande missione marittima civile mai tentata verso Gaza, una coalizione mondiale di 44 Paesi composta da attivisti, giornalisti, medici, persone comuni e personalità dello spettacolo con l’obiettivo di spezzare l’assedio e stabilire un canale umanitario stabile con il grido disperato d’aiuto che viene dalla Palestina.
«Sumud», che in arabo significa resistenza, resilienza, fermezza, perseveranza, perché lo sdegno va bene, ma non basta. Bisogna anche fare qualcosa di concreto. E su una delle barche che salperanno dalla Sicilia ci sarà anche Boris Vitlacil, attivista cooperante italo-bosniaco che una tragedia come questa la visse trent’anni fa quando era ragazzino nella Sarajevo assediata e ridotta alla fame dalla tenaglia serba: «Porto la voce delle vittime di Sarajevo a quelle di Gaza: un ponte tra l’assedio del passato e il blocco del presente, nella speranza di dimostrare che la coscienza respira ancora di fronte a una desolazione calcolata. Il mio imbarco sulla flottiglia non è un atto di sfida, ma di dovere: un dovere di far rispettare gli obblighi internazionali quando l’applicazione vacilla, un dovere di affermare i principi quando le istituzioni falliscono», spiega Boris che nel 1993 lasciò la Bosnia in fiamme per riparare in Italia dopo essere stato un anno in Repubblica Ceca.
Boris, cosa la spinge a partire?
«Da operatore umanitario (da quindici anni Boris Vitlacil, laureato in Scienze Internazionali Diplomatiche, è cooperante per un’organizzazione umanitaria che si trova a Gaza e di cui non può fare il nome per timore di ritorsioni, ndr) mi rendo conto che non possiamo portare aiuti a una popolazione che ne ha tanto bisogno. In Giordania abbiamo i magazzini pieni di cibo e beni di prima necessità e non riusciamo a farli entrare e distribuirli. Siamo in una situazione perversa, un paradosso in cui c’è un governo che è stato accusato di genocidio dalla Corte Internazionale e allo stesso tempo questo governo è incaricato di disporre corridoi umanitari che, invece, dovrebbero essere indipendenti sotto una giurisdizione internazionale. Il governo di Israele sta mettendo a morire di fame un popolo, tanto che l’Onu ha denunciato una situazione di carestia a Gaza. È inaccettabile. Da un anno siamo esposti a immagini orrende, ci sentiamo impotenti; ne va della nostra umanità, non possiamo chiudere gli occhi davanti a un genocidio impunito, rassegnarci alla normalizzazione dell’eccidio, della fame e all’erosione dell’umanità. Non possiamo essere complici di questo, dobbiamo cominciare a far capire che la situazione deve cambiare urgentemente. Se i corridoi umanitari fossero aperti, le morti per fame o dissenteria finirebbero in tre giorni».
Lei questa stessa tragedia la visse sulla sua pelle trent’anni fa…
«In Bosnia c’ è molta gente che soffre per quanto sta accadendo a Gaza, ma la mia empatia non viene dal fatto che ho vissuto il dolore a Sarajevo, semmai posso dire che forse proprio per questo le emozioni sono più intense. Avevo tredici anni, è un’esperienza forte, anche se sei un ragazzino. Sei privato della tua vita, della normalità della tua vita. Ti ritrovi senz’acqua corrente, al freddo, senza elettricità, con il frigo vuoto. Capisci allora che è la solidarietà, l’attenzione dell’altro a tenerti in vita quando non hai niente. Quando vedo i bambini di Gaza giocare in strada, penso a quando ero bambino a Sarajevo e anche noi giocavamo in strada: la resilienza dei bambini, la loro capacità di trasformare una cosa orrenda come la guerra nella purezza del gioco è una magia. Quando muore un bambino di Gaza è per me come se morisse un bambino qui accanto a me».
Trent’anni fa il genocidio di Srebrenica in Bosnia: se dopo trent’anni siamo qui a pronunciare di nuovo quella stessa parola, significa che non abbiamo imparato proprio nulla dalle lezioni del passato. Che ne pensa?
«E invece, purtroppo, hanno imparato, nel senso che hanno sviluppato quella lezione in un’ottica di perversione. Come allora, parliamo di safe zone, aree dove i civili vengono concentrati e ammassati, per poi decidere che devono essere cacciati via anche da lì. Di safe non c’è proprio nulla, questa gente continua a non avere nulla che la mantenga in vita; chi garantisce che queste persone siano davvero safe? Solo un organismo internazionale dovrebbe farlo, altrimenti queste safe zone diventano solo zone di sterminio».
Immagino siate consapevoli del fatto che, con ogni probabilità, andrete incontro a un blocco navale israeliano.
«Sì, ma non è la prima Flottilla. Abbiamo memoria delle esperienze del passato e sappiamo a cosa possiamo andare incontro (nel 2008 due barche del Free Gaza Movement riuscirono a sbarcare nella Striscia; due anni dopo, le barche della Freedom Flotilla vennero assaltate dalla Marina israeliana: finì con nove vittime tra gli attivisti. Quest’estate i tentativi di raggiungere via barca Gaza sono terminati prima con un attacco di droni al largo delle acque maltesi e poi con l’arresto degli attivisti da parte della flotta militare israeliana in acque internazionali, ndr). Stavolta è però una situazione senza precedenti, una dimensione come questa non c’era mai stata in passato: abbiamo ricevuto 27.000 adesioni da tutto il mondo. Pensi se si unissero tutte le barche del Mediterraneo per cercare di aprire questo corridoio umanitario: be’, io credo che nessuna forza al mondo potrebbe fermarle. Solo le masse sono in grado di far cadere i regimi totalitari».
In Sudafrica il regime dell’apartheid cadde, proprio perché si trovò alla fine isolato dinanzi a una mobilitazione globale da tutto il mondo.
«Certo. E a Gaza la linea rossa è stata superata: non esiste un giornalismo indipendente che ci informi, i giornalisti e i civili non sono protetti, i bambini continuano a morire. Ma davvero è questa roba che il mondo oggi produce? Perché se è questo, in un mondo così non vale la pena di viverci».
Due Popoli due Stati, Israele e Palestina, la soluzione dai più auspicata; trent’anni fa la guerra in Bosnia finì con gli Accordi di Dayton che di fatto divisero il Paese in due entità, croati e bosgnacchi da una parte, e serbi dall’altra. Doveva essere un accordo transitorio, ma trent’anni dopo siamo rimasti lì…
«In un Paese multietnico come la Bosnia ci troviamo a dover riconoscere il diritto di veto a ogni gruppo etnico: questo crea un perverso meccanismo che accresce la segregazione a discapito dell’integrazione. È un sistema nazionalistico che si nutre di una narrazione di separazione basandosi sulla paura dell’altro, sull’odio nei confronti dell’altro, perché devi proteggere la tua comunità. Una volta tutto questo non esisteva: io sono nato nella Jugoslavia, la Croazia era il mio mare, Belgrado la città di mia nonna. Persino una città come Sarajevo è divisa, un’assurdità. La Bosnia è oggi un insieme di microsistemi autarchici, un Paese estremamente disfunzionale che non riesce a progredire in quanto è privo di un interesse collettivo, non lavora, cioè, per il bene comune. Nemmeno sulla questione palestinese ha una posizione unitaria».
L'intervista
Davide Enia riporta in scena «Italia-Brasile 3 a 2»: memoria, teatro e quella «coscienza collettiva felice» che oggi ci manca
di Jacopo Tomasi
Al teatro Zandonai di Rovereto lo spettacolo che consacrò l’attore e drammaturgo palermitano: tra calcio, lutti, identità e rito collettivo. «Sarà una festa per tutti»
L'inchiesta
L'amore al tempo delle App, la docente di Social media: «Piattaforme frequentate soprattutto da uomini. L’essere scelti gratifica»
di Andrea Manfrini
L'esperta analizza il fenomeno crescente delle relazioni mediate dalla rete. «È importante sapere che tipo di relazione si cerca e comunicarlo»
In primo piano
In Trentino gli utenti psichiatrici sono aumentati del 70% in vent'anni. Il primario Claudio Agostini: «Siamo davanti a un fenomeno epocale»
di Donatello Baldo
Il direttore Dipartimento transmurale di Salute mentale dell’Asuit: «Non vediamo più solo persone che presentano sintomi da manuale. C'è un disagio diffuso»