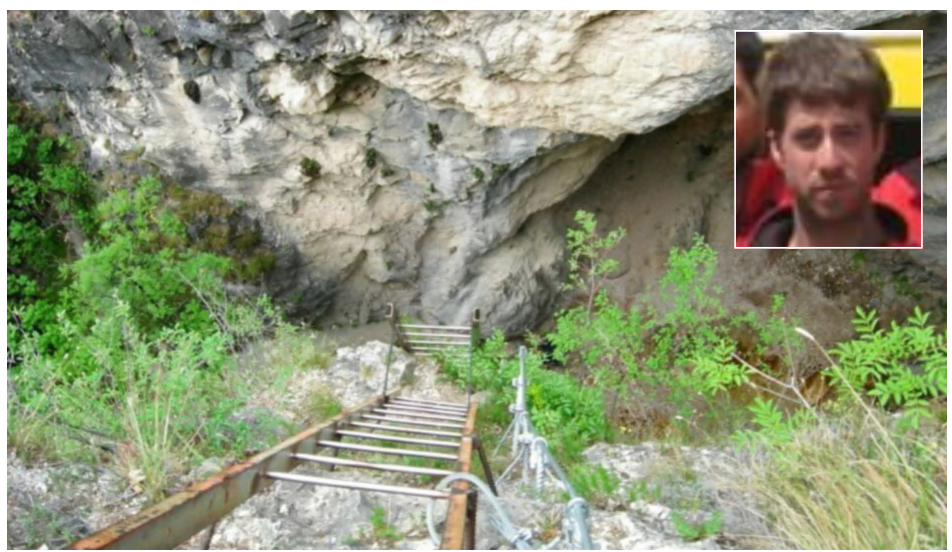l'editoriale
giovedì 30 Ottobre, 2025
Salari reali e fiscalità: cosa cambia
di Andrea Fracasso
Dovrebbe essere il mercato del lavoro tramite la contrattazione, e non il governo tramite la tassazione, a far sì che una quota maggiore del valore aggiunto vada a lavoratrici e lavoratori, in modo particolare nei settori e nelle imprese che hanno realizzato elevati profitti grazie ad attività soggette a limitata concorrenza

Da mesi molti osservatori sottolineano come i redditi in Italia abbiano perso potere di acquisto in questi vent’anni e, in particolare, nell’ultimo quinquennio segnato da elevata inflazione. Secondo il rapporto annuale dell’Istat di maggio, la riduzione delle retribuzioni reali tra gennaio 2019 e dicembre 2024 è stata del 10,5%, frutto di una crescita delle retribuzioni del 10,1% contro un aumento dei prezzi al consumo del 21,6%. In luglio, l’Ocse quantificava la riduzione dei salari reali italiani rispetto al 2021 in – 7%, a differenza del valore costante registrato in media nei Paesi dell’organizzazione. Nel suo quinto Bollettino economico del 2025, la Banca centrale europea mostrava come i salari reali avessero completamente recuperato o superato i livelli del quarto trimestre 2021 in diversi Paesi dell’area dell’euro (esempio Germania), mentre in Italia restasse ancora un 6% da recuperare.
L’elevata inflazione dei prezzi di beni e servizi registrata in questi cinque anni non è infatti stata accompagnata in Italia da un aumento proporzionale delle retribuzioni, almeno per buona parte dei lavoratori dipendenti. Un fenomeno che aiuta a comprendere l’aumento dei livelli di occupazione, la crescita del numero di famiglie povere e a rischio povertà e l’andamento non entusiasmante dei consumi privati.
Per affrontare questa situazione e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, il Governo ha deciso di inserire nella bozza della legge di bilancio 2026 una serie di interventi volti ad aumentare i redditi al netto delle tasse. Diverse misure sono di natura fiscale, come la riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% e l’imposizione di una aliquota limitata sugli aumenti contrattuali per i redditi bassi e sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti privati a seguito dei rinnovi contrattuali. Queste misure riducono l’ammontare delle tasse altrimenti dovuto a legislazione vigente allo Stato.
Nonostante la condivisibile finalità delle misure, serve ricordare che la perdita del potere di acquisto dei salari deriva da una crescita meno marcata di questi ultimi rispetto a quella dei prezzi. Dovrebbe essere il mercato del lavoro tramite la contrattazione, e non il governo tramite la tassazione, a far sì che una quota maggiore del valore aggiunto vada a lavoratrici e lavoratori, in modo particolare nei settori e nelle imprese che hanno realizzato elevati profitti grazie ad attività soggette a limitata concorrenza. Con riferimento a un rapporto di Mediobanca su circa 2000 società, Federico Fubini sul Corriere della Sera ha rilevato come nelle società italiane a controllo pubblico i salari dei dipendenti abbiano perso quasi il 9% di potere d’acquisto dal 2021, nonostante il costante aumento di valore aggiunto per unità di lavoro registrato negli ultimi dieci anni. Il mancato riallineamento delle retribuzioni reali colpisce ancora di più se si ricorda che, in questi stessi anni, si è assistito a un rapido aggravarsi delle difficoltà delle imprese a individuare e attrarre lavoratori e lavoratrici, specializzati e non. Certamente non tutte le imprese hanno tratto dei profitti maggiori dalla moderazione salariale e alcune (specie nella manifattura) l’hanno sfruttata per far fronte ai costi crescenti di altri input della produzione, come l’energia. Questo è una questione diversa rispetto alla prima, un segno della limitata capacità di far crescere il valore aggiunto in una parte importante del sistema economico.
L’andamento negativo delle retribuzioni reali segnala quindi due problemi: uno scarso aumento della produttività in alcune imprese e una distorta distribuzione dell’aumento di questa (ove realizzato) a causa di un inadeguato sistema di rinnovi contrattuali. Pensare che lo Stato possa rinunciare a una parte delle risorse fiscali per compensare questi due fenomeni è discutibile, anche perché il taglio delle risorse da destinare ai servizi pubblici potrebbe costringere le famiglie a sostenere spese compensative, annullando il beneficio ricevuto tramite gli sgravi. Meglio rivedere più a fondo la politica dei redditi, il sistema dei rinnovi dei contratti e la governance di alcune società pubbliche e partecipate al fine di garantire una più equa redistribuzione del valore aggiunto creato.
Vi è però un motivo diverso per cui il Governo potrebbe aver scelto di ridurre la tassazione con interventi ad hoc, ovvero iniziare un percorso di riduzione del drenaggio fiscale (fiscal drag). Come si è detto, le retribuzioni sono aumentate del 10% in termini nominali in questo quinquennio e ciò ha portato a un aumento automatico delle entrate fiscali. In un sistema di tassazione progressivo (dove la tassazione cresce più che proporzionalmente al crescere dei redditi nominali), fatto da scaglioni ad aliquote crescenti e varie detrazioni, l’aumento dei salari nominali porta automaticamente a una crescita delle entrate. È possibile che il Governo abbia inteso restituire una parte dell’extra gettito, scegliendo al contempo di redistribuirlo in modo che vada a chi beneficia delle misure introdotte dalla manovra. Un meccanismo che, insieme alla presenza di redditi soggetti a tassazione non progressiva (flat), può alterare significativamente l’equità complessiva del sistema di tassazione, nonostante le buone intenzioni.
Il recupero del drenaggio potrebbe meglio avvenire attraverso la revisione di detrazioni e scaglioni, alzandoli in modo adeguato all’inflazione. Cinquant’anni fa essi erano indicizzati all’inflazione (un aspetto da non confondere con la scala mobile che invece legava l’andamento delle retribuzioni nominali all’inflazione) proprio per sterilizzare il drenaggio. Alternativamente si potrebbe calcolare l’Irpef sulla base imponibile corrente e su quella deflazionata, definendo la parte dell’imposta da restituire al contribuente.
In questi giorni un gruppo di ricercatori e ricercatrici ha realizzato uno studio sul fiscal drag nei vari paesi europei pubblicato dalla Banca centrale europea (Fiscal drag in theory and in practice: a European perspective). Lo studio analizza il periodo tra il 2019 e il 2023 in cui grande è stato l’aumento dei redditi nominali.
L’analisi mette in evidenza come in tutti i Paesi il fenomeno del drenaggio sarebbe stato piuttosto marcato se non corretto. Dei 21 Paesi considerati, 16 hanno introdotto qualche forma di indicizzazione automatica o discrezionale del sistema e solo 5 (Cipro, Grecia, Croazia, Ungheria e Italia) non l’hanno fatto. Anche in assenza di indicizzazione, tutti gli Stati hanno adottato anche delle riforme ad hoc della tassazione che, in un modo o nell’altro, hanno tenuto conto del fenomeno e l’hanno moderato (questa osservazione conferma l’interpretazione che ho dato di alcune misure proposte dal Governo in chiave anti-drenaggio).
Secondo lo studio, in Italia il recupero è stato quindi pari al 50% del totale, mentre esso è stato completo in Finlandia, Irlanda, Francia, Portogallo e Grecia, e superiore al 100% in altri Paesi tra cui la Germania. Lo studio quantifica in ben mezzo punto di Pil l’extra-gettito ricevuto dallo Stato italiano a causa dell’incompleto aggiustamento.
L’analisi mostra anche come, in Europa, il drenaggio fiscale penalizzi in modo particolare i contribuenti che si collocano negli scaglioni più bassi (anche senza passaggio da uno scaglione all’altro in presenza di detrazioni). Questo effetto differenziato a sfavore dei redditi più bassi riduce la progressività complessiva del sistema, già peggiorata con l’introduzione di forme di tassazione non progressiva su una parte dei lavoratori autonomi.
Un motivo in più per ripensare nei prossimi anni l’approccio complessivo, passando da aggiustamenti ad hoc e indiretti a una riforma più strutturale del sistema di prelievo.
Andrea Fracasso
*Professore ordinario di Politica economica Unitn