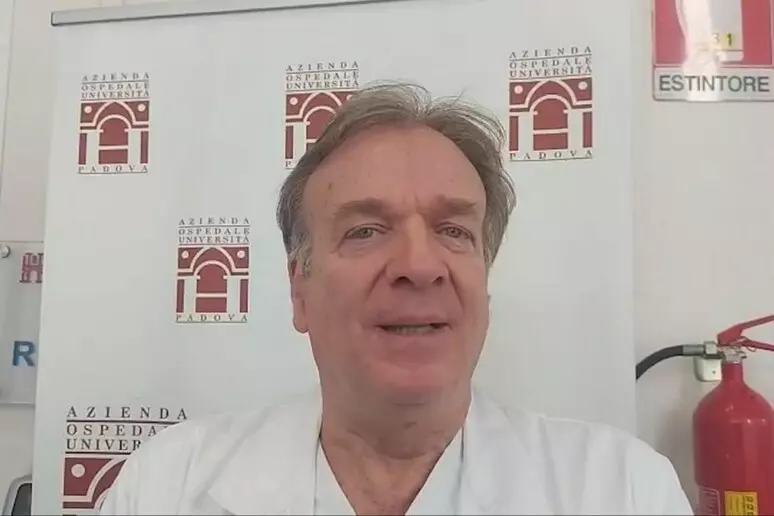L'editoriale
lunedì 11 Agosto, 2025
Il turismo e la questione culturale
di Simone Casalini
Nel 2025 saranno 964mila i turisti dal Medio Oriente in Italia: analizzare correttamente la questione può diventare un momento di crescita per tutti

Sono molti i Paesi occidentali che negli ultimi anni si stanno rivolgendo al mercato arabo per accrescere il flusso potenzialmente infinito del turismo o per compensare il calo dei mercati tradizionali. Quando parliamo di mondo arabo o islamico dovremmo avere l’avvertenza di specificare che esiste un’unica area di provenienza che ha capacità economica al momento: i Paesi del Golfo. In particolare, gli Emirati arabi uniti (Abu Dhabi e Dubai su tutti) da cui provengono il 32% dei visitatori (poco più di 300mila persone) seguiti da Arabia Saudita, Qatar e Bahrein. È una clientela facoltosa che è uscita fuori dalle rotte dell’affinità culturale perché da tempo ha cominciato a condividere con l’Occidente alcuni gusti (consumo di alta fascia, soggiorni di lusso, ricerca dello status, estetica dei luoghi). Si stima che nel corso del 2025 saranno 964mila gli arrivi dal Medio Oriente che si distribuiranno in Italia, con una particolare inclinazione verso le città d’arte e questa tendenza al rialzo ha fatto registrare nell’ultimo quinquennio il segno più a doppia o tripla cifra.
Alcuni di questi nuovi segmenti turistici hanno cominciato a esplorare anche le sponde del lago di Garda tanto da interrogare gli operatori del commercio e del turismo rivano, abituati al rigore teutonico e ad una richiesta rivolta all’outdoor. Una trasformazione radicale, sia culturale che di fruizione del territorio. C’è chi si è attrezzato perché coglie la possibilità di costruire una nuova platea, magari di nicchia, ma che andrebbe in parte a sterilizzare la discesa momentanea di quelle storiche (Germania, Olanda, Paesi scandinavi e dell’Est Europa) e chi guarda con difficoltà al cambio di paradigma perché impone una revisione dell’offerta e una negoziazione culturale. Gli inviti alla massima accoglienza si confondono con la priorità ribadita ai mercati tradizionali e con la precisazione che nessuno ente (da Trentino Marketing in giù) ha sviluppato strategie pubblicitarie nel mondo arabo. Diversa è la posizione del governo italiano che fa, invece, promozione nei Paesi del Golfo (Enit ha partecipato alla Fiera del turismo di Dubai con 8 Regioni, Visit Brescia e 38 operatori turistici) e dell’Italia nel suo complesso che gode di ottima fama sui social e sul web arabi e del miglior feedback lasciato da chi viaggia (battute Francia e Spagna).
La cautela di una parte degli operatori gardesani è soprattutto culturale e può sembrare fuori tempo. Viviamo in società in cui la componente migratoria arabo-islamica è assai forte e dove le negoziazioni dell’identità e di nuove culture non sono un elemento inedito. Dalla questione alimentare (la macellazione halal, per esempio) a quella di fede (con l’organizzazione di centri culturali o la codificazione del velo) per varcare le soglie delle scuole, sono numerose le occasioni di confronto e mediazione. Però l’Islam, nel suo complesso, pone sempre molti problemi di ricezione all’Occidente. Evidentemente anche quello facoltoso che si sposta per viaggiare e non per migrare.
Il mondo islamico è un retaggio di stereotipi radicati nel tempo e di tratti peculiari che interrogano l’universo dei valori illuministi. Nel primo caso il rapporto tra società e religione, spesso letto in modo assoluto, ha condotto ad un’idea di preminenza della fede che non c’è. Come ha sottolineato l’islamologo Massimo Campanini ne «La politica nell’Islam», semmai è sempre stato vero il contrario: la politica ha strumentalizzato la religione a fini di consenso e di organizzazione sociale. Non è dissimile dall’uso dell’elemento sacro nelle società occidentali che condiziona ancora alcune questioni sensibili (il fine vita, per esempio).
L’Occidente è poi il tempio della modernità. E la modernità è stata costruita sul capitalismo e, prima ancora, nella rivoluzione industriale che il mondo arabo non ha conosciuto, rimanendo ancorato al commercio. Le fortune dei Paesi del Golfo si fondano quasi tutte sul petrolio – che noi acquistiamo – con una distribuzione della ricchezza che fa impallidire le disuguaglianze occidentali. Lo sviluppo economico è uno dei temi fondanti del mito della superiorità d’Occidente che condiziona l’immaginario collettivo.
La relazione di genere è, invece, un discorso aperto, per nulla immobile, che presenta molte differenziazioni nel mondo islamico. I Paesi del Golfo sono, tra quelli ad alto reddito, i più indietro sulla parità, dietro anche alla Tunisia – per esempio – che conosce storicamente nelle donne una componente sociale trasformativa. Sul velo, elemento simbolico del dibattito pubblico, e sponda dei ragionamenti sulla subordinazione del femminile al maschile, non basterebbe un trattato per esplorarne anche le valenze politiche che gli ha assegnato la contemporaneità. Ma rimane per la maggior parte degli sguardi occidentali una barriera invalicabile.
Il dibattito nell’Alto Garda sembra essersi concentrato su questi aspetti – a chi rivolgersi nella famiglia? Quali coordinate alimentari inserire? Come gestire la preghiera degli osservanti? – perché la quotidianità irrompe chiedendo risposte e prassi. Anche se il Trentino, in questo momento, possiede solo alcune caratteristiche ricercate dal turista arabo, difficilmente potrà rimanere indifferente rispetto ai suoi primi approcci. Non dipende nemmeno più solo dalle strategie del governo turistico della Provincia o degli enti preposti perché influencer, social e informazione digitale sempre più spesso diventano epicentro di opzioni di viaggio.
Nel tempo delle interdipendenze economiche e culturali, che rimane tale al di là dei sovranismi, e di capitali che viaggiano senza frontiere il tema non è l’accettazione dei nuovi flussi, ma la costruzione di un percorso che non sia solo estemporaneo e che, attraverso la mediazione e la proposta culturale, avvicini mondi che qualcuno percepisce ancora remoti. Problematizzare correttamente la questione, senza scivolare in una rappresentazione superficiale e senza indulgere nel politically correct (che è sulla bocca di chi non è mai chiamato a negoziare), può diventare un momento di crescita per tutti. Edward Said, in «Covering Islam», osservava che «ogni volta che un musulmano si pronuncia sull’Occidente o un americano sull’Islam, inevitabilmente entrano in gioco enormi generalizzazioni che, sebbene rendano possibili forme di scambio, allo stesso tempo ne impediscono altre. Le definizioni sono ideologiche, cariche di forti emozioni e, rimanendo intatte nel corso dei secoli, sono state capaci di adattarsi al mutare degli eventi e delle situazioni». Smontare, dunque, queste definizioni è l’unico passo verso una differente comprensione reciproca.
l'editoriale
L’ascensore sociale si è rotto
di Gianluca Salvatori
Il sentimento più diffuso, specie nei Paesi a reddito più alto, è che si sia rotto il sistema che aveva consentito ad una maggioranza di elevare costantemente la propria condizione sociale ed economica. Con il rischio concreto, per qualcuno è già una certezza, che la posizione nella scala sociale nel prossimo futuro non possa che peggiorare
l'edioriale
Giovani e disagio, la fatica di crescere
di Maria Prodi
Difficile per gli adulti capirli, perché per insinuarsi nella dimensione di queste vite dovrebbero abbandonare le proprie coordinate e infilarsi nelle bolle social in cui si si dipanano esistenze sbilanciate fra il reale ed il virtuale