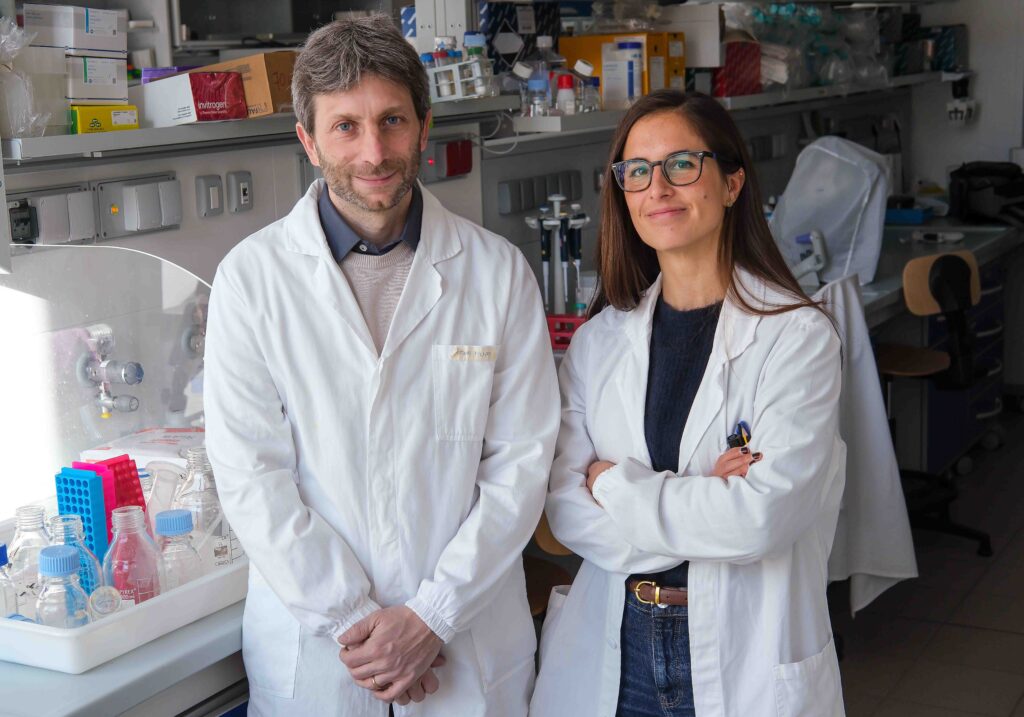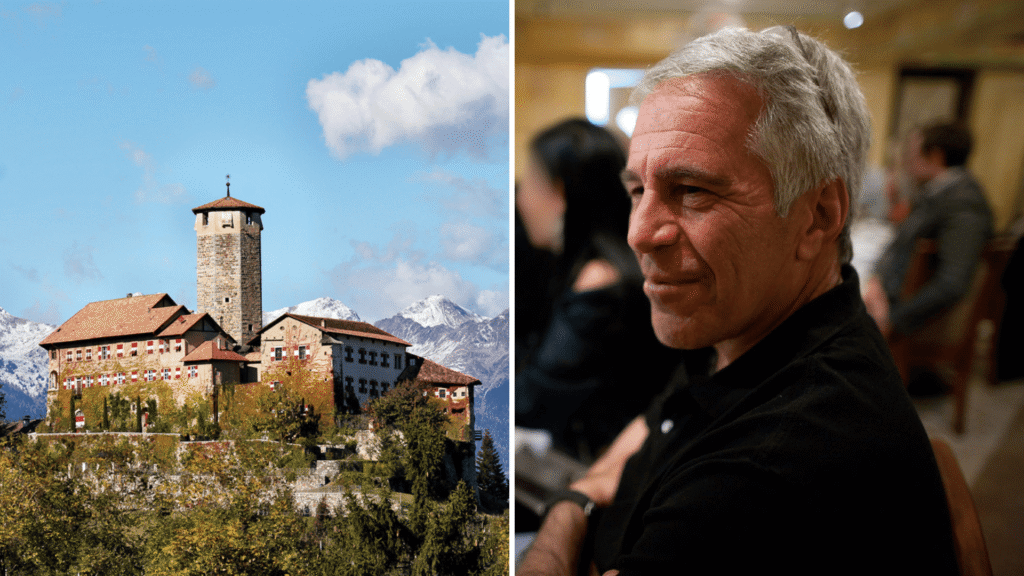Le testimonianze
domenica 7 Dicembre, 2025
Dalla Libia all’Italia, il viaggio dei ventenni del Darfur: «Vogliamo un Paese che non ci ammazzi»
di Lucia Ori
La testimonianza di due profughi sudanesi all’evento di Emergency e Università

«Per ora ci basterebbe vivere in un paese dove non vogliono ammazzarci o incarcerarci». È la frase che Luca Radaelli, responsabile delle risorse umane della divisione Search & Rescue di Emergency, si è sentito dire da due fratelli sudanesi soccorsi dalla nave Life Support nel Mediterraneo centrale. Originari del Darfur, hanno attraversato a piedi il Sudan fino a Khartoum e poi l’Egitto. «Se ne sono andati perché agli egiziani non piacciono le persone nere, venivano picchiati spesso» racconta Radaelli. La Libia non è stata un approdo sicuro: «Appena arrivati, la polizia li ha fermati e picchiati, portando via i passaporti, poi li hanno arrestati per mancanza di documenti. Sono rimasti in carcere senza un motivo preciso finché, un giorno, non sono stati liberati: le detenzioni arbitrarie in Libia sono parte di un gioco politico che ci riguarda». Quando finalmente si sono imbarcati, non sapevano se sarebbero arrivati vivi in Italia. E quando la Life Support li ha raggiunti, un’unica e sola consapevolezza: non troveranno pace neanche qui. E hanno solo vent’anni.
Da questa realtà prende avvio la conferenza «Life Support: migrazioni, salvataggi in mare e geografie del Mediterraneo», organizzata dal professor Nicola Gabellieri all’interno del corso di Geografia della sostenibilità e della cooperazione dell’Università di Trento, con ospiti principali Radaelli ed Enrica Manna, giornalista di Repubblica e collaboratrice de L’Espresso, che durante una missione sulla Life Support ha realizzato il podcast Linea d’acqua, raccontando la quotidianità dei salvataggi in mare.
«Le Ong esistono per colmare vuoti strutturali che lo Stato o il pubblico non sono in grado di garantire. In questo caso parliamo del vuoto lasciato dall’operazione Mare Nostrum, smantellata per un’asserita mancanza di fondi. Emergency basa il proprio lavoro sul riconoscimento dei diritti dell’essere umano: primo fra tutti, il diritto alla vita e alla protezione delle persone che intraprendono una delle rotte più mortali del mondo» racconta Radaelli. Dal 2014 al 2024, nel Mediterraneo centrale sono morte oltre ventiseimila persone, cifra che rappresenta probabilmente una stima al ribasso. «Basterebbero i numeri a smontare le dichiarazioni propagandistiche che accusano le Ong di incentivare le traversate: considerando tutte le navi di soccorso insieme, non si intercetta nemmeno il 10% delle imbarcazioni che attraversano il mare» aggiunge.
Il lavoro di soccorso è complesso e richiede coordinamento sanitario, logistico e comunicativo. A bordo della Life Support operano 29 persone, di cui 20 membri dello staff tecnico e sanitario, affiancati da mediatori culturali e personale di coperta. Ogni ciclo operativo è preceduto da sessioni di training e simulazioni per replicare la pressione di un intervento reale. La nave si muove verso le aree Sar – Search and Rescue – in acque internazionali, suddivise in zone di responsabilità degli Stati costieri, e una volta nell’area entra nella fase di watch: pattugliamento costante con visual scan a 360 gradi, seguendo pattern prestabiliti e incrociando le informazioni di Alarm Phone, velivoli civili o segnalazioni informali.
Quando viene identificata un’imbarcazione in pericolo, si attiva la procedura di intervento: la nave principale riduce velocità e cala i Rhib (Rigid Hull Inflatable Boats), gommoni veloci attrezzati per il soccorso che trasferiscono i naufraghi in sicurezza sulla nave. Qui comincia la post-rescue assistance: triage medico, cure immediate, distribuzione di cibo e acqua, vestiti asciutti, supporto psicologico e mediazione culturale. A bordo vengono accolti anche bambini e neonati, spesso in condizioni di ipotermia o disidratazione.
Le difficoltà non finiscono con il salvataggio: «L’assegnazione sistematica da parte della guardia costiera di porti lontani non serve a ‘liberare i porti del Sud’, come viene dichiarato» spiega Manna. «Serve ad allungare le tratte, rallentare il soccorso e rendere più difficile il lavoro umanitario». È una strategia che si somma alla disumanizzazione del discorso pubblico: trasformare l’immigrazione in una minaccia, oscurare le storie delle persone, ridurre tutto a numeri. «Salvare vite non dovrebbe essere divisivo» aggiunge la giornalista. «Divisivo è l’uso politico che si fa di queste vite».
Eppure, le storie continuano a emergere, dure e nitide. Sulla nave, racconta Manna, c’è una parete con una grande mappa. È lì che molti naufraghi si fermano a guardare il proprio percorso e a dare una dimensione allo spazio percorso: Etiopia, Eritrea, Darfur, Centrafrica. Il punto cieco di quasi tutti è la Libia: mesi di violenze, carcerazioni arbitrarie, estorsioni, famiglie ricattate. Una donna ha raccontato di aver bevuto benzina pur di sopravvivere.
Resta allora una domanda di fondo: che cosa significa testimoniare? Per Manna è il senso del giornalismo: «Decidere cosa raccontare è una scelta politica, si tratta di illuminare ciò che viene distorto o dimenticato». Per Radaelli, testimoniare è continuare a fare il proprio lavoro, nonostante i venti poco favorevoli. Ma il mare restituisce una verità semplice: la migrazione non è il problema della nostra epoca, è la storia dell’umanità intera.