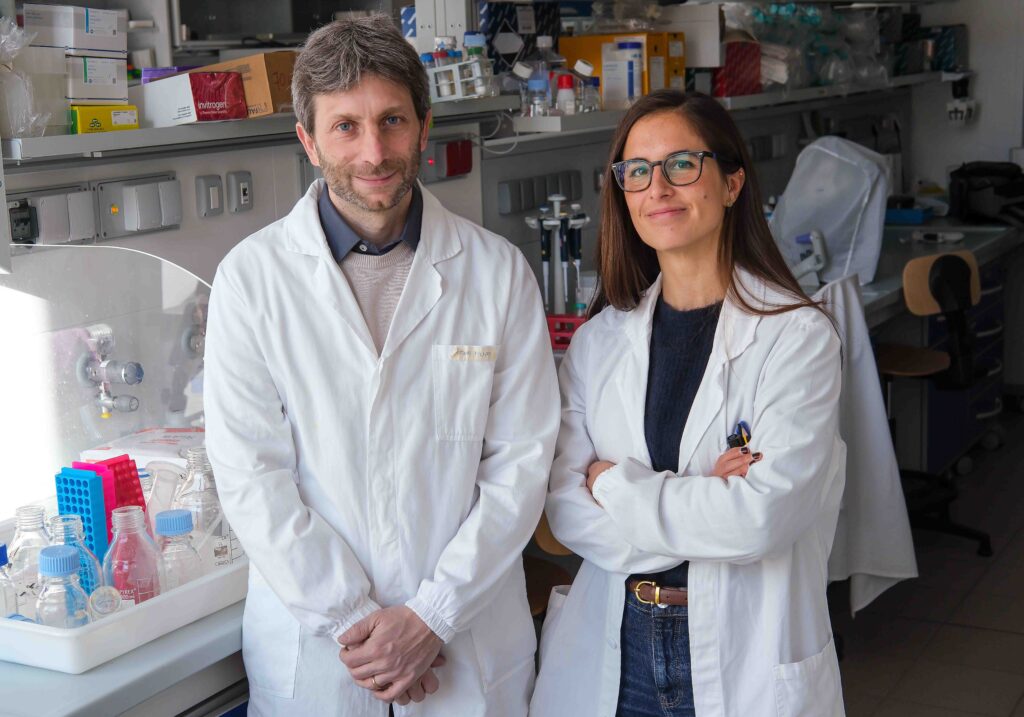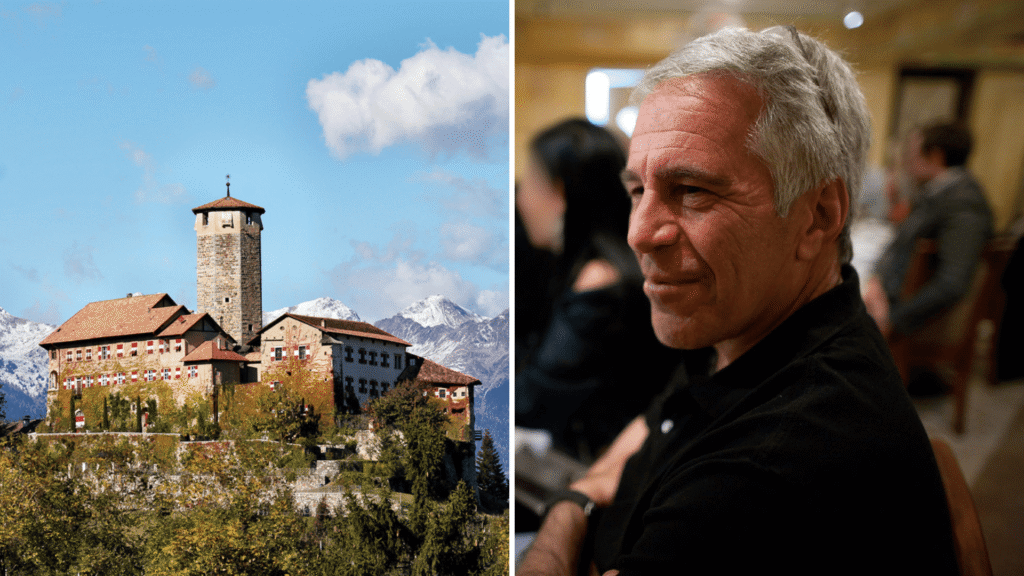L'editoriale
giovedì 22 Gennaio, 2026
Da dove nasce il trumpismo
di Francesco Barana
Tutte le «partite» sullo scacchiere globale sono correlate alla lotta per le risorse: in questo scenario il presidente degli Stati Uniti in declino è un interprete radicale di un cambiamento drastico, non la sua causa

Si sprecano gli alti lai per la crisi del diritto internazionale. Guerre, duelli geopolitici, prove di forza: dall’Ucraina al Medio-Oriente, dal regime change in Venezuela a quello ipotizzato in Iran. Per tacere della Groenlandia, che ora pare essere il centro (geopolitico) di gravità permanente. È saltato tutto, si è sciolta ogni impostazione precedente, si è frantumato il mondo che abbiamo conosciuto negli ultimi 80 anni. Il diritto è stato soppiantato dalla forza. Ma perché? Dipende principalmente da due fattori.
Uno «esterno» – il declino degli Stati Uniti come fulcro occidentale e caposaldo del blocco globale dominante; un crepuscolo coinciso con l’emergere di Cina e Brics e i moti di rivalsa del secondo tempo della democratura putiniana in Russia – e l’altro «endogeno» agli Stati occidentali, con l’affermarsi al loro interno dei populismi-sovranismi (ergo i vecchi nazionalismi solo un po’ riverniciati). Dal Dopoguerra al 1990, quindi fino al crollo del Muro di Berlino e dell’Unione Sovietica, il mondo era suddiviso in due blocchi – Usa e Urss – che, pur in contrasto, fungevano da reciproco punto di riferimento e si riequilibravano dentro il meccanismo della «guerra fredda». Il blocco occidentale guidato dagli Stati Uniti era costituito da democrazie autenticamente liberali, memori dei disastri della Seconda Guerra Mondiale e dei totalitarismi della prima parte del ‘900. Morto il comunismo, dal 1990 e per un decennio l’equilibrio è stato garantito dal predominio americano, con la Russia frastornata di Eltsin e del primo Putin che si leccava le ferite inferte dal crollo dell’Unione Sovietica.
Dal 2000 è cominciato a cambiare tutto: sul piano economico ecco l’affermarsi prepotente della Cina (e poi il formarsi del cartello dei Brics), corroborato dal revanscismo nazional- militare della Russia del secondo Putin. Da allora i vecchi blocchi sono andati via via scemando e gli Stati Uniti, non più egemoni, hanno cominciato a sentirsi minacciati. Attenzione siamo anche nel periodo dell’attentato di Al Qaeda alle Torri Gemelle (2001) e dell’avanzare del turbocapitalismo della globalizzazione (contrastato in quel periodo dai movimenti «no global» di Seattle), che ha l’epicentro dei suoi effetti negativi nella crisi finanziaria del 2008. È in questo periodo che, mentre la Cina si rafforza, le democrazie occidentali si affievoliscono tra diseguaglianze economiche e sociali e il formarsi dei nuovi populismi nazionalisti, che sfruttano politicamente le nuove sacche di povertà e indicano nell’immigrazione, soprattutto islamica, il nemico.
Un processo che si palesa in tutta la sua forza oggi: non a caso tutte le «partite» che si stanno giocando sullo scacchiere globale sono correlate alla lotta per le risorse (petrolio, terre rare, rotte commerciali) proprio tra Cina-Russia-Brics da una parte e gli Usa dall’altra, i quali nel frattempo cercano nuovi partner tra i regimi del Golfo e lasciano campo libero a Netanyahu in Medio-Oriente. Con la sfida finale sullo sfondo, che è tutta finanziaria: il controllo dei circuiti digitali delle carte di credito, la cui centralità oggi è dei canali americani, ma con Cina e gli altri Brics che sono all’opera per crearne di alternativi.
In questo scenario, è intuibile capire i perché dell’aggressività americana (il cui carattere predatorio è insito nella sua storia e nascita, chiedere ai «nativi»…): aggressività che a dire degli States non era necessaria nel mondo «di prima», quello in cui erano egemoni e garanti dell’ordine, ma che lo è oggi per sconfiggere la minaccia. E Trump è solo un interprete radicale di questo cambio di atteggiamento, non la causa. Come ha detto Lucio Caracciolo, direttore di Limes, in un’intervista a questo giornale: «Se fosse stata presidente Kamala Harris, pur con altri metodi, nella sostanza non credo avrebbe agito diversamente». È chiaro però che il demagogo Trump è l’attore perfetto per sdoganare con metodi spicci questa aggressività.
E qui veniamo al secondo motivo della crisi del diritto internazionale: il riaffermarsi dei populismi-sovranismi come metodo politico per intercettare il consenso. Un fenomeno favorito, dicevamo, sia dal pericolo dell’estremismo islamico (dopo Al Qaeda, i numerosi attentati dell’Isis in Occidente) che dagli effetti sociali della globalizzazione economica. Si acuiscono le diseguaglianze e non c’è freno all’immigrazione incontrollata e irregolare, e così – in assenza di proposte dei partiti più liberali e riformisti (a destra come a sinistra) – il «popolo» sfoga la sua frustrazione e solitudine votando il politico demagogo di turno, capace di manipolare pro domo sua queste (comprensibili e legittime) fragilità.
Politicamente, tuttavia, è acclarato che il populismo sovranista apre il terreno alla conflittualità, perché per esso il rapporto tra classe politica e opinione pubblica, tra potere e cittadini, si fonda su un meccanismo plebiscitario e verticale, alto e basso. Il cittadino s’identifica con il potente (il quale gli fa credere di essere come lui) e gli dà carta bianca. Il potente per ravvivare questo rapporto totalizzante e fideistico deve alzare continuamente la posta, additare un nemico, indicare un credo, quasi sempre nazionalista e identitario. Da lì è un passo arrivare alle minacce, agli ultimatum, ai conflitti. E a frantumare il diritto internazionale.