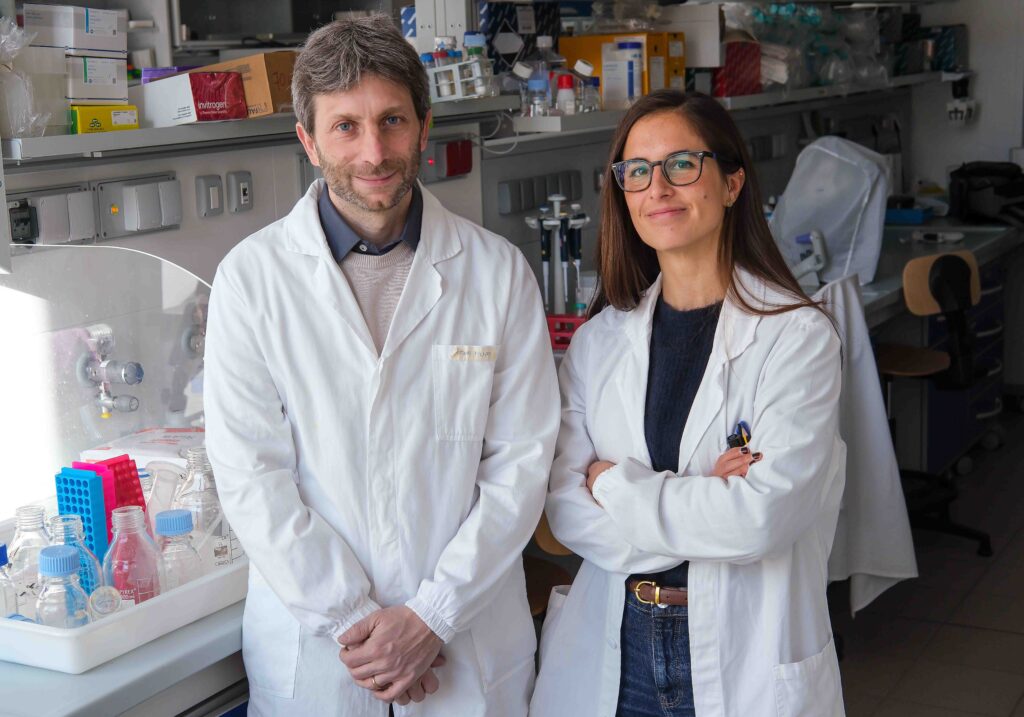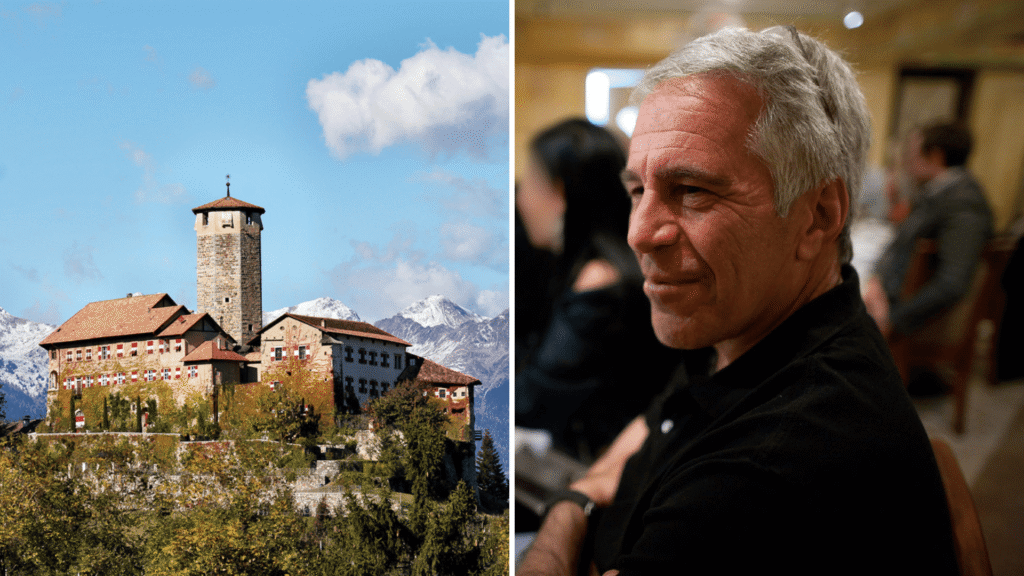L'editoriale
martedì 26 Agosto, 2025
«Mia moglie», anche una foto può diventare violenza a tutti gli effetti
di Elena Pavan*
«Perché stupirsi del fatto che siano stati i compagni di queste donne ad agire questa violenza? La maggior parte dei femminicidi avviene in famiglia»

Qualche giorno fa, Meta ha chiuso la pagina Facebook «Mia Moglie». Dal punto di vista tecnico, «Mia Moglie» era un gruppo pubblico con circa trentaduemila membri aperto sei anni fa ed esplicitamente dedicato a condividere e commentare foto di mogli, fidanzate, amanti, partner. Nella pratica, era uno spazio nel quale avvenivano centinaia di casi al giorno di violenza sessuale attraverso immagini.
Mi ha particolarmente impressionata lo stupore con il quale è stato accolto il post Instagram della scrittrice Carolina Capria che ha reso virale la questione. Di gruppi come «Mia Moglie» ce ne sono stati e continuano ad essercene un numero impressionante (sono oro per le piattaforme digitali!) e sopravvivono nonostante si prendano provvedimenti come ha fatto Meta. Chiudere una pagina in casi come questi causa giusto qualche fastidio a individui abituati alla transumanza digitale ogni qualvolta non è più possibile abusare e molestare liberamente chiunque vogliano.
Ad ogni modo, ci sono due elementi che ricorrono costantemente nei commenti e nei contenuti circolati sul caso e che sembra spieghino questo stupore collettivo. Primo: che a postare siano stati i mariti, fidanzati, amanti, partner delle donne nelle foto o, quantomeno, persone che hanno tutto l’interesse ad essere pubblicamente percepiti come tali. Mi chiedo: perché stupirsi del fatto che siano stati i compagni di queste donne ad agire questa violenza? Ricordiamoci che la maggioranza dei femminicidi avviene per mano di partner attuali o passati (lo dicono i dati del Ministero dell’Interno). La verità è che c’è ancora molta difficoltà a riconoscere la violenza di genere in tutte le sue forme e per quello che realmente è: un elemento sistemico che persiste anche (soprattutto) per mano di uomini con cui condividiamo le nostre quotidianità.
Il secondo elemento che concorre allo stupore collettivo è che questi «mariti» abbiano condiviso queste foto «senza consenso». In questi anni, abbiamo preso più confidenza con il concetto stesso di consenso. Tuttavia, siamo ancora molto lontani dall’aver realmente compreso che esso gioca un ruolo dirimente nelle relazioni affettive, intime e sessuali nello stesso modo in cui, per esempio, permette di distinguere un atto legittimo come un prestito da un abuso come un furto. Per cui, sì, parliamo di consenso – ne abbiamo bisogno. Però, per favore, non parliamone così.
Nell’epoca del «tutti insieme appassionatamente contro la violenza di genere» e «le donne hanno il diritto di dire di no», richiamare in modo generico l’elemento del consenso innesca un nuovo e subdolo meccanismo di giustificazione.
Esattamente, a che cosa avrebbero dovuto acconsentire queste donne? Ad essere date in pasto dai loro compagni al branco di «Mia Moglie»? A rinunciare alla loro intimità – una sfera che va ben oltre quella della sessualità – ed essere valutate per quanto riescono a solleticare le pulsioni sessuali di chicchessia anche quando escono dalla doccia a fine giornata, prendono il sole al mare, si cambiano d’abito o dormono sul divano in mutande? E come avrebbero dovuto dare questo consenso? Dicendo esplicitamente sì o non dicendo no? Firmando un modulo? Dopo aver letto un’informativa dettagliata? E, per assurdo, una volta concesso, questo consenso si sarebbe potuto anche ritirare? Vi prego, non scherziamo.
È veramente pericoloso discutere in maniera generica di consenso solo perché abbiamo ancora bisogno di una scusa per decretare che ciò che accade dentro «Mia Moglie» è inaccettabile. Il problema non è che «le mogli» non abbiano acconsentito. Il problema, semmai, è che a chi frequenta gruppi come «Mia Moglie» (ma anche i bar, le piazze, le case) non importa nulla se «le mogli» sono consapevoli e d’accordo con quanto sta loro accadendo. È proprio questa cultura patriarcale, la convinzione di poter fare delle donne ciò che si vuole – soprattutto quando le si considera una proprietà in virtù di una relazione intima – che permette alla violenza di genere di mettere radici profondissime e difficilissime da estirpare.
Bene che si parli di violenza di genere e bene che si guardi dentro le forme che questa assume negli spazi digitali perché è veramente dura a morire l’idea che «siccome è solo una foto» non si tratta di violenza. Però, per l’ennesima volta, l’invito è a fare uno sforzo in più. Per assurdo, se il gruppo si fosse chiamato «Tua Moglie» non avremmo visto trentamila camerati scambiarsi le loro donne ed azzannarle come se fossero pezzi di braciola. Avremmo visto trentamila mariti incazzati dirsi le peggio cose (scommetto: prima di tutto insultando le rispettive mogli). Tristemente, si sarebbero incazzati per la ragione sbagliata.
*Professoressa associata di Sociologia generale all’Università di Trento