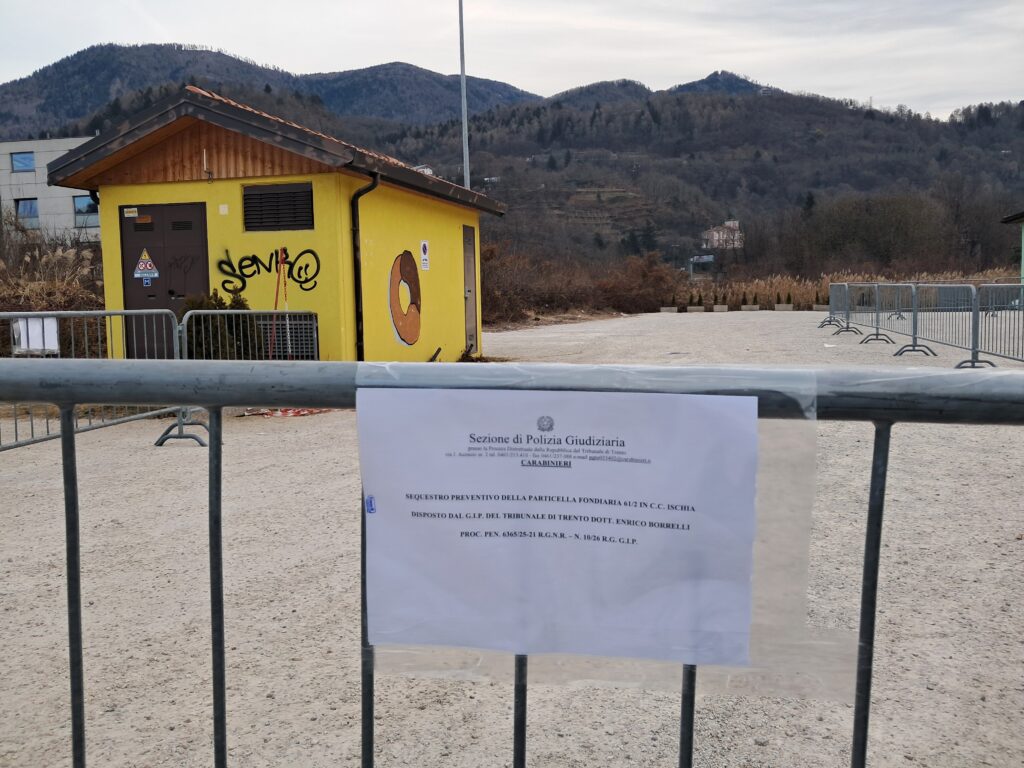L'editoriale
lunedì 29 Dicembre, 2025
La Spoon River dei senza casa
di Simone Casalini
Il diritto alla casa vive una fase di recesso e paradossi: così si inceppano alcuni meccanismi essenziali di funzionamento dell’Autonomia

Marwa, suo marito e i due figli soggiornano in venti metri quadrati. Un piccolo presepe con cucina e letti a castello incorporati e solo il bagno separato (e cieco). La bicicletta, indispensabile mezzo di trasferimento, è spesso il quinto inquilino perché non può essere esposta al rischio di una sottrazione. Pagano 500 euro di affitto, avrebbero la possibilità di spendere di più, ma il mercato non è semplice per gli «stranieri».
Sarah, la casa, non ce l’ha proprio. In compenso ha un lavoro nella cucina di una mensa. Vive per strada, riposa in un dormitorio pubblico. La precedente occupazione l’ha persa proprio perché non ha un luogo né spazi dove pianificare la sua esistenza. «Non riuscivo ad arrivare in tempo». Sarah ha due bambini che vede a singhiozzo per la precarietà della sua condizione di vita.
Lorenzo, studente universitario di 21 anni, non ha una casa ma una stanza. Otto metri quadri a 500 euro al mese. Un letto, un appendiabiti, una scrivania a scomparsa. Niente poltrona perché quella è un optional di lusso: 40 euro aggiuntivi mensili. Resistere è il passe-partout per costruire un futuro con lo studio.
Giuliana, 29 anni, laureata, ha appena vinto un concorso. Il «posto fisso» all’Agenzia delle entrate nella provincia prescelta: il Trentino. I ricordi d’infanzia, delle vacanze in Val di Fassa, si mescolano con la valutazione dell’età adulta. «Ho cominciato a cercare un’abitazione, un monolocale in periferia costa mediamente 800-900 euro. Se ci avviciniamo al centro saliamo sopra i mille. Considerato lo stipendio e le spese di trasferimento ho compreso che non era sostenibile». Giuliana non prenderà servizio in una delle sedi dell’Agenzia delle Entrate del territorio.
Le cronache pubblicate su «ilT» in questi ultimi tre anni traboccano di storie come queste. Potremmo proseguire, quasi all’infinito, nella Spoon River dei senza casa o di quelli che ce l’hanno ma non è inclusa la dignità. Il diritto alla casa, riconosciuto come diritto sociale primario dalla Corte costituzionale e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, sembra vivere una fase di recesso e di paradossi. Eroso dalle rendite, impiegate per generare redditi più generosi (con il turismo, soprattutto, e con gli universitari), dal fenomeno correlato delle disuguaglianze e dalla titubanza politica nel collocare la questione al centro di una serie di strategie. Anche se la Provincia ha cominciato ad investire di più con l’ultima finanziaria.
La società di oggi non è quella del dopoguerra quando Amintore Fanfani e la Dc lanciarono il piano Ina. Dal 1949 al 1963 vennero costruiti 355mila alloggi con ventimila cantieri e 41mila lavoratori impiegati all’anno. Un progetto vasto di edilizia popolare che voleva costruire le basi per il boom economico attraverso l’individuazione di una classe sociale che sarebbe poi entrata nel motore dell’industrializzazione. Un’abitazione rispettosa e migliori condizioni di vita ne costituivano la precondizione. Il Piano Fanfani nasceva da più tracce culturali: da un punto di vista economico era ispirato alle politiche keynesiane; da un punto di vista sociale si richiamava al solidarismo cristiano e alla dottrina sociale della Chiesa; dal punto di vista urbanistico (furono coinvolti i principali urbanisti e architetti del Paese) il desiderio di arrivare alla configurazione della «città pubblica». Cioè, una città a misura di comunità che, insieme a diritti individuali, soddisfacesse anche il traguardo di una società coesa. Poi, certamente, era interesse della Dc anche diramare la sua influenza nei ceti meno abbienti, proletari o piccolo borghesi.
Da giovane ricercatore dell’Università Cattolica di Milano, Fanfani fu tra i protagonisti di un’indagine (nel 1930) che poneva in connessione reddito basso e precario, costo dell’alloggio e ridotto accesso alla salute. Seppure non abbiano senso parallelismi tra l’oggi e la prima metà del Novecento, è anche difficile non scorgere che questa relazione continua a riproporsi in modo intrecciato.
La crisi della casa, nel nostro versante storico, ha molteplici inneschi e sta inceppando alcuni meccanismi essenziali di funzionamento dell’Autonomia.
Il primo è quello economico perché le imprese e l’ente pubblico perdono competenze e professionalità per l’impossibilità di accedere a prezzi corretti al mercato della casa. È essenziale anche da un punto di vista sociale perché sono flussi in ingresso che mitigano quelli in uscita di giovani (e non) che scelgono di vivere altrove. Semplificando, richiama l’attrattività di un territorio e la sua apertura a nuove cittadinanze.
Il secondo riguarda i servizi essenziali. In alcuni valli, ma anche nei centri urbani, questo si riverbera – tra gli altri – sull’istruzione, per esempio, con un turnover molto accentuato dei docenti che, appena ne hanno l’occasione, muovono verso zone più economiche o lasciano la provincia. Si crea un sobbalzo nella continuità didattica con classi che vedono sfilare di anno in anno maestri/i o professori/professoresse.
Il terzo meccanismo essenziale riguarda l’equità e il bilanciamento perché una società che ha condizioni materiali radicalmente disomogenee non costruisce prospettive, ma rischia di alimentare l’indifferenza o il rancore sociale. In una società impoverita, come quella odierna, è ancora più delicato il ruolo del pubblico come garante dei diritti e regolatore delle disfunzioni del mercato. La casa non dovrebbe occupare più del 30% del reddito di una famiglia, ma per vivere a Trento o Riva del Garda si raggiungono punte del 60%.
Da qui al 2042 Nomisma ha stimato un fabbisogno di seimila alloggi nel capoluogo, contemporaneamente ne abbiamo 5mila sfitti e 69 Piani attuativi bloccati per il mancato accordo pubblico-privato che valgono altri 5mila appartamenti. Quasi quattromila domande di accesso ad abitazioni Itea rimangono inevase, 800 sono i posti scoperti per universitari. Per le soluzioni mediane di canoni calmierati si registrano in città 40 domande ad alloggio. Dati che inquietano se solo sapessimo vivere la vita degli altri. Tutti gli strumenti messi in campo – dal Ri-Urb al Ri-Val, che porteranno 800 alloggi, al bando sulle aree spopolate – possono essere utili ma è necessaria una spinta propulsiva nettamente superiore.
Intanto stimolando una riflessione su cosa intendiamo oggi per «città pubblica» e quindi coinvolgendo professionisti che possano portare pensiero per individuare una via originale. In secondo luogo, intervenendo sul mercato degli affitti turistici che cresce in corrispondenza della progressione delle rendite immobiliari. Produce, peraltro, un’economia fragile e povera. La sensazione è che non si intenda colpire una potenziale area di consenso elettorale. In terzo luogo, occorre riproporre una politica pubblica della casa che risponda alle esigenze di dignità delle persone e alle necessità di ricchezza umana del territorio (che per l’economia e la conoscenza si traduce in competitività). Infine, correggere le regole d’ingaggio tra locatari e affittuari è un prerequisito per restituire fiducia ad una relazione entrata in crisi dove a prevalere è ora il pregiudizio. La casa è una parte della nostra vita, lo spazio della socializzazione, dell’intimità, della relazione, del riposo. È il nostro alter ego, ci assomiglia e ci cura. Non può diventare né un sacrifico né una rinuncia.
L'editoriale
Referendum giustizia, una polarizzazione che non aiuta
di Gianluca Salvatori
Entrambe le posizioni omettono nei rispettivi argomenti elementi cruciali per una scelta informata. In queste condizioni, a prescindere dall'esito per un servizio di giustizia che funzioni meglio bisognerà aspettare ancora.
L'editoriale
L’oro di Lollobrigida e la sorellanza
di Marika Damaggio
Non è solo un cronometro fermato a 3’54”280: il successo di Francesca Lollobrigida è la risposta potente a chi vede nella maternità un limite alla carriera. Dalla dedica al figlio Tommaso all'appello per una genitorialità condivisa, la campionessa trasforma il ghiaccio in uno specchio per tutte le lavoratrici