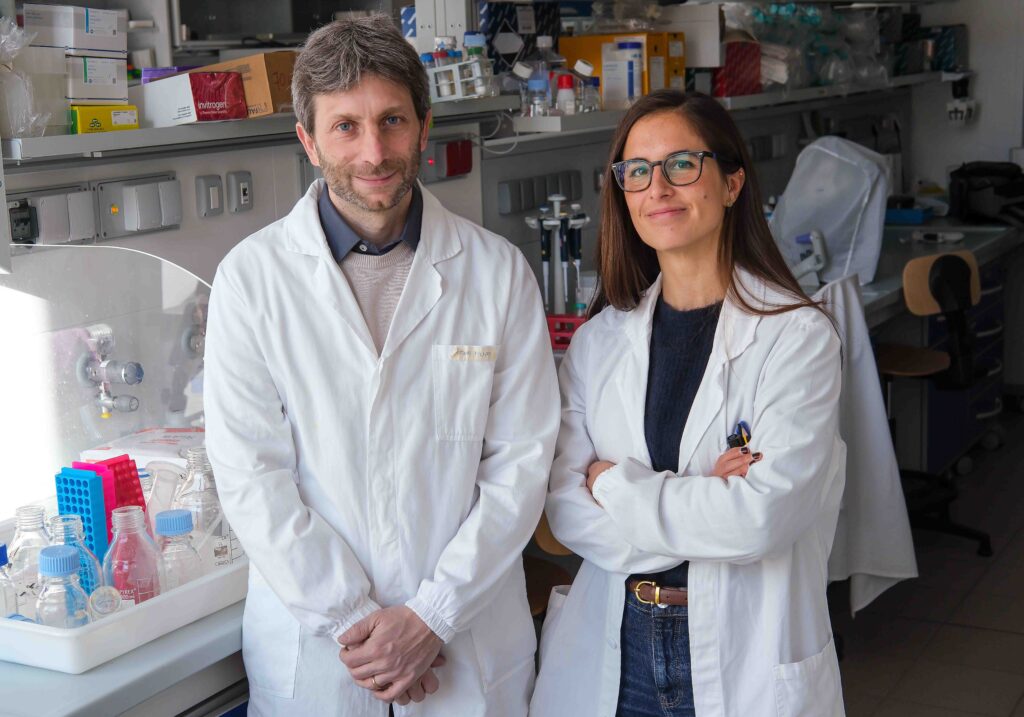L'editoriale
giovedì 28 Agosto, 2025
I sultani e il corpo delle donne
di Elena Tonezzer
A sessant'anni dal volume della sociologa Gabriella Parca, quel tipo di mascolinità denunciato non è ancora scomparso: lo dimostra il caso del gruppo Facebook «Mia Moglie»

Nel 1958 viene approvata in Italia la «legge Merlin», che chiude le case di tolleranza e introduce il reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Il 5 febbraio 1958 i due quotidiani trentini dell’epoca salutano la nuova legge nello stesso modo, non parlandone, ma concentrando l’attenzione solo su un aspetto minore della legge, che prevedeva l’apertura della polizia alle donne. Lungo i dieci anni dell’iter legislativo, la stampa nazionale si era occupata del tema spesso ridicolizzando la senatrice socialista Lina Merlin, che invece coraggiosamente portava avanti una battaglia che scardinava un concetto basilare della disuguaglianza tra sessualità maschile (il cui esercizio andava garantito addirittura dallo Stato) e quella femminile (interpretata come servizio). Ai più accorti interpreti della società italiana non sfuggono le conseguenze più ampie che l’abolizione dei postriboli poteva avere sul piano della mentalità.
Due anni prima, Indro Montanelli pubblica «Addio Wanda», un pamphlet in difesa proprio dei bordelli, indicati come la pietra angolare su cui si basava l’ordine del Paese. E in un certo senso, suo malgrado, il conservatorismo di Montanelli vede giusto perché la legge Merlin non ha solo un effetto immediato e concreto. Chiudere i «casini» è stato un passo nella direzione di dare personalità e diritti alle prostitute, ma è stato anche molto di più perché è intervenuta sul piano culturale nel meccanismo di potere asimmetrico che regge la relazione cliente/prostituta. Un’asimmetria che rappresentava in purezza – come sul vetrino del microscopio – meccanismi che difficilmente rimanevano solo nelle stanze della «case chiuse». La legalizzazione del divorzio (1970), della contraccezione (1971) e dell’aborto (1978), sono stati altri passaggi della strada che ha assegnato alle donne italiane maggiore potere di decisione sulle relazioni e sul proprio corpo.
Sette anni dopo l’approvazione della legge Merlin, nel 1965, la sociologa Gabriella Parca pubblica un volume intitolato «I sultani», che illustra i risultati di una significativa campagna di interviste agli uomini italiani rispetto alla sessualità, al matrimonio e alla donna. Il 50% degli intervistati dichiara di avere avuto il primo rapporto sessuale con una prostituta. Secondo Parca, ai maschi italiani degli anni Sessanta «a vari scopi può servire l’atto sessuale, raramente ad esprimere affetto, tenerezza per una donna. C’è qualcosa di patologico in questa scissione completa tra sesso e sentimento, che non può addebitarsi ai singoli, perché se è così diffusa da divenire regola, costume, […] vuol dire che la società con i suoi falsi valori ha creato l’esigenza anche psicologica della donna-oggetto». Per le centinaia di maschi intervistati dalla sociologa, «la donna è vista senza personalità autonoma, con proprie esigenze e propri diritti: in fondo è una cosa, che non appartiene a sé stessa ma al suo padrone».
Sono passati diversi decenni da «I sultani», la cultura del rispetto delle donne è sicuramente più diffusa, il tipo di mascolinità che emerge da quel volume è meno forte, meno legittimo, ma non scomparso. Nel 2025, l’osservatorio nazionale «Non Una di Meno» conta già 60 femminicidi: troppi, soprattutto perché le donne che rischiano di entrare in queste statistiche sono molte di più. Se il femminicidio è l’epilogo più tragico di una storia di violenza, le forme della mascolinità tossica e i gradi con cui questa si può manifestare sono innumerevoli.
Il caso del gruppo Facebook «Mia moglie», in cui venivano scambiate e commentate fotografie intime di donne la maggior parte inconsapevoli, apre una botola su uno spazio culturale che ci riporta alla mentalità degli uomini intervistati da Parca. Gli iscritti erano più di 30.000, ma altri gruppi di quel genere esistevano e continuano ad esistere. Se sono comprensibili i sentimenti che possono aver provato le donne che hanno scoperto quanto stava succedendo con le loro immagini (spesso scattate a loro insaputa nelle loro case da persone di cui si fidavano), più difficile è immaginare cosa possono aver provato gli uomini iscritti una volta scoperto il «gioco», una volta che la porta del loro «spogliatoio virtuale» era stata aperta. L’idea di essere in una relazione in cui il maschio sente di potere usare le fotografie dei corpi delle proprie amiche e compagne come vuole, per esporle come trofei o alla derisione senza il loro consenso, potrebbe porre degli interrogativi anche a loro. Il numero di persone coinvolte nel gruppo «Mia moglie» segnala la diffusione tra persone qualunque, lavoratori di tutti i livelli su cui la polizia postale sta indagando, di assenza di rispetto per l’intimità dei corpi di donne e ragazze interpretate come oggetti. Dalla scoperta di comportamenti di massa come questo potrebbe derivare l’occasione per discutere, anche tra chi non è direttamente coinvolto, di quanto successo per costruire insieme una pratica sentimentale più sincera e rispettosa.
*Ricercatrice della Fondazione Museo storico del Trentino