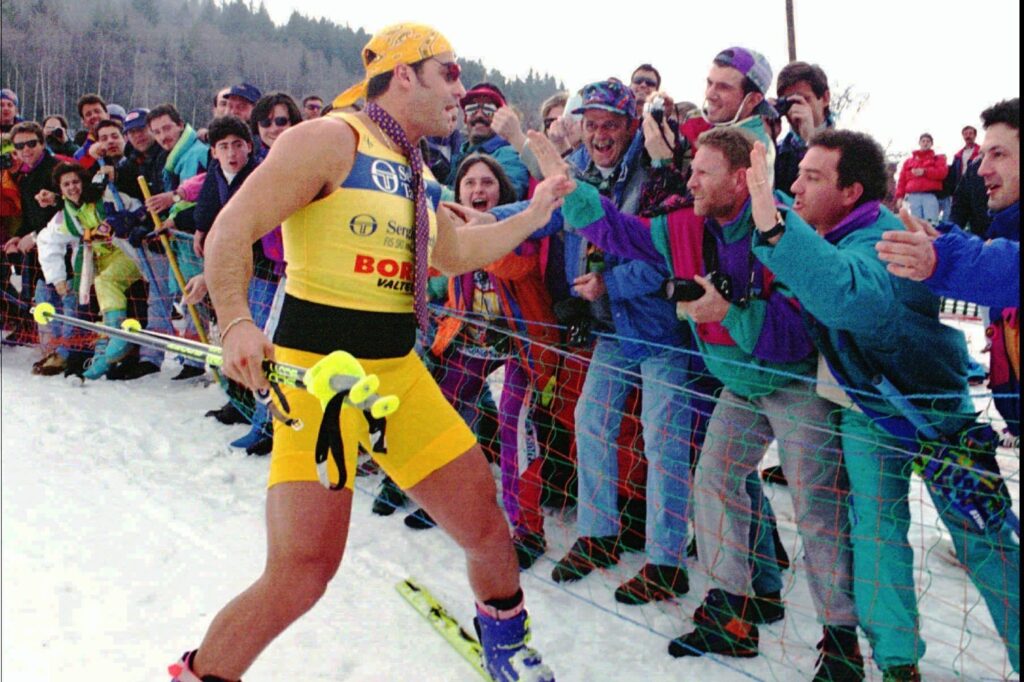L'editoriale
venerdì 29 Agosto, 2025
I powwow dei nativi americani
di Claudio Ferlan
Storia, caratteristiche e significato dei grandi raduni interindiani, testimonianze dell'identità come un processo vivo capace di allargarsi

Negli Stati Uniti, i popoli nativi rappresentano il 2% della popolazione, ma meno dello 0.5% delle notizie nei principali media li riguarda. Quando vi compaiono, succede spesso attraverso stereotipi: rappresentazione della povertà (magari per vuoto sentimentalismo da clickbait), dispute legali sulle terre, immaginario da Far West in occasione di ricorrenze. A tentare di colmare questo vuoto ci pensano alcuni media specializzati, come Indian Country Today (ICT), testata no-profit che dal 1981 fa giornalismo «dai nativi, per tutti».
Con reportage sulle battaglie per i diritti, articoli dedicati all’arte contemporanea e a storie della quotidianità indigena, ICT è diventato un faro per chi crede che l’autonarrazione sia un fondamentale antidoto all’oblio. Il legame tra tradizione e modernità è al centro della «Powwow Guide 2025», pubblicata a inizio estate proprio da Indian Country Today. L’etimologia del termine «powwow» ci porta direttamente al cuore della sua trasformazione. Derivato dalla parola algonchina pauau o pau-wau, che originariamente indicava un raduno di leader spirituali, il termine fu distorto dai colonizzatori europei che lo applicarono a qualsiasi riunione indigena. Oggi le comunità native si sono riappropriate del termine, restituendogli il significato profondo di incontro comunitario interindiano. Si tratta di eventi non religiosi che durano qualche giorno, incentrati sul canto e sulla danza, in cui possono essere coinvolte poche decine di membri di una comunità o migliaia di appartenenti a popoli diversi. Come nota la guida 2025 di ICT, «powwow è diventato un verbo attivo: non si partecipa, si ‘fa’ powwow, perché è un processo che coinvolge corpo e spirito».
La guida elenca 170 eventi organizzati in tutto il Nord America (Stati Uniti e Canada), accompagnati da storie come quella dell’uomo omaha (nazione oggi principalmente residente in una riserva compresa tra Nebraska e Iowa) che insegna al figlio a suonare il tamburo in un garage di periferia, o dell’animatore cowlitz (nordovest degli Stati Uniti) Joey Clift che ridisegna i raduni con gli occhi di un bambino. La guida include tutorial sulle differenze tra stili di danza – il fancy dance dinamico maschile e il jingle dress terapeutico femminile – ricette che mostrano l’evoluzione della cucina powwow, dai piatti tradizionali ai food truck fusion, e approfondimenti su come i giovani usano i social media per organizzare «flash mob powwow» nelle città.
I decenni recenti hanno segnato una svolta per le nazioni indigene negli Stati Uniti e in Canada: lingue riportate in vita, economie in ripresa grazie a vittorie legali storiche, e soprattutto, il tramonto definitivo del mito assimilazionista, secondo il quale l’unico modello di sopravvivenza delle culture native era la loro adesione al modello dominante, importato dai colonizzatori dell’Europa a partire da cinque secoli fa. Al suo posto, è fiorita un’identità panindiana, capace di tenere insieme diversità e unità. E se c’è un luogo/momento dove questa identità prende forma, ebbene, questo è proprio il powwow.
Il powwow moderno affonda le radici in due tradizioni distinte: le danze delle Pianure del XIX secolo e i raduni intertribali nati nelle riserve durante l’epoca delle politiche assimilazioniste di inizio XX secolo. Soppressi dal governo statunitense nel 1883, questi raduni riemersero nel primo Novecento come atto di resistenza silenziosa. La vera esplosione avvenne però dopo gli anni Sessanta del secolo scorso, parallelamente al Movimento per i diritti civili e alla nascita dell’identità panindiana.
Entrare in un powwow odierno significa immergersi in un microcosmo complesso. Non esiste un format rigido: gli Irochesi orientali vi inseriscono la Smoke Dance, originariamente danza di guarigione, ora adattata ai tempi contemporanei, ma sempre legata alla medicina tradizionale. Altri introducono nuovi balli, sperimentando fusioni hip-hop. La struttura dei powwow del Terzo Millennio è divisa tra danze sociali aperte a tutti e competizioni formali con premi in denaro. Si trascorre il tempo in compagnia, cantando e ballando sì, ma anche condividendo il cibo e i racconti di vita. Succede anche che si presentino candidati alle elezioni tribali, si raccolgano fondi per chi è in difficoltà, si tenga insomma viva una memoria che altrove rischia di sbiadire. Secondo stime di ICT, i grandi powwow generano fino a cinque milioni di dollari di indotto tra artigianato, turismo e sponsorizzazioni. Ma il cuore resta sempre lo stesso: performance pubbliche che celebrano l’appartenenza a una comunità più vasta, quella indiana nordamericana, con i suoi obblighi sociali e le sue battaglie.
Tommy Orange, autore Cheyenne-Arapaho, ha scelto proprio un powwow come sfondo per il suo romanzo «Non qui, non altrove» (traduzione italiana di Stefano Bortolussi, Frassinelli, 2019). Quella che Orange descrive è una «geografia emotiva» dove i personaggi ritrovano le proprie radici pur essendo urbanizzati, dove le ferite coloniali si confrontano con la resilienza contemporanea, e dove la danza diventa linguaggio comune per chi ha perso il legame con la lingua ancestrale. Questo tema ritorna nel sequel «Stelle vaganti» (Mondadori 2024, tradotto nuovamente da Stefano Bortolussi), dove il powwow funge da filo conduttore tra passato e presente, andando a esaminare traumi comuni come il massacro del Sand Creek.
A somiglianza di ogni espressione culturale viva e conseguentemente mutevole, il powwow deve affrontare dilemmi contemporanei: la commercializzazione contro l’autenticità, l’accessibilità per le comunità urbane, il bilanciamento tra competizione e spirito comunitario. Eppure, le testimonianze ricorrenti sembrano dire che il cerchio della memoria celebrato in questi incontri intercomunitari non si è spezzato. Semplicemente, si è allargato. Il powwow ci racconta una verità semplice ma rivoluzionaria: l’identità non è un reperto museale, ma un processo vivo. Come scrive Jourdan Bennett-Begaye di ICT, «quando i tamburi iniziano a suonare, anche chi è lontano per la prima volta sente di essere arrivato a casa». In un’epoca di omologazione globale, questa lezione di celebrazione della memoria volta alla costruzione di nuovi modi di stare assieme può riguardare qualsiasi cultura. Mentre i tamburi battono, i nativi nordamericani ricordano al mondo che la loro storia non è un capitolo chiuso, ma un cerchio che continua ad allargarsi, resistendo e reinventandosi senza mai spezzarsi.
*Storico del cristianesimo e ricercatore della Fbk