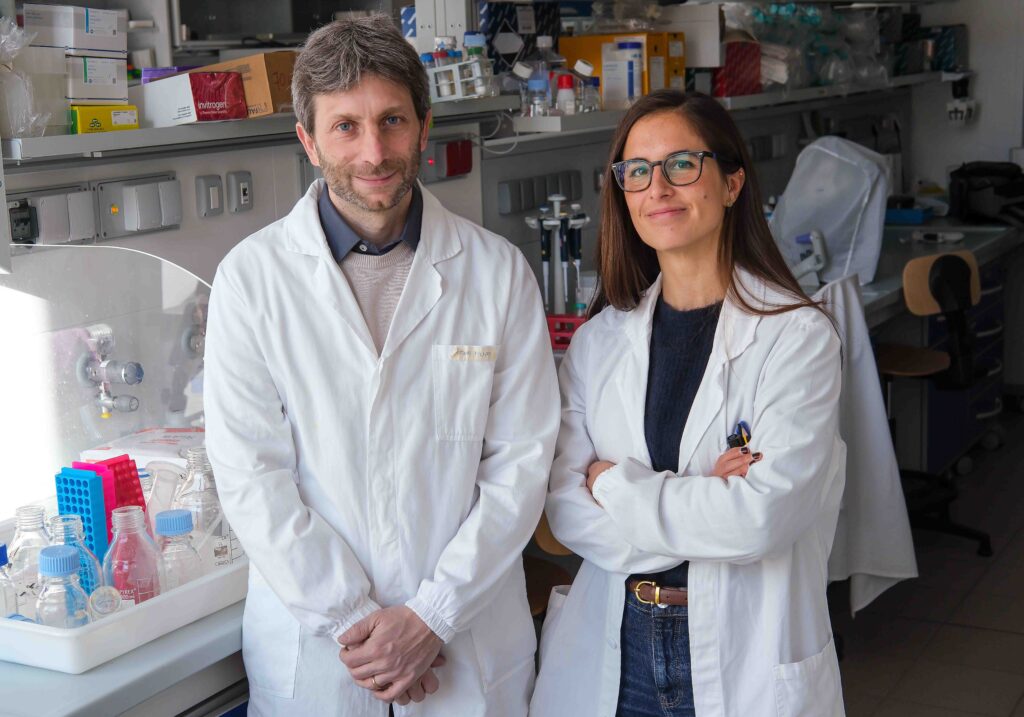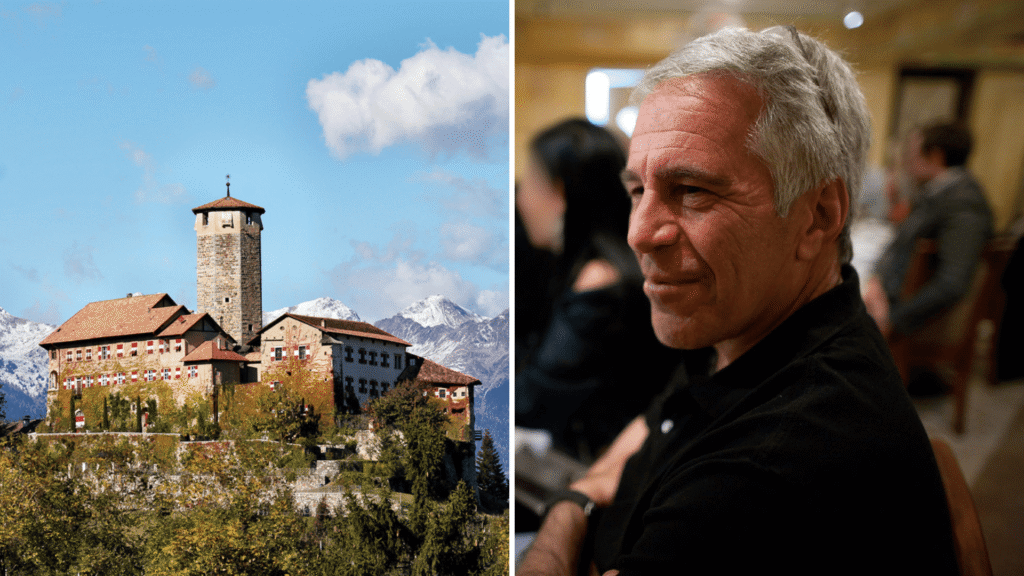L'editoriale
domenica 18 Gennaio, 2026
Clochard, questione di cittadinanza
di Simone Casalini
Il profilo dei senzatetto oggi è stato rovesciato da struttura del lavoro, carenza di alloggi e globalizzazione: il mondo economico può essere uno stimolo alla soluzione, che però passa dalla questione della cittadinanza

Ogni anno in Italia più di quattrocento clochard muoiono. Qualcuno di freddo, qualcun altro per le conseguenze di una vita esposta e senza scudi di protezione. Né sociali né affettivi né di sistema. La parola «clochard» ha un’etimologia ben precisa: deriva dal verbo francese «clocher», che significa «zoppicare». Dunque, il clochard è colui che zoppica, realmente o metaforicamente. In società sempre più agoniste e scolpite su modelli che incentivano la competizione, chi zoppica non fa il tempo per qualificarsi, è un atleta ridotto, un palloncino senza il governo dei venti. Tutti i clochard hanno avuto, da sempre, una consonanza: sono senza lavoro.
L’esercito dei clochard è oggi assai differente rispetto al passato. Ci vorrebbe un film o un romanzo che riscriva la storia di un homeless contemporaneo. Il pasoliniano Accattone – che pure una casa l’aveva – era un antieroe sottoproletario con l’evidenza che solo la morte lo avrebbe salvato. La liberazione dal dolore del destino ingiusto. In un’altra pellicola, «Les Amants du Pont-Neuf» (Gli amanti del Ponte Nuovo) di Leos Carax, oltre al prototipo di sempre (il clochard bianco, diseredato, alcolizzato e rassegnato) si affaccia l’artista di strada-sognatore e la sua compagna di ponte, inquieta e socialmente diversa, una studentessa allontanatasi dalla famiglia per una malattia. Ma siamo sempre all’interno dell’etimologia della zoppia. Il clochard, il barbone, l’homeless, il vagabondo cantastorie hanno rappresentato anche la scelta del rifiuto del sistema, per qualcuno – che non ha sperimentato il prezzo della vita in strada – simboleggiano l’estrema libertà. Di panchina in panchina, di ponte in ponte: un viaggio al limite negli spazi della miseria, ma anche una sottrazione ad un desiderio coercitivo e diseguale che attraversa comunque la società.
Oggi, dicevamo, il profilo del senzatetto è stato in molti casi rovesciato. È il ragazzo che ci allunga l’hamburger da Burger King, la ragazza che pulisce i luoghi del nostro lavoro, il richiedente asilo (e speranza), lo stagionale che dopo la raccolta delle mele o dell’uva galleggia nella comunità come uno scarto, il giovane straniero che muove il muletto in un magazzino (come ci ha raccontato Marina Castaldo, presidente di MoviTrento), chi – per un imprevisto di vita – non ha più il reddito per sostenere un affitto. Si è creata una microsocietà parallela che è aggrappata al convoglio dell’altra società, ma non riesce a salire, a garantirsi un posto, anche se in quarta classe.
Questa microsocietà è nata nell’intersezione di tre questioni: la struttura del lavoro; il mismatch negativo tra domanda e offerta di casa; la globalizzazione che ha disposto una dinamica di riscatto per biografie potenzialmente bruciate dal destino e lo ha fatto sfruttando le vecchie rotte coloniali. Nel caso del lavoro c’è una fame crescente di figure professionali (poco o altamente specializzate) che il mercato interno non soddisfa. E non soddisferà più per ragioni culturali e demografiche. A questo si associa una dinamica salariale debole che, nelle posizioni più basse, lascia pochi margini ad imprevisti. E nella fattispecie dei lavoratori stagionali rischia di produrre marginalità. Alla produzione di posti di lavoro (nella scuola, nel pubblico impiego, nell’industria, nel turismo, eccetera) non corrisponde un’adeguata disponibilità di alloggi. Sia perché il pubblico si è progressivamente ritirato negli anni Duemila, sia perché chi ha una rendita immobiliare cerca di metterla a reddito nel prospero mercato turistico (l’ultima frontiera del consumo di massa) sia perché i costi sono diventati nel tempo fuori scala e insostenibili. A ciò si aggiunge una questione razziale o di opportunità: agli stranieri non si affitta. Infine, ci sono le dinamiche globali che soccorrono una società, quella occidentale, in difficoltà ma che rimodulano in senso più ampio le geografie socioculturali. È la sfida dell’incontro, della relazione. E ha molti canali di accesso che non sempre nascono dalla disperazione. Per i richiedenti asilo la restrizione delle maglie dell’accoglienza ha, però, determinato il loro ingresso nel girone dantesco degli «zoppicanti» pur avendo diritto ad un percorso, e quindi ad un ricovero che non siano le stelle.
La questione, con tutta la sua urgenza, è emersa con la chiusura dei dormitori emergenziali aperti pochi giorni in corrispondenza di temperature discese sotto i meno 4 gradi. Al di là che i protocolli sono legati a fasi storiche e possono essere ripensati per evitare di burocratizzare la dignità o di avere un decesso per strada nelle fiorenti lande autonomistiche (chi ne sarebbe responsabile?), il ping pong istituzionale non sembra in grado di produrre risultati significativi. Il presidente della Provincia Fugatti sa che è un tema ostile anche per una parte della società e del suo elettorato, si è dimostrato flessibile su chi lavora ed è in strada, ma non può cedere la delega sull’accoglienza perché è quella con cui si governano i flussi migratori. Al Comune di Trento non rimane che adattarsi o costruire un’alternativa. È quello che ha provato a suggerire l’ex governatore ed ex sindaco Lorenzo Dellai, proponendo un’alleanza che allarghi le maglie della responsabilità al terzo settore e al mondo economico. E, aggiungiamo, a quella parte di società che, dal basso, crede ad un’altra configurazione dell’affresco sociale. Se usciamo dalle visioni schematiche e scegliamo un’osservazione di strada, chiunque può notare come la temuta contaminazione di biografie e culture è – con tutte le sue difficoltà – già in atto.
Il mondo economico reclama di regolare diversamente le frontiere. Ha bisogno di lavoratori e lavoratrici che non possono essere disgiunti da una piena cittadinanza. Intorno ad una persona che arriva in Trentino va eretto un fortino di diritti e doveri, si chiama – diversamente – sicurezza sociale. È un compito anche dell’economia non fermarsi alla richiesta, ma essere un elemento di stimolo alla soluzione e non accettare che qualcuno possa vivere sotto l’eco di un ponte. Per le posizioni sociali più estreme occorrono delle «case delle cittadinanza», strutture che li accompagnino al lavoro e alla vita, e che garantiscano almeno una stanza e un bagno per potersi programmare. Se usciamo dall’idea di accoglienza tout court – che implica comunque un dislivello tra chi accoglie e chi è accolto – e da quella che assegna all’emergenza la regolazione dell’esistenza degli ultimi, forse possiamo avanzare nel problema. La chiave della riflessione non può, però, che essere la cittadinanza.