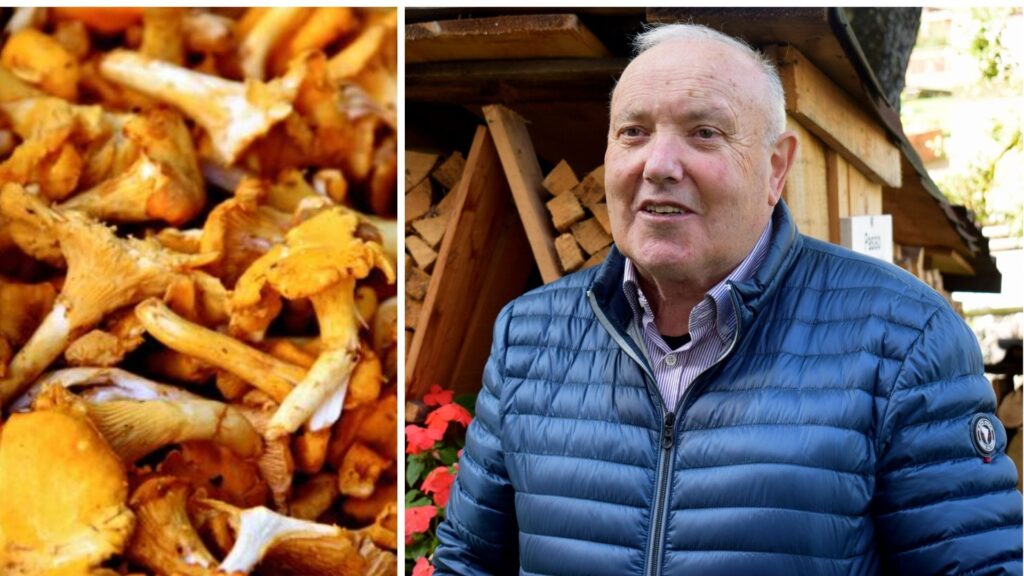L'editoriale
mercoledì 27 Agosto, 2025
Autonomia, aprire il cantiere
di Gianfranco Postal
Serve interrogarsi collettivamente sul futuro dello strumento e sugli obiettivi che le comunità trentina e altoatesina vogliono porsi. Non significa inventarsi competenze da sottrarre allo Stato, ma capire come esercitarle

Dopo il ripristino delle condizioni dell’Autonomia del 1992, con la ormai prossima modifica in Parlamento dello Statuto, quali saranno i prossimi passi? Da anni si afferma l’Autonomia dinamica come caratteristica fondamentale di questo territorio, come processo, che ad un tempo conserva la propria identità e specificità, dall’altra continua a costruire l’innovazione in tutti i settori, laboratorio di sperimentazione istituzionale. Seguendo le indicazioni dei recenti pronunciamenti dei tre Consigli, regionale e provinciali, sul disegno di legge costituzionale di modifica «manutentivo-ripristinatoria» dello Statuto, è ora necessario interrogarsi su come impostare quell’ulteriore fase che porterebbe all’evoluzione dell’Autonomia nel mutante assetto anche ordinamentale, a livello nazionale come a quello europeo. E pertanto quale idea di sé abbiano e quali obiettivi di lungo, medio e breve termine si pongano le Comunità del Trentino e dell’Alto Adige/Südtirol. Che hanno caratteristiche diverse e peculiari, ma al contempo fortemente collegate tra loro per l’unico statuto, la storia, gli ordinamenti e le istituzioni, la geografia, l’ambiente, e tanto altro.
Ciò significa individuare gli obiettivi, soprattutto quelli condivisi da entrambe le Comunità, per avviare la nuova stagione della cosiddetta revisione dello Statuto, peraltro evocata di fatto in tutti i dibattiti consiliari, a Bolzano come a Trento, ed esplicitamente richiamata anche nei pareri formali espressi per il Parlamento sul disegno di legge costituzionale ora all’esame della Camera dei deputati. Non si tratta solo di scrivere nuove norme, essenziali, ma pur sempre strumenti, che necessitano di valori, finalità e gli obiettivi condivisi dalle due Comunità. Occorre quindi un approfondimento e un confronto sistematico.
Ciò deve coinvolgere tutte le forze politiche e sociali, i vari mondi della cultura e delle scienze, gli strumenti della partecipazione popolare alla vita delle istituzioni, superando con coraggio gli scarsi risultati del confronto avvenuto negli scorsi anni (Convention e Consulta); facendo però tesoro della comunque preziosa esperienza. Senza questo passo necessario è da dubitare molto, infatti, che si possa arrivare ad una evoluzione dello Statuto, che non sia mero adeguamento, con i necessari mutamenti, alle modifiche costituzionali del 2001 per le regioni ed enti locali ordinari. E, si badi bene, non si tratta tanto di inventare quali altre competenze statali acquisire dallo Stato, ma piuttosto come creare maggiori opportunità per esercitarle con minori condizionamenti.
Sarà necessario modificare gli schemi fin qui seguiti, basati sugli elenchi, fin troppo pedissequi, delle materie di competenza; elenchi scritti nel 1948 e via via aggiustati, anche ora con il disegno di legge costituzionale in Parlamento. Elenchi che, peraltro, vanno in futuro riscritti tenendo anche conto del linguaggio giuridico adottato in Costituzione per definire, nel 2001, i nuovi ambiti di competenza di Stato, regioni ed enti locali. Ma occorre anche individuare quali nuove finalità ed obiettivi riservare all’Autonomia. Quindi anche gli spazi riconosciuti all’Autonomia per progettare specifici modelli organizzativi per la tutela dei diritti fondamentali delle persone appartenenti alle due Comunità. Ciò per contribuire a promuovere appieno lo sviluppo della loro personalità, la loro effettiva partecipazione alla vita delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sociali. Il tutto considerando che in questo territorio la grandissima parte delle funzioni destinate ad attuare tali diritti fondamentali sono nella competenza e responsabilità delle istituzioni dell’Autonomia. Ad esempio, obiettivi per l’organizzazione dell’istruzione e della formazione, della tutela della salute e delle condizioni socioeconomiche della popolazione. Strumenti organizzativi adeguati anche per sostenere in positivo il processo di profondo cambiamento in atto del sistema produttivo e di quello istituzionale (quale ruolo di Regione, Province e Comuni), quindi nell’organizzazione del lavoro.
Allo stesso tempo, individuare quali interessi si ritiene di programmare e gestire meglio in comune, con reciproco vantaggio, a livello regionale o bi-provinciale. Quali obiettivi e relativi strumenti programmare e gestire in comune con altre regioni (Veneto in particolare), anche a livello transfrontaliero (come l’Euroregione) o internazionale (come la Convenzione delle Alpi o la Convenzione di Madrid). Solo per citare qualche esempio pratico, a livello bi-provinciale/regionale, si potrebbe valutare se e come espandere la responsabilità della previdenza, Inps compreso, per assicurare la continuità e qualità delle prestazioni. Per la tutela della salute, costruire un modello organizzativo adeguato ai fabbisogni di un territorio prevalentemente montano, che allo stesso tempo vuol garantire la continuità del modello universale e anche la qualità e la sostenibilità finanziaria. Individuare, inoltre, quali obiettivi comuni perseguire per specifici aspetti della tutela dell’ambiente, di governo del territorio, delle grandi infrastrutture di comunicazione e trasporto (ferrovie, autostrade, reti dell’energia e del digitale). Si tratta di specifici obiettivi che, per loro natura superano il territorio della singola Provincia autonoma-Regione e che, in alternativa, continuerebbero ad essere gestiti prevalentemente a livello statale ed europeo. Ora la questione è: a chi spetta avviare questo processo?
Questo è compito che esige un impegno collettivo, che coinvolge, come detto sopra, istituzioni (in particolare i tre consigli con ampia partecipazione di maggioranza e opposizione), quindi le forze politiche, sociali, economiche, della scienza e della cultura, intese nel senso più ampio. Compito che coinvolge e valorizza anche il determinante ruolo della cooperazione e del volontariato. Necessita anche di una regia propositiva e di un metodo condiviso, dal Brennero a Borghetto, in grado di dare vita ad una sorta di «Cantiere Trentino-Alto Adige/Südtirol». L’alternativa sarebbe la prosecuzione di ulteriori trattative a livello di vertici, locali e nazionali. Sicuramente in quel caso il metodo sarebbe più efficiente, ma sarebbe anche più efficace, al di là delle maggioranze del tempo? A livello nazionale, le esperienze del passato non sembra abbiano risolto i veri nodi, specie se guardiamo al processo di attuazione delle regioni, come ci ha narrato anche la recente vicenda delle autonomie differenziate o quella del federalismo fiscale.
*Docente di Finanza pubblica multilivello all’università di Udine e già dirigente generale della Provincia autonoma di Trento
l'editoriale
Forza e dilemmi di una piazza
di Simone Casalini
La destra è in difficoltà anche per una ragione storica: il suo sostegno alla causa palestinese. L’impossibilità di contrastare fino in fondo Israele con l’adozione di sanzioni e l’impossibilità di sostenere una ragionevole conclusione della violenza è tutta, dunque, nella storia più recente
l'editoriale
Le guerre d’attrito uomo-natura
di Flaviano Zandonai*
La maggior parte di questi conflitti si basa sostanzialmente sul lento esaurimento delle risorse dell'avversario. Un approccio che nel caso della natura non ci possiamo permettere perché significherebbe banalmente (e in qualche caso letteralmente) farci franare la terra sotto i piedi