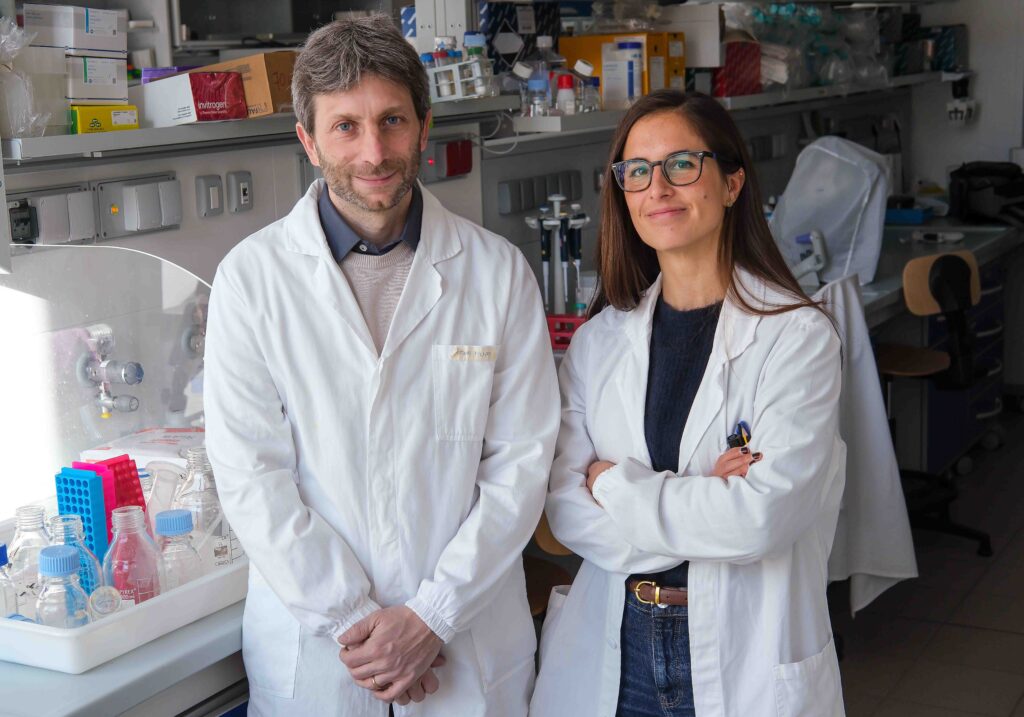l'editoriale
giovedì 7 Agosto, 2025
L’Europa sottomessa a Trump
di Alessia Donà*
Il presidente americano ha alimentato la narrazione secondo cui l’Europa avrebbe approfittato per decenni della «generosità» americana, sostenendo che per gli europei fosse giunto il momento di «pagare il conto»

Dopo settimane di incertezze e reciproche minacce sui dazi, domenica 27 luglio si è finalmente tenuto l’atteso incontro tra il presidente americano Donald Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L’accordo commerciale che ne è scaturito rappresenta un ulteriore capitolo nella progressiva subalternità dell’Europa nei confronti degli Stati Uniti.
Nonostante la narrazione ufficiale della von der Leyen, che ha definito l’intesa un «risultato positivo e soddisfacente, nel nome della stabilità e della prevedibilità per cittadini e imprese in questi tempi incerti», i dettagli raccontano tutt’altra storia. Ancora una volta, l’Unione Europea cede su più fronti. Emblematico è il caso della controversa tariffa del 15% imposta dagli Stati Uniti su numerosi prodotti europei: una riduzione rispetto agli annunciati dazi del 30% previsti a partire dal primo agosto, ma pur sempre un incremento significativo rispetto alla media del 4,8% vigente nell’era pre-Trump.
Inoltre, l’accordo prevede un impegno dell’Unione Europea ad aumentare l’acquisto di gas e armamenti americani — un passo indietro rispetto all’auspicata indipendenza energetica e strategica del continente. L’Unione Europea esce politicamente ed economicamente sconfitta: non solo accetta dazi pesanti sulle sue esportazioni, ma si impegna ad acquistare «americano» e a investire oltre Atlantico, senza ottenere in cambio contropartite significative.
Le ragioni di tale resa vanno ricercate nei profondi dissensi interni ai 27 Stati membri. Francia e Spagna avrebbero preferito rispondere con fermezza, ad esempio imponendo dazi simmetrici. Germania e Italia, invece, hanno spinto per evitare lo scontro. Altri Paesi, invece, sostenevano un approccio più dialogante, sia per motivi economici — essendo più esposti al mercato americano — sia per la loro vicinanza geografica alla Russia, che li rende particolarmente dipendenti dall’alleato americano. Il risultato è stato una postura debole e frammentata, frutto della paura che un’escalation commerciale avrebbe potuto accelerare il disimpegno degli Stati Uniti in ambito difensivo.
In questo contesto, la tecnica negoziale di Trump ha prevalso. Come esplicitato nel suo celebre «The Art of the Deal», il presidente americano adotta una strategia di massima pressione per ottenere concessioni, sfruttando ogni leva disponibile, anche a costo di dividere gli alleati. Per Trump, in ogni trattativa ci deve essere un vincitore (gli Stati Uniti) e un vinto. Ha inoltre alimentato la narrazione secondo cui l’Europa avrebbe approfittato per decenni della «generosità» americana, sostenendo che per gli europei fosse giunto il momento di «pagare il conto». Anche su questo fronte, l’Unione Europea è rimasta pressoché in silenzio, incapace di articolare una risposta credibile. Non va ignorato neppure l’aspetto simbolico della sede scelta per l’incontro: Trump Turnberry, il celebre golf club scozzese di proprietà dello stesso presidente americano. Una cornice tutt’altro che neutrale, dove la diplomazia internazionale lascia spazio a un intreccio opaco tra affari privati e politica estera. Più che un vertice diplomatico, quello del 27 luglio è stato l’ennesima dimostrazione di come Trump utilizzi le sue proprietà come strumenti di potere e di rappresentazione.
In sintesi, l’accordo rappresenta l’ennesima conferma della difficoltà dell’Europa ad affermare la propria autonomia. Anche su temi cruciali come energia e difesa, l’Unione Europea rischia di rimanere intrappolata in un sistema di dipendenze, con margini sempre più ridotti per negoziare da pari a pari. A rendere il tutto più preoccupante è l’imprevedibilità dell’attuale inquilino della Casa Bianca, che ha fatto dei dazi uno strumento punitivo. Ne sono esempi l’aumento dal 25 al 30% delle tariffe contro il Canada — «colpevole» di voler riconoscere lo Stato di Palestina — o il drastico rialzo al 50% contro il Brasile, punito secondo Trump per il clima politico di «caccia alle streghe» legato al processo contro l’ex presidente Jair Bolsonaro, accusato di aver progettato un colpo di Stato dopo la sconfitta elettorale del 2022. E ogni giorno che passa dal 27 luglio, Trump aggiunge nuove pressioni e nuovi elementi di incertezza, rendendo l’accordo ancora più fragile e pericoloso per l’Unione Europea.
Sentiremo ancora parlare di accordi commerciali e sicurezza militare: due questioni ormai inscindibili, la cui gestione sarà determinante per la credibilità geopolitica dell’Europa. In questo disordine globale, lasciare le carte in mano a un bullo è il modo più rapido per farsi trascinare in una deriva distruttiva.
*Professoressa associata
di Scienza politica all’Università di Trento