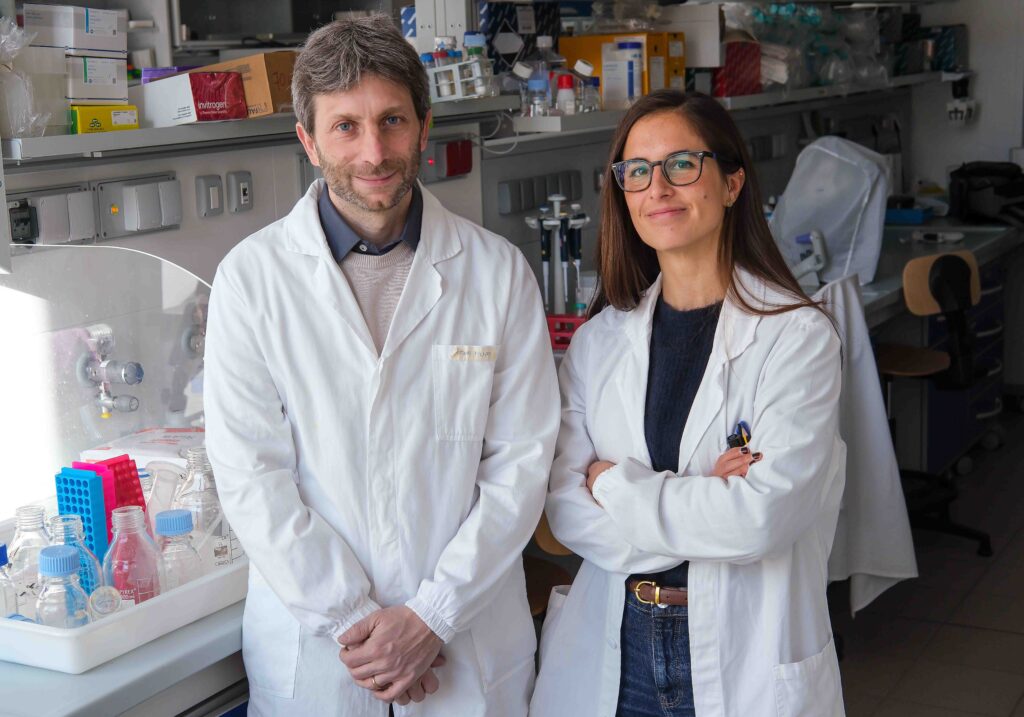l'editoriale
martedì 14 Ottobre, 2025
Per la pace ripartiamo dal basso
di Sara Zanatta

«Delegazioni sono giunte da Cosenza, da Messina, da Palermo, da Trento, da Pescara, da Torino, da Genova, da Milano, da Taranto. Professori universitari, artisti, dirigenti sindacali si mescolano alle famiglie venute al completo, con la borsa per la merenda, alle ragazze in costume, agli sportivi. […] Dietro gli stessi cartelli, con lo stesso passo sostenuto e pieno d’ottimismo, camminano i rappresentanti di un gruppo teosofico e quelli degli esperantisti, gli obiettori di coscienza e gli invalidi di guerra, operai di fabbrica e mutilati». Così Gianni Rodari raccontava la prima Marcia della Pace e della Fratellanza, il 24 settembre del 1961, e con quella sua curiosità cristallina risaliva la lunga serpentina umana in cammino tra cartelli con il volto di Gandhi e le bandiere colore dell’arcobaleno.
In quella domenica d’autunno, mentre il mondo cadeva in scacco di una guerra nuova, detta «fredda», e la gente da un mese aveva iniziato a morire nel tentativo di attraversare un muro alzato nel cuore dell’Europa, Rodari posava il suo sguardo sui famosi in marcia, da Italo Calvino con lo striscione in testa al corteo ad Aldo Capitini, filosofo della non violenza e padre di quel piccolo miracolo di partecipazione, ma coglieva anche il senso di una manifestazione composita «come un discorso nel quale confluiscano argomenti diversi». Quasi 65 anni dopo, mi sono trovata per la prima volta dentro alla marcia Perugia-Assisi e ho provato anch’io ad afferrare rivoli di pace, allungando le orecchie sui discorsi di chi camminava spedito con le bacchette da trekking e di chi altrettanto serenamente procedeva coi mocassini e la giacca elegante, contando le fasce di sindaci e sindache vicino ai loro gonfaloni e salutando come un atto di civiltà i punti ristoro con «acqua gratis».
La partenza come un corteo. Ai Giardini del Frontone di Perugia devono essere in tantissimi, a noi assiepati sotto le arcate venti minuti più indietro arriva lontana l’eco dei discorsi ufficiali con qualcuno che chiede a gran voce «perdono» per la reiterata indifferenza di questi mesi. Tutt’intorno, l’euforia di chi si sente nel posto giusto e con le gambe ancora fresche sorride solidale agli sconosciuti o cerca tra la folla amici ritardatari. Io, come alla manifestazione per Gaza dello scorso 4 ottobre, mi lascio attraversare da quella vibrazione collettiva e da un pensiero semplice: quanto siamo belli quando in così tanti riusciamo a restare umani. «Imagine all the people» è lo slogan di questa edizione: ma non serve immaginarla, la gente è davvero qui.
In marcia come un viaggio. Nella pancia di quella marea umana che procede ora adagio ora spedita – e si snoda, dice qualcuno, per 14 chilometri – vedo qualcosa che aveva già visto Gianni Rodari: la pace è ovunque ma declinata in modi e forme diverse. Se le bandiere della pace uniscono e colorano (c’è n’è anche una di centinaia di metri srotolata sui campi), quelle dell’associazionismo creano oasi di appartenenza e riconoscimento: i sindacati, gli universitari, le Acli, le sezioni locali dell’Anpi, gli scout e, più sporadici dal mio angolo visuale, i partiti politici. In mezzo, miriadi di gruppetti informali con le chitarre, i colori della Palestina (tanti) e dell’Ucraina (pochi), le scritte «PEACE» in polistirolo bianco, il viso sorridente di padre Alex Zanotelli coi giovani delle Acli, il pugno chiuso di un anziano signore che ci ringrazia a bordo strada, bambini e bambine a cui è stato detto che tocca a loro «seminare il futuro» (parole che scandiscono come un mantra nell’ultimo tratto in salita verso Assisi). E poi i cartelli con cui ognuno prova a posizionarsi e distinguersi: ci sono riferimenti più o meno velati a Trump («La pace più che Nobel è nobile») e agli americani («Sono i guerrafondai»), al genocidio e all’infanzia negata («C’è un bambino disossato sotto i cingoli di un carro armato, l’ho visto in tv non lo voglio vedere più»), al potere simbolico della Flotilla («Voglio una nave che salva tutti»), al senso stesso di quei 24km zaino in spalla («Le avversità si superano marciando»). Rodari di fronte a tanta eterogeneità era già stato lucido: «Così sarà, del resto, se vorremo la pace: essa potrà essere soltanto la somma e la moltiplicazione di volontà diverse, e non già il frutto uniforme dell’imposizione di una sola volontà sulle altre». Prendano nota i leader del mondo accorsi come soldatini a Sharm el Sheikh per la firma del documento di pace.
Infine, l’arrivo come il risveglio da un sogno. In un regionale assiepato di gente stanca, l’unico momento di tensione della giornata (quello in cui alcune persone restano sulla banchina ad aspettare il treno successivo) viene stemperato da un «bella ciao» che unisce e riscalda il vagone. Ma io mi scopro già un po’ scocciata: cerco notizie della marcia sulle homepage dei principali quotidiani, ne trovo poche e quasi tutte concentrate sulle parole dei politici presenti. E invece è stata una manifestazione partecipatissima e senza sbavature, multigenerazionale e multietnica, con le forze dell’ordine che hanno mantenuto, appunto, l’ordine della marcia e chi non ha partecipato non si è lamentato per il blocco del traffico. Sarebbe bello che la pace – quella che proviamo a costruire dal basso – facesse un po’ più notizia. Perché ho l’impressione che lì dentro – più che nelle parole di politici a portata di selfie – troveremmo qualche strumento utile per leggere anche le «piazze piene, urne vuote» di nenniana memoria e stringente attualità.
*Ricercatrice della Fondazione Museo storico del Trentino