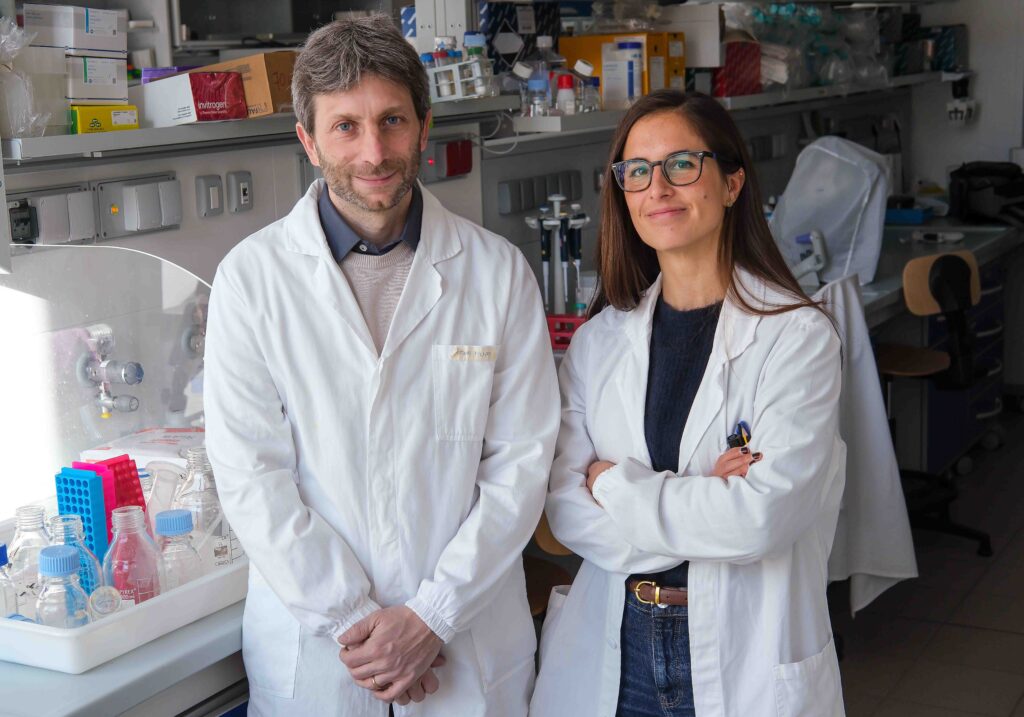L'editoriale
venerdì 22 Agosto, 2025
Manipolatori e leadership plurali
di Gianluca Salvatori
In Alaska fra Trump e Putin, che ha volto tutto a suo favore, è tornata alla ribalta la politica di potenza nella sua forma più personalizzata. Ma la frammentazione del potere è qualcosa da cui non si torna indietro

Quando un manipolatore addestrato scientificamente incontra un manipolatore che agisce in base all’istinto, di norma è il secondo a uscirne peggio. L’incontro tra Putin e Trump ad Anchorage, avvenuto qualche giorno fa, è una conferma di come l’improvvisazione non si adatti alla diplomazia, che invece rende meglio in altri contesti, come le campagne elettorali o gli eventi spettacolari (due generi, peraltro, sempre più sovrapponibili). Benché il breve vertice sia avvenuto sul suolo Usa, a dettare l’agenda è stato di fatto il leader russo. L’improvvisatore Trump sì è presentato senza aver fissato chiari obiettivi e priorità, affidandosi soltanto alla propria «arte negoziale». È bastato poco al calcolatore Putin per volgere l’incontro a proprio favore: nessuna concessione alle richieste occidentali trasmesse, con poca convinzione, dal presidente americano e un ritorno in pompa magna che ha cancellato tre anni di isolamento dalla scena internazionale. Sono bastate ventiquattro ore perché Putin smentisse anche l’unico risultato positivo che la parte americana dichiarava di aver ottenuto, ovvero la concessione di porre a garanzia dell’Ucraina uno schema simile all’articolo 5 del Trattato Nato. Davvero il premier russo non poteva manipolare meglio la situazione.
Più dei risultati dell’incontro, tutt’altro che definitivi e men che meno storici, quel che colpisce però è che in Alaska la politica di potenza è tornata alla ribalta nella sua forma più personalizzata. Ai tempi della guerra fredda, così come era avvenuto a Yalta al termine della seconda guerra mondiale, si confrontavano ideologie e modelli diversi di regime politico. Il confronto era tra sistemi, che riflettevano differenti visioni della storia e dei meccanismi che la muovono. Oggi invece tutto viene presentato come un incontro/scontro tra personalità. Il perno attorno a cui tutto viene fatto ruotare collassa su figure singole e rispettive volontà. Come se i destini del mondo potessero davvero essere decisi in qualche ristretto conciliabolo tra leader e non dipendessero piuttosto, come insegna la storia da almeno un secolo a questa parte, dall’interazione tra una moltitudine di fattori che nessun singolo protagonista può realmente controllare.
Questo concentrarsi sulla figura del leader è il sintomo del ritorno di una visione imperiale, seppure in due declinazioni molto diverse. In Putin, come figlia di un desiderio di rivalsa motivato dal ridimensionamento delle ambizioni russe a seguito del crollo dell’Unione Sovietica, vissuto come un oltraggio al ruolo millenario di un popolo spiritualmente vocato a prevalere sui suoi decadenti vicini. Mosca come la Terza Roma resta il fondamento della visione imperiale russa, chiamata a risorgere dalle ceneri per riprendere la propria missione storica. L’Ucraina – come prima la Bielorussia e la Georgia – è solo una tappa di una strategia a lungo termine, mirata a riportare la Russia al centro della scena con un ruolo di potenza dominante in Europa. E Putin si considera uno strumento di questo più ampio disegno.
Mentre in Trump quel che conta, più che una missione nazionale, è soprattutto la fascinazione esercitata dal ruolo del leader in quanto soggetto capace di plasmare a proprio piacimento le sorti del mondo. «America First» in questo senso non è altro che una versione più presentabile del troppo esplicito «Trump First», che ne resta però il significato sottinteso. Un indizio di questo culto dell’imperatore, neppure troppo nascosto, si rintraccia nella determinazione con cui Trump si attribuisce un ruolo determinante nella risoluzione di almeno cinque conflitti in meno di sei mesi: tra India e Pakistan, Armenia e Azerbaigian, Congo e Rwanda, Thailandia e Cambogia, Israele e Iran (ai quali a volte aggiunge, casomai a Oslo i giurati del Nobel per la pace non fossero ancora soddisfatti, anche Egitto e Etiopia, nonché Serbia e Kosovo). Il fatto è che, anche nei pochi casi in cui gli Usa hanno veramente giocato un ruolo nello spegnere sul nascere un potenziale conflitto, quel che Trump non coglie è come si sia trattato del risultato dell’influenza che gli Stati Uniti riescono ancora a esercitare in virtù della propria forza economica e militare, più che dell’abilità del suo presidente. Un’influenza però in declino proprio a motivo della imprevedibilità e del disinteresse per le strategie di lungo respiro che Trump non manca di dimostrare in ogni circostanza.
L’idea di un enorme potere concentrato nelle mani dei leader di due o tre grandi Paesi evoca la nostalgia di un passato che Putin e Trump difficilmente saranno in grado di far tornare, perché la complessità della nostra età non si lascia ridurre a comando. Ed è pericolosamente distopico immaginare di proporla come principio di un nuovo ordine mondiale. La frammentazione del potere è una conquista della modernità da cui non si torna indietro: gli imperi sono negli archivi della storia e il futuro dipende dalla capacità di far interagire una pluralità di poteri, di cui quello delle istituzioni e delle leadership politiche è solo una parte. A fasi alterne, gli attori economici e quelli sociali, i media e i movimenti di opinione hanno dimostrato in più occasioni che l’idea di un sovrano onnipotente è ormai fuori dalla storia. E chi tenta di impersonarla può certamente causare danni, ma non sperare di prevalere.
Se c’è un’immagine che rende questo stato di cose, questa è la fotografia al termine dell’incontro tra Trump e Zelensky di inizio settimana, a Washington. Schierati con i due, apparivano i leader di cinque paesi europei, più la presidente della Commissione Ue e il segretario generale della Nato. A qualcuno sarà parsa una immagine della debolezza europea, incapace di farsi valere con un’unica voce. Vista diversamente, è la consapevolezza che il potere non si esercita mediante atti di imperio bensì va concepito come una costante ricerca di convergenze e come capacità di trovare punti di sintesi. L’Europa, in questo senso, è una costruzione nativamente anti-imperiale. Oggi può apparire fuori tempo rispetto alle tendenze del momento, e a volte sconcertante per la tortuosità dei suoi processi decisionali. Eppure la sua pluralità, anziché essere considerata unilateralmente come un elemento di fragilità, racchiude una visione forte, che fonda la capacità di difendere diritti e libertà sulla fiducia nelle regole democratiche. In prospettiva, questa è una visione che permette di affrontare i problemi dell’ordine mondiale con maggiori possibilità di successo rispetto ai rigurgiti di una politica di potenza di stampo ottocentesco.
A volte sembriamo dimenticarcene, mancando di reagire con adeguata fermezza a chi, con più di un contorsionismo, giustifica il proprio putinismo o trumpismo in nome della sovranità nazionale. Ma in una fase tanto rischiosa, in cui tutto sembra ridursi alla volontà di potenza di pochi leader, è proprio alla visione europea di una leadership plurale che dovremmo rivolgerci. Sostenendola, malgrado le non poche manchevolezze. Purché, ovviamente, sappia anche chiarirsi che non essere prepotenti non equivale ad essere impotenti. E su questo fronte sicuramente c’è ancora molto da fare.
*Segretario generale Euricse