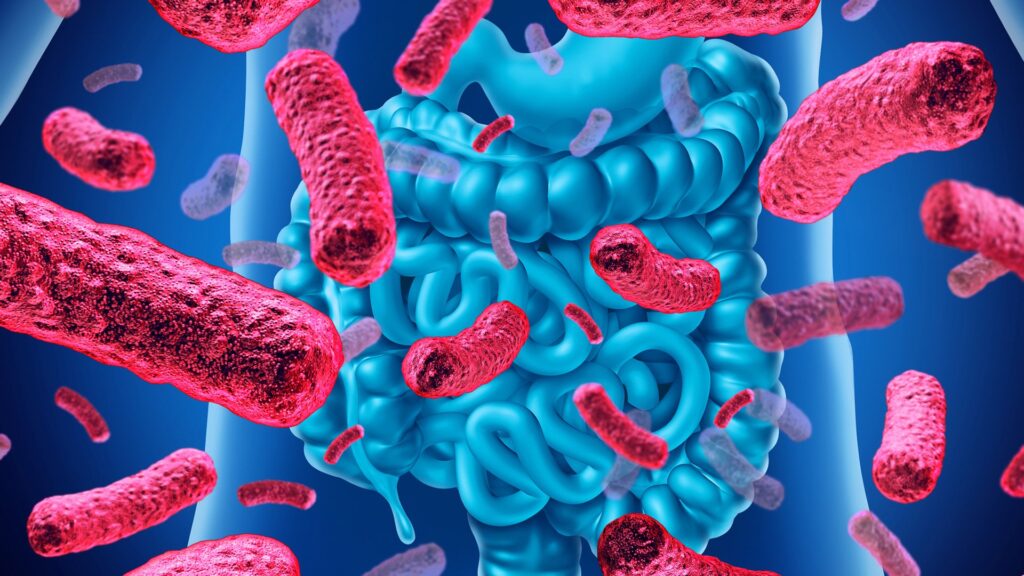L'intervista
sabato 26 Novembre, 2022
Palma Baldo: «La montagna si sgretola, impossibile scalare d’estate le vie di ghiaccio»
di Alessandro de Bertolini
La prima guida alpina donna in Trentino analizza lo stato dei massicci rocciosi e il loro mutamento a causa della crisi climatica

È stata la prima guida alpina donna del Trentino, Palma Baldo. Ha iniziato a scalare alla fine degli anni Sessanta negli ambienti della Sat, sulle montagne di casa sua, per spostarsi poi sulle pareti più famose e difficili delle Alpi. Praticando un alpinismo completo su roccia e ghiaccio, ha firmato numerose prime femminili assolute e italiane nei gruppi del Bianco, del Rosa e sul Cervino. Negli anni Settanta si appassiona alla Yosemite Valley, la nuova frontiera dell’arrampicata, dove erano puntati gli occhi degli scalatori più forti al mondo. Ci arriva nel 1979, assieme a Giovanni Groaz. Con lui, compagni di cordata e nella vita, scala la via del Naso (The Nose) al Capitàn scrivendo una pagina straordinaria di storia dell’alpinismo. Sulla grande Big Wall, in California, quella salita le vale un doppio primato: prima cordata mista uomo/donna sul Nose e prima femminile. Quando torna in Italia, dopo l’avventura americana, è tra la generazione di alpinisti che scopre la Valle del Sarca, emblema di una rivoluzione che segna un punto di svolta per l’arrampicata moderna nelle Alpi.
La prima donna guida alpina. È stato difficile?
«Avevo l’entusiasmo e avevo Giovanni, al mio fianco. Perciò le difficoltà passavano in secondo piano. Ma ho dovuto tenere nascosto quello che facevo perfino alla mia famiglia. In un Trentino così religioso, così legato alla Chiesa e ai valori tradizionali, arrampicare non era cosa che si potesse consentire a una donna. A casa mia si dava molto peso alla morale. Vivevo ad Aldeno, era un piccolo paese, molto rurale. Se non andavi a messa se ne accorgevano».
Siete stati interpreti di un nuovo modo di scalare e di vedere la montagna: vi passava davanti un pezzo di storia dell’alpinismo e tu e Giovanni eravate tra i protagonisti principali.
«L’alpinismo tradizionale, quello che avevamo conosciuto fino a quel momento, privilegiava ancora una dimensione eroica della scalata, legata strettamente al raggiungimento della vetta. Noi, invece, cominciavamo a vedere altre priorità. Non c’era soltanto la voglia di arrivare in cima, ma contavano anche le modalità con le quali si saliva. Mi riferisco alla bellezza del gesto atletico. Cercavamo di conquistare la vetta con un bel movimento, con eleganza, inseguendo una dimensione estetica».
Anche la società stava cambiando.
«Attraversavamo tutti una fase di profonda transizione. Cambiavano gli stili di vita e cambiavano le mentalità. La ventata di freschezza della contestazione, il Sessantotto, si cominciò a respirare nel mondo dell’alpinismo proprio in quel periodo. Contestualmente, anche l’attrezzatura tecnica migliorava. La mia generazione scalava ancora con gli scarponi da montagna. Poi, all’inizio degli anni Ottanta, cominciarono a diffondersi le scarpette, proprio grazie alla rivoluzione che stava avvenendo in California».
Che cosa avete trovato nello Yosemite?
«Un mondo nuovo, in tutti i sensi. Dal punto di vista sociale e culturale, erano gli anni del sogno americano e le persone che incontrammo nelle valle vivevano con stili molto differenti dai nostri. Dal punto di vista sportivo imparammo a confrontarci con un nuovo tipo di arrampicata, nuovi strumenti, nuovi gesti. In Yosemite, i ragazzi del luogo arrampicavano su quelle lavagne di granito con una tecnica e uno stile totalmente sconosciuti ai nostri occhi».
Cioè?
«Noi eravamo legati a uno stile classico. Ricordo che, la prima volta che arrivammo al Capitàn, ci fermammo alla base per esercitarci, quando ci si avvicinò un ragazzo che arrampicava scalzo. Noi ci muovevamo come se fossimo sulle Dolomiti. Allora lui ci mostrò come fare su quelle fessure, incastrando mani e piedi. Capimmo subito che, pur facendo tesoro delle esperienze che avevamo maturato, dovevamo buttarci tutto alle spalle e tuffarci in quel mondo nuovo».
Fu una battaglia, con quella la parete? Il Capitàn sono quasi mille metri verticali.
«Altroché. Ci impiegammo tre giorni per fare la via bivaccando di notte sulla montagna, appesi agli imbraghi. Dopo tutto quel tempo sospeso nel vuoto perdi il contatto con la realtà. Il tempo vola oppure non passa mai. Diventi un tutt’uno con la parete e con il tuo compagno. Io e Giovanni. Quando uscimmo, dopo tre giorni, sulla cima della montagna, facevamo quasi fatica a camminare, dopo tutto quel tempo passato in verticale».
Dopo il 1979, quando avete scalato il Nose, siete più tornati nella Yosemite Valley?
«Ci siamo stati un paio di volte, all’inizio degli anni Novanta e poi una decina di anni fa. A distanza di tanto tempo, la Yosemite Valley non è cambiata molto. Certo, oggi è più turistica. Ma le atmosfere che abbiamo respirato sono ancora quelle».
In tutti questi anni, com’è cambiata la montagna?
«Le montagne si stanno sgretolando, fa caldo, manca la neve. Penso alle grandi vie di ghiaccio, non le puoi più fare in estate. Penso al Gruppo del Bianco, al Cervino, alla Nord dell’Eiger, alle Dolomiti di Brenta, al Cevedale, alle molte salite che abbiamo fatto io e Giovanni. In pochi anni è tutto cambiato e la montagna si impoverisce senza la neve e il ghiaccio. Accettiamo le circostanze, non c’è nulla da fare».
Una vita in parete, tu e Giovanni. Cosa rappresenta per te oggi la montagna?
«Un luogo dove rifugiarmi, ancora adesso, nella vita di tutti i giorni, per trarre energia. Una nicchia dove ci rechiamo ancora insieme, noi due, come sempre. Un spazio dove ritrovare il contatto con la natura a ogni stagione, ogni anno, di giorno così come di notte».
Di notte?
«Ancora oggi, se devo stare in un rifugio… Preferisco dormire all’aperto su una cengia».