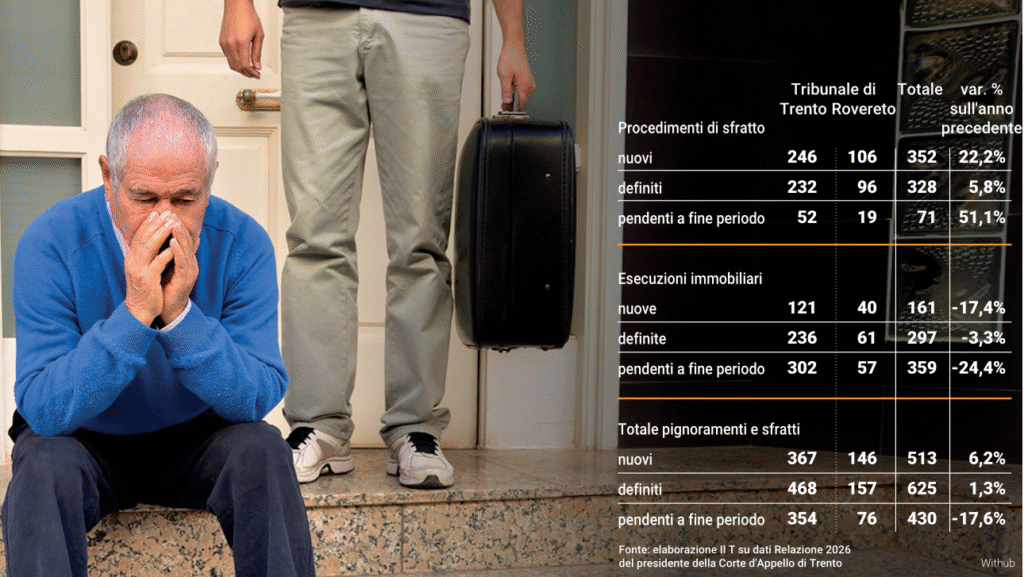La polemica
domenica 18 Maggio, 2025
Necropoli preromana, i Beni culturali: «Sotto il cantiere non ci sono resti archeologici»
di Gabriella Brugnara
Il dirigente della Soprintendenza Marzatico replica all'interrogazione del consigliere Degasperi: «Dicerie inconsistenti, fatto un controllo scrupoloso»

«Spiace, dal punto di vista della visione dell’organo di tutela tecnico, essere investito da illazioni alimentate evidentemente da persone che non hanno una cognizione di causa e che questa – per citare Shakespeare – ricerca “del marcio in Danimarca” sia una sorta di delegittimazione dell’operato degli archeologi incaricati, della Provincia, e dei professionisti di ditte esterne, talvolta percepiti come soggetti piegati a presunti poteri forti». È di dispiacere misto a rammarico la prima reazione del dirigente dell’Umst Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Provincia di Trento, Franco Marzatico, per l’interrogazione (la numero 943) presentata al presidente del Consiglio provinciale l’8 maggio scorso dal consigliere Filippo Degasperi, con oggetto: «Via Santa Croce, Trento: una necropoli preromana sacrificata al mercato immobiliare?».
Si ricorderà che lo scorso febbraio è stata data notizia della scoperta di 200 tombe complete di prestigiosi corredi nella suddetta zona. Nell’interrogazione Degasperi parla, tra l’altro, di «silenzio assordante» da parte dell’amministrazione, di «ripresa dei lavori» dell’impresa costruttrice, si chiede perché si sia scavato «fino ad un massimo di 5 metri evitando di arrivare alla stessa profondità di ritrovamento delle tombe (8 metri)».«Comprendo pienamente le dinamiche della relazione politica e non metto in discussione il valore sacrosanto dell’interrogazione, che rappresenta uno strumento essenziale di chiarezza, con una funzione sociale e culturale fondamentale — dichiara Marzatico —. Tuttavia non si può, come avvenuto in questo caso, basare un’interrogazione su dicerie inconsistenti. Questo approccio rischia non solo di delegittimare l’azione dell’amministrazione pubblica, ma anche di svalutare l’impegno di chi lavora con dedizione al recupero e alla tutela del patrimonio archeologico. Non si tratta, ovviamente, di una questione partitica, né di centrodestra né di centrosinistra, ma di un principio generale». Per Marzatico il cosiddetto «silenzio» non è mai stato assoluto. Piuttosto, va ricordato che la ricerca archeologica non si presta a una radiocronaca quotidiana. Il lavoro di restituzione scientifica è già in corso: sono infatti previste due conferenze — una al Museo di Belluno e una all’Università di Bologna — per presentare pubblicamente le acquisizioni. Per quanto riguarda il supposto mancato approfondimento degli scavi oltre i cinque metri, «è stato condotto un controllo scrupoloso, che sotto tale quota non ha rilevato resti archeologici, come spesso accade nella ricerca, anche in relazione ai fenomeni alluvionali che hanno interessato l’area della necropoli — spiega ancora il dirigente —. Sotto il cemento che appare nella foto allegata all’interrogazione non sono stati trovati resti. Attualmente si attende lo scavo dell’altra metà della necropoli già individuata, per il quale sono in fase di preparazione le procedure di affidamento, come previsto dalla normativa vigente».
Nel frattempo, i tempi tecnici di sospensione necessari per il riaffidamento rendono compatibili alcuni lavori di messa in sicurezza, stabilizzazione e cantierizzazione da parte della proprietà, laddove l’assenza di resti archeologici lo renda possibile. «Sarebbe prematuro e poco opportuno trarre ora delle conclusioni sulle modalità di valorizzazione delle scoperte, dato che il lavoro è ancora in corso — afferma Marzatico —. In ogni caso, il concetto di interazione tra tutela e sviluppo urbano è da decenni una prassi consolidata, tanto a livello locale quanto nazionale. Esiste infatti un dialogo costante tra chi esercita la tutela e gli altri portatori di interesse, pubblici o privati, con l’obiettivo di ottimizzare gli impegni reciproci, sempre nel rispetto della salvaguardia del bene culturale e dell’interesse pubblico». In questo caso specifico, gli accordi tra le esigenze della prosecuzione dei lavori e quelle della ricerca «hanno consentito agli archeologi di operare fino a otto metri di profondità in condizioni di sicurezza, nonostante gli edifici sovrastanti incombessero sullo scavo, con facciate a strapiombo. Parlare di “armonizzazione” tra esigenze archeologiche e urbanistiche significa anche pensare concretamente alla prevenzione di incidenti sul lavoro, che purtroppo rappresentano una tragedia ancora troppo attuale» osserva il soprintendente.
I lavori per la costruzione del complesso immobiliare stanno dunque proseguendo, «considerato che il controllo scrupoloso archeologico preventivo alle opere edili, condotto dal 10 marzo al 4 aprile, non ha rilevato alcuna presenza di frequentazione antica». Per quanto riguarda le verifiche effettuate sulla presenza di altri reperti, Marzatico ricorda che «tutto il centro storico della città è area ad alto potenziale archeologico, e nella cartografia del PRG del Comune di Trento e nel geoportale cartografico della Provincia è possibile consultare i dati cartografici di tutti i siti sottoposti a tutela. Il PRG del Comune di Trento, in aree specifiche indicate di interesse archeologico che sono perimetrate, impone un controllo preventivo a tutti i lavori che prevedano movimenti terra».
Ma al di là di quelle che possono essere «le tenzoni di natura politica, con uno sguardo verso l’aspetto tecnico-scientifico, da un lato continuano gli studi sui resti dei cremati: l’analisi è già stata affidata a specialisti, ed è in corso il restauro di diversi oggetti, proprio in vista della definizione delle modalità di conservazione e di narrazione, il cosiddetto storytelling». Alcuni oggetti ritrovati permettono inoltre «di istituire delle relazioni di scambio culturale di grandissimo rilievo, come ad esempio nel caso di uno scettro/conocchia in bronzo con inserti di altra materia — che deve essere determinata — che fa parte della simbologia del potere e del prestigio dei ceti dominanti della Pianura Padana. I confronti con quello che abbiamo trovato a Trento ci permettono di tracciare linee di contatto che dimostrano il fatto che a quell’epoca le Alpi non erano isolate, e che erano comunità dominate da un’élite aristocratica di guerrieri armati e di donne che li accompagnavano, che si autorappresentavano con oggetti carichi di valenze simboliche come quelli che troviamo nel territorio proto-etrusco dell’Emilia villanoviana», conclude.
La storia
Dalla laurea in Filosofia all'oro olimpico: Davide Ghiotto, l'alumno UniTrento che domina il ghiaccio (con i trentini Giovannini e Malfatti)
di Redazione
Il campione si è laureato con il programma TopSport. Il Rettore Deflorian: «Esempio di come conciliare studio e sport ai massimi livelli»
L'iniziativa
Il Monte Bondone debutta nel Winter Triathlon: alle Viote la sfida finale tra corsa, bici e sci di fondo
di Redazione
Domenica 22 febbraio 2026 la "montagna di Trento" ospita l'atto conclusivo del Circuito Federale Suzuki. Atleti e giovani promesse si sfidano su distanza sprint tra i panorami innevati delle Viote
Salute
Ginecologia, un gettonista (specializzato in endometriosi) anche per il Santa Chiara. Parolari (Pd) contro il bando: «Così casi complessi affidati a un esterno»
di Davide Orsato
La retribuzione: fino a 79 euro all'ora (con super reperibilità). Ma c'è anche un concorso per il tempo indeterminato: arrivate 26 domande