La rubrica
mercoledì 21 Maggio, 2025
Ricordi d’adolescenza di «Partir un Jour», gli scorci sull’ex DDR, l’eco dei gilet gialli, il deserto marocchino di «Sirat»: quattro titoli da Cannes
di Michele Bellio
Una selezione (con recensione) dei film più apprezzati del concorso

PARTIR UN JOUR
(Francia 2025, 94 min.) Regia di Amélie Bonnin, con Juliette Armanet, Bastien Bouilllon, Dominique Blanc

Scelto come film d’apertura del festival e presentato quindi fuori concorso, «Partir un Jour», esordio nel lungometraggio della regista Amélie Bonnin, offre l’occasione per piccola una riflessione sul cosiddetto cinema medio. Non ci troviamo, infatti, di fronte a un’opera memorabile, quanto alla realizzazione, riuscita e gradevole, di un prodotto capace di instaurare un franco e positivo rapporto con il pubblico — indubbiamente in patria, ma anche al di fuori della Francia, se adeguatamente promosso. Il film si ispira a un cortometraggio della stessa regista, vincitore del César nel 2023, di cui conserva il titolo e lo spunto narrativo iniziale, con l’inversione dei ruoli tra i due protagonisti. Cécile vive a Parigi, dove sta per aprire insieme al compagno un ambizioso ristorante gourmet, il sogno di una vita, divenuto finalmente alla sua portata dopo la vittoria nel reality «Top Chef». A pochi giorni dall’inaugurazione, due notizie la travolgono: scopre di essere incinta (e non ha intenzione di tenere il bambino) e viene a sapere che suo padre ha avuto un infarto. Torna così nel paesello natio nell’est della Francia, da cui si era allontanata molti anni prima, e si ritrova a fare i conti con la propria infanzia. I genitori gestiscono umilmente da una vita una classica trattoria per camionisti: il padre è un maniaco del lavoro e la madre, che lo supporta come può, sogna una pensione che non arriva e fuma di nascosto nel camper parcheggiato dietro casa, con il quale vorrebbe finalmente raggiungere l’amata Italia. Cercando di mettere ordine nella propria vita e di ricucire il rapporto con il genitore, offeso dall’atteggiamento altezzoso assunto dalla figlia in tv, Cécile ritrova Raphaël, amico e amore di gioventù. E tanti dubbi cominciano ad affiorare.
Una trama non particolarmente originale diventa lo spunto per una vicenda che ha nella sua verosimiglianza l’aspetto più interessante. E questo nonostante la struttura narrativa si basi su un’idea tutt’altro che realistica: nei momenti più emotivamente intensi, infatti, il racconto procede attraverso celebri brani pop cantati dagli attori, che usano i testi al posto dei dialoghi. Si passa da “Alors on danse” al brano che dà il titolo al film. Anche qui, nulla di nuovo. Eppure la descrizione della realtà di provincia, la vividezza del ritratto dei genitori e della loro attività, l’innegabile simpatia dei comprimari e del protagonista maschile e l’efficace evoluzione del personaggio principale — meravigliosamente reso da Juliette Armanet — rendono il tutto coinvolgente, spontaneo, sincero. Un film splendidamente francese, di quelli che il nostro cinema sembra sempre incapace di realizzare: comincia con una grafica in omaggio al karaoke e si chiude con una nota di (facile, ma sincera) commozione. E la descrizione di un sabato pomeriggio adolescenziale negli anni Novanta, tra una pista di pattinaggio e un bacio mai dato, rimane impressa con una semplicità devastante.
SOUND OF FALLING
(In die Sonne schauen, Germania 2025, 149 min.) Regia di Mascha Schilinski, con Luise Heyer, Filip Schnack
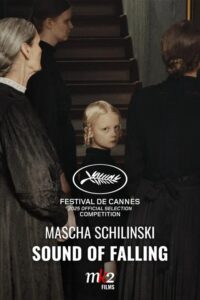
Tra i film più apprezzati del concorso, anche se inevitabilmente travolto da recensioni contrastanti, il secondo lungometraggio della regista tedesca racconta la storia di quattro generazioni di donne in una fattoria nella storica regione dell’Altmark, nell’odierna Sassonia-Anhalt, parte dell’ex DDR. Il tema principale è la ricorrenza della violenza che travolge inesorabilmente le donne di ogni generazione, in particolare sotto forma di parenti-orchi, di fantasmi del passato che non smettono di tormentare anime innocenti. La storia si ripete, pur modificandosi nell’apparenza degli eventi, e le vittime di un sistema inquietante e malato si susseguono, mentre sullo schermo assistiamo alla disperata crescita delle protagoniste, predestinate loro malgrado a un futuro di sofferenza che vede nella morte o nella fuga le uniche alternative possibili. Non è un film facile da raccontare «Sound of Falling», perché la sua struttura non è canonica. Il collegamento familiare tra le generazioni è definito, ma il film vola su una suggestione profondamente sensoriale, alternando le trame senza connessioni esplicite. Magistralmente diretto, con un uso incredibile della macchina da presa che si muove con inquietante rapidità tra gli spazi chiusi — enfatizzati dalla scelta del formato quadrato — si tratta di un’opera incredibilmente ambiziosa e affascinante, che vive di fantasmi, di improvvisi silenzi, di tesi sguardi in macchina, di esplosioni di violenza descritte da un occhio attonito e senza pietà. C’è chi ha citato Haneke, chi Malick — entrambi sicuramente presenti — ma di certo la carne al fuoco è tanta, forse anche troppa, e talvolta il rischio è di perdersi o di annegare nella straordinaria ricerca formale, a scapito dell’importanza dell’assunto. Perché la descrizione dell’universo patriarcale maschile che regna attraverso i decenni e la tensione sessuale che ammanta ogni segmento mettono giustamente i brividi, e meritavano forse una maggiore sintesi. Rimane un’opera molto interessante, certamente non alla portata di tutti e che richiede impegno, ma che apre anche a una legittima curiosità sui futuri progetti della regista. E sono innumerevoli le scene che restano impresse nella memoria, non solo per lo splendore della messa in scena.
DOSSIER 137
(Francia 2025, 115 min.) Regia di Dominik Moll, con Léa Drucker, Yoann Blanc, Antonia Buresi
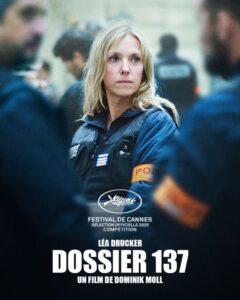
Francia, dicembre 2018. In tutto il Paese imperversano le proteste dei gilet gialli. Stéphanie è una poliziotta che lavora a Parigi nell’ufficio affari interni. Si occupa di indagini sull’uso ingiustificato della forza da parte dei colleghi e, in questo particolare momento, il suo ufficio è travolto dalle segnalazioni legate a scontri con i manifestanti, spesso degenerati in episodi fuori controllo. Stéphanie ha rispetto per i colleghi e ne comprende il disagio e la pressione, ma allo stesso tempo è determinata a svolgere il proprio lavoro con serietà, per tutelare la verità e non gettare ulteriore discredito sulle forze dell’ordine. Una posizione che la isola: da un lato nei rapporti con gli altri poliziotti, dall’altro nel necessario distacco da chi si rivolge a lei per denunciare un abuso. In quei giorni, Guillaume, un ragazzo di vent’anni, parte da Saint-Dizier — nella disagiata provincia francese — per raggiungere Parigi insieme alla madre, alla sorella e al fidanzato di lei. Non hanno intenzioni violente: vogliono solo far sentire la propria voce, denunciare la pressione delle difficoltà economiche. Per loro è anche la prima volta nella capitale, vissuta come una gita. Ma una serie di coincidenze sfortunate porta Guillaume nel posto sbagliato al momento sbagliato: un proiettile antisommossa lo colpisce in pieno volto, provocandogli danni cerebrali irreversibili. La famiglia denuncia l’accaduto e il dossier finisce sulla scrivania di Stéphanie, che, essendo originaria dello stesso paese, si prende il caso particolarmente a cuore. Dopo l’apprezzato noir «La notte del 12» Dominik Moll porta in concorso un film incredibilmente equilibrato nell’affrontare un tema e una situazione che avrebbero potuto trasformarsi facilmente in un pamphlet retorico o in un’opera ambigua. Una struttura solida, sia a livello di scrittura che di regia, traccia una panoramica complessa sulla difficile posizione della protagonista, impegnata a indagare oltre i luoghi comuni. Il Paese è ancora scosso dagli attentati terroristici e l’opinione pubblica appare distratta, incapace di affrontare i problemi reali con la coesione necessaria (esemplare, in tal senso, il personaggio della madre di Stéphanie che guarda i gattini su Instagram). Il ritratto che ne emerge è efficace e coinvolgente, arricchito da dettagli di quotidianità (il rapporto col figlio e l’ex marito, il gatto, la partita a bowling con i colleghi), e riesce a evitare l’approccio da generico atto d’accusa. Eppure, proprio grazie alla sobrietà dello sguardo, nello spettatore monta una legittima rabbia per un sistema che, in nome dell’ordine, dimentica l’umanità e nasconde la verità. Un film che fa il suo, senza voli né cadute.
SIRAT
(Spagna/Francia 2025, 120 min.) Regia di Oliver Laxe, con Sergi López, Stefania Gadda, Jade Oukid

Capita raramente di uscire da una proiezione profondamente turbati da quanto appena visto, indipendentemente dal fatto che il film sia stato o meno apprezzato. «Sirat», in concorso a Cannes, è sicuramente un’esperienza sensoriale che non può lasciare indifferenti, e questo costituisce già di per sé un merito, in un certo senso. Ma è anche vero che si tratta di un titolo che molti spettatori non saranno disposti ad affrontare o non accetteranno. La storia si svolge nel deserto marocchino, tra le rocce di un paesaggio quasi irreale, dove un padre di famiglia e un bambino si aggirano tra i ritmi e la popolazione di un grande rave party, alla ricerca di Mar, figlia e sorella scomparsa cinque mesi prima in circostanze simili. Sullo sfondo incombe una misteriosa guerra e, nella speranza di riuscire nel loro intento, i due spaesati protagonisti decidono di seguire un gruppo di raver ben più attrezzati, diretti verso il confine con la Mauritania e un nuovo grande raduno. Ma il viaggio — autentica discesa all’inferno — sarà denso di prove e pericoli inaffrontabili. Difficile riassumere in poche righe la quantità di temi messi in campo dal regista, giunto al suo terzo e più ambizioso lavoro. Ad un certo punto è inevitabile che si avverta un senso di eccesso e che la scrittura dell’ultima parte rischi di apparire gratuita; ma è proprio l’equilibrio e lo sviluppo generale del film a sorprendere. Mistico, magicamente costruito sulla suggestione sonora di una musica nata per ballare, crudele nel modo in cui descrive l’incapacità dell’uomo europeo — o comunque occidentale — di affrontare con umiltà il rapporto con un mondo e una natura che non è in grado di controllare, «Sirat» è feroce e travolgente, brutale e lancinante. Visivamente straordinario e popolato da un cast che resta impresso nella memoria — dalla pingue banalità del protagonista ai corpi e agli animi mutilati dei comprimari, scelti nel contesto autentico in cui il film è girato — è un’esperienza che, in qualche modo, cambia la percezione del mondo contemporaneo. A condizione, naturalmente, di essere disposti a viverla fino in fondo.
L'intervista
«Metadietro», il nuovo assalto teatrale di Rezza e Mastrella: «L’eroe non esiste più. Non dobbiamo accettare compromessi»
di Luca Galoppini
I Leone d’Oro alla carriera portano a Rovereto uno spettacolo che unisce materia e visione, satira e filosofia, denunciando controllo, conformismo e scomparsa del conflitto
L'evento
Errore, fragilità e dubbio come motore di crescita e creatività: a Trento l’evento (per studenti) che insegna il valore dell’imperfezione
di Stefania Santoni
Al Centro Studi Erickson di Trento, il progetto dell’associazione Ateleia che porta nelle scuole un messaggio ispirato a Rita Levi-Montalcini





















