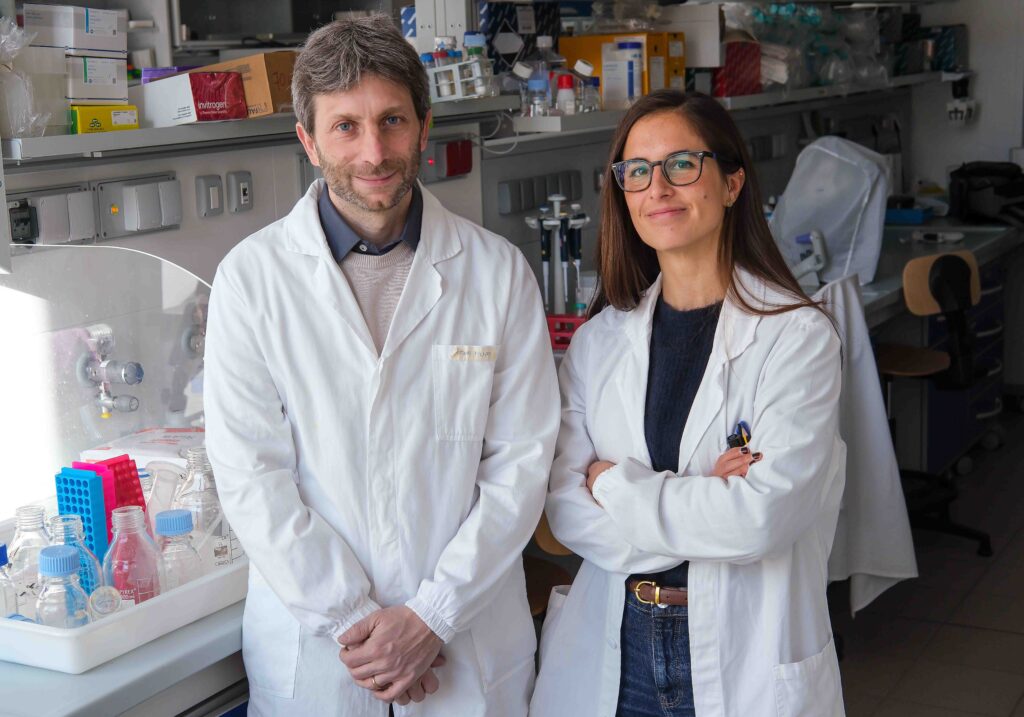l'editoriale
mercoledì 30 Luglio, 2025
Storia e simboli della Campana
di Elena Tonezzer*
Il racconto del secolo di vita di Maria Dolens, dall'inaugurazione alla visita del presidente Mattarella

Il numero dei monumenti dedicati ai morti della Grande Guerra resta tutt’ora impressionante. Lapidi, steli, cippi, statue sono stati eretti in tutta Europa con una frequenza che non ha avuto eguali neanche dopo la seconda guerra mondiale. La dimensione della strage di milioni di soldati, il ritorno di reduci traumatizzati e mutilati, era stata inimmaginabile prima di quel conflitto e il marmo e il bronzo sono stati il mezzo per trasformare i lutti dei familiari in un’esperienza collettiva, per questo più «accettabile».
Nel 1918, alla fine della guerra, Rovereto si è trovata al centro della zona nera, quella più colpita dalle distruzioni ed è tra quelle macerie che fanno ritorno i profughi e le profughe, gli internati e i volontari irredentisti. Due famiglie, quella di Damiano Chiesa e Fabio Filzi, piangono in città i loro figli condannati a morte del castello del Buonconsiglio nel 1916, a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro.
Subito, a partire dalla circolare del comitato promotore del Museo della guerra nel luglio del 1920, la città è attraversata da idee e progetti che affrontano il lutto collettivo in una maniera peculiare – come scrive Fabrizio Rasera nel saggio «Il prete della campana» – e segna l’immagine della città. Per prima cosa sorge l’idea di raccogliere le tracce e musealizzare subito nel castello la guerra appena terminata; poi, il 20 maggio del 1921, nella direzione del Museo della Guerra si discute la proposta di collocarvi una grande Campana; infine, nel settembre del 1922, viene proposta l’idea di costruire un Ossario in grado di accogliere le decine di migliaia corpi disseminati sulle montagne.
Tutti i tre progetti culturali sorgono dal dibattito nella società civile locale, sono il risultato di un sentimento che si raccoglie prima dell’inizio della dittatura fascista attorno a protagonisti diversi tra loro, tra i quali svetta il carisma di don Antonio Rossaro. L’originalità dell’idea della Campana era chiara allo stesso prete, che nel 1921 scriveva: «Pensammo un monumento che non fosse la solita fredda allegoria in bronzo o in marmo, di cui oggi è soverchiato abuso, ma un monumento che, voce viva, risuonasse e scuotesse i cuori nella solenne rievocazione di tanti eroi scomparsi e di tante vittime trapassate». Pochi mesi dopo, il progetto contava già l’adesione della regina Margherita, la collaborazione di Francia e Cecoslovacchia, e veniva lanciata una sottoscrizione nazionale.
Mentre a Trento si trascinavano le discussioni sul progetto del mausoleo dedicato a Cesare Battisti, di cui si parlava già nel 1916 ma che si concluse nel 1935 secondo il gusto del fascismo imperante, a Rovereto si costruisce rapidamente un simbolo di pietà fraterna, che va oltre quelle barriere nazionali per le quali si era appena smesso di combattere. La Campana dei caduti, infatti, si sarebbe ottenuta con il bronzo dei cannoni e sarebbe stata dedicata a tutti i caduti senza distinzione di nazionalità.
La Campana viene inaugurata alla presenza del re il 4 ottobre 1925, giorno scelto da don Rossaro perché dedicato a San Francesco, e collocata nel torrione Malipiero del Castello di Rovereto, sede dal 1921 del Museo Storico italiano della Guerra. Rossaro è un «nazionalista di confine» e aderisce al fascismo, ma riesce a mantenere la sua «creatura» indipendente dalle ritualità del regime. Non sempre è facile, anzi, non mancano le frizioni con una dittatura onnivora e vorace di spazio pubblico. Forse l’unico cedimento è quello in occasione della fondazione dell’impero d’Etiopia, quando i cento rintocchi di Maria Dolens si affiancano ai cento colpi di cannone esplosi nelle grandi città italiane.
La Campana viene rifusa nel 1939 e riportata a Rovereto nel maggio del 1940, poche settimane prima della dichiarazione di guerra di Mussolini. Il 16 maggio don Rossaro annotava: «La guerra continua a menar strage, nei paesi colpiti da tale flagello. Ho un senso di ripugnanza a pensare ad una celebrazione per la Campana dei Caduti ma il Ministero la desidera e per questo l’appoggio in pieno». Il disagio espresso da don Rossaro è dovuto al contrasto tra i valori della Campana e i venti di guerra che respirava, una tensione emersa anche nelle parole pronunciate dal presidente della Repubblica, lo scorso sabato 19 luglio al Colle di Miravalle: «Il ritorno qui è prezioso, in questo momento storico della vita internazionale, in cui, in pieno contrasto con i desideri, le aspirazioni, le attese dell’umanità in ogni continente, in ogni parte del mondo, riemergono ombre che si pensava non dovessero più aver spazio e presenza». I cento rintocchi della Campana, vedere da vicino il suo movimento e sentire la profondità del suo suono è un’esperienza indimenticabile, sono tutt’oggi un richiamo che non ha perso (purtroppo) la sua importanza, che mostra la potenza simbolica dell’idea di don Rossaro e rilancia il significato del richiamo che i simboli della pace devono mantenere: «I rintocchi di Maria Dolens – ha concluso Sergio Mattarella – esprimono non soltanto un dolore rinnovato da quanto avviene, ma esprimono soprattutto, e ne siamo convinti, un messaggio di pace e di speranza».
*Ricercatrice della Fondazione Museo storico del Trentino