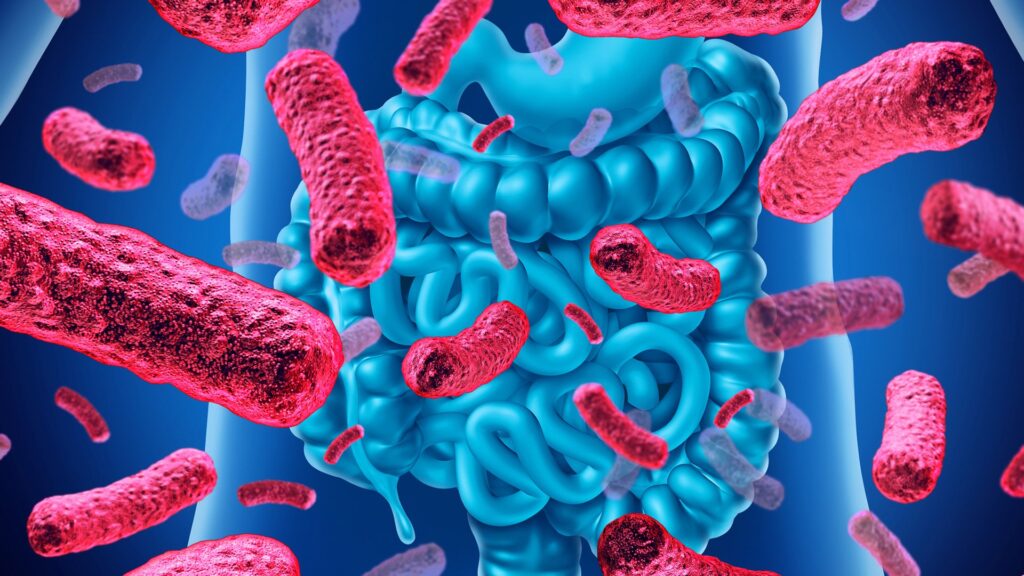L'intervista
martedì 20 Febbraio, 2024
Rovereto, Luciano Passamani: «Credo si possa creare una società che abbia più rispetto della vita»
di Anna Maria Eccli
Parla il «papà» della biblioteca dei bimbi della Città della quercia: «l’arte con la vita mi ha permesso di riaprirmi alla vita sociale, di sentirmi disponibile

L’origine della famiglia si trova in Valsugana e Luciano Passamani porta impressi nel temperamento i verdi silenzi di quei boschi, gli scorci sognanti del Sentiero degli gnomi, l’armonico sciabordio delle acque di Caldonazzo e Levico. Nella Sala di lettura per bambini più invidiata d’Italia, a Rovereto, nella Biblioteca Tartarotti, ne ha riversato tutto il potenziale immaginifico. L’artista è nato a Tenna il 17 novembre 1949 ed è stato molto attivo nelle avanguardie dell’Italia del Nord quando la Galleria Synchron di Brescia coordinava mostre collettive e personali nell’intento di portare l’arte sulle piazze, scelta «sociale» che divenne una vera e propria operazione di avanguardia, precorritrice di ciò che sarà in seguito la Land Art. Passamani si definisce «artista sociale», infatti ha realizzato, a cavallo tra arte e artigianato, opere all’interno di teatri come in quello di Levico e di Vigo Cavedine, centri di cura per la persona, luoghi di ristoro, case di abitazione, scenografie, e per sei anni ha tenuto corsi artistici pomeridiani alle elementari, curando forme e colore nelle aule della scuola steineriana. Ha conosciuto ed approfondito il pensiero del filosofo tedesco, incontrando le profondità spirituali dell’antroposofia, nel lungo periodo di riflessione trascorso con la campagna Maria Rosa in un maso, durante il quale nacquero le sue due figlie, Naama e Samatha. Lo incontriamo a 10 anni dalla realizzazione della visionaria, poetica, sala per bimbi della Tartarotti, assolutamente unica, presa ormai a modello da altre città, maturata quando era direttore Gianmario Baldi e costruita sotto la supervisione dell’architetto Sandro Aita. L’idea su cui poggia, l’immaginare di un veliero arenato su un’isola resa fertile proprio dal carico prezioso di libri che vi si rovescia, ha permesso a Passamani di realizzare spazi per il sogno: nicchie in cui i bimbi possono isolarsi per ritrovarsi; una grotta, il faro, una tenda. Archetipi che parlano del cielo e della terra, di protezione, solitudine e di illuminazione.
Luciano, a Rovereto la conoscono tutti come “il mago” della sala di lettura per bimbi più invidiata d’Italia, ma la sua origine è altrove.
«Sono nato a Ischia di Pergine, anche se mio padre, quasi in un’anticipazione di ciò che sarà il continuo sradicamento nella mia vita, mi registrò a Tenna, immaginando di costruirvi anche una casa, cosa che avvenne, ma quella casa la dovemmo anche lasciare per sopraggiunti problemi. Compressi nell’abitacolo dei camion, che trasportava anche i pochi mobili, lasciammo Tenna durante una fitta nevicata; noi cinque figli, con gli occhi incollati al vetro anteriore, seguivamo il movimento del tergicristallo. Guardavamo cadere fiocchi illuminati, mentre affrontavamo l’ignoto. Quel viaggio rappresenta ancora, per me, il distacco, quella sensazione che, anche in seguito, non mi permetterà di sentirmi appartenente ad un luogo specifico. Tuttavia, se per mio padre quell’esodo fu doloroso, per noi fu la via di apertura verso il mondo».
Ci regala un’immagine dell’infanzia per capire da cosa nasca il suo talento?
«Quella di mia madre che mi teneva sulle ginocchia mentre disegnava a lume di candela. A volte ricopiava semplicemente l’immagine riportata sulle scatole dei colori, ma così facendo impresse in me qualcosa di indelebile. Avevo, credo, 8 anni quando con un carbone disegnai, sulle pareti verde chiaro del corridoio in cui si trovava la stufa, un paesaggio con animali e alberi. Lei ne fu felice. Sicuramente contribuirono al mio amore per l’arte e per il rigore artigianale nonno Ermete, abile muratore, e mio padre, così come il fatto d’essere cresciuto nella vita contadina, semplice ma di grande valore formativo».
Il suo percorso scolastico?
«Alle scuole medie ebbi come docente la figlia del noto pittore e incisore trentino, Carlo Bonacina, che in seguito ebbi anche come maestro; fu lei a insistere affinché frequentassi la scuola d’arte, l’Istituto d’arte Vittoria, attuale liceo coreutico. A quel tempo gli insegnanti portavano nella scuola d’arte la loro formazione accademica, che contemplava la copia dal vero. Fu un periodo intenso. Preso il diploma rimasi chiuso in caso per sei mesi a dipingere: avevo bisogno di rovistare nell’interiorità per trovare l’espressione originale più vera di me».
Tempo di crisi.
«L’epoca era apocalittica; il ’68 portò ribellione sociale, riflessione, attesa di un tempo nuovo, dando uno sconquasso alla stessa visione ingessata dell’arte. Facevo parte degli Artisti Trentini, mentre avevo contatto col movimento giovanile… lo scollegamento era notevole. Il Marxismo considerava l’artista il “servo dei padroni”, tutto era ideologico. Trento era sede di Sociologia e un giorno qualcuno teorizzò addirittura la mia soppressione fisica quando si fosse attuata “la vera rivoluzione”».
Come ne uscì?
«Avevo cominciato a fare mostre a Bolzano e Trento e gli Artisti Trentini mi ritenevano una promessa. Poi, andando a Milano, trovai un crogiuolo di idealità che ampliava la mia visione. L’ambiente di Trento era irrimediabilmente segnato da un’ideologia estrema».
A Milano si fermò tanti anni.
«Fino al ’75; ero vicino al movimento dell’avanguardia, caratterizzato da grande intolleranza verso i circuiti preordinati delle gallerie. Si era capito che, alla fine, questi rappresentavano un pericolo per la ricerca creativa, isolavano l’artista all’interno d’un sistema forte e omologato. In qualche maniera ci si sentiva catalogati, manipolati, cristallizzati, imbalsamati, nello stesso tempo in cui si veniva super-valorizzati dai profitti economici».
Lei parla di «generosità sociale dell’arte»?
«Sì, nel senso di fare discendere l’arte nella quotidianità, restituendo al popolo ciò che gli appartiene di diritto. Tutto ciò che è stagnante è sterile; ho fiducia nella possibilità di rimodellare una società che abbia più rispetto per la vita».
Dopo il marxismo a Trento e l’avanguardia milanese… quali furono le scelte?
«Quella di vivere, con la mia compagna Mariarosa e la nostra prima figlia Naama, in un maso abbastanza isolato. Fu benefico, per la salute fisica e anche spirituale».
Naama è anche il nome scelto per l’isola che non c’è della Tartarotti…
«In ebraico significa “consolatrice”; purtroppo mia figlia ci ha lasciati un anno fa, a soli 49 anni. Il fatto che la Biblioteca abbia scelto questo nome mi ha sorpreso e commosso. Naama insegnava ai piccoli e che quella sala porti ora il suo nome è quasi segno di continuità della sua missione».
Cosa l’ha indotta a tornare attivo nel campo dell’arte?
«Il varcare la porta che mette in comunicazione arte e artigianato, l’arte con la vita: mi ha permesso di riaprirmi alla vita sociale, di sentirmi disponibile a cogliere domande autentiche, di ideazione di spazi abitativi, pubblici e privati, in case ma anche scuole, asili, teatri, la sala per bimbi da 0 a 6 anni di Rovereto… Il lavoro di studio e di ricerca non si interrompe mai. Durante tutti gli anni trascorsi, il vero alimento dell’attività svolta nel sociale l’ho trovato in primis nella continua riflessione».
Il testimone
Srebrenica: 30 anni dal massacro, il giornalista Riva: «Come Gaza oggi. L'Onu è morta quel giorno»
di Lorenzo Fabiano
L'editorialista era inviato nei Balcani, morirono oltre 8mila bosniaci musulmani: «È avvilente constatare che se avessimo appreso quella lezione non avremmo dovuto assistere agli orrori cui assistiamo oggi»
l'intervista
Cinquant’anni fa Francesco Moser batteva Eddy Merckx: «Sei giorni in maglia gialla sfidando il cannibale»
di Lorenzo Fabiano
Il campione di ciclismo ricorda il Tour de France del 1975: «Gli organizzatori erano così sicuri che vincesse lui che, quando mi consegnarono la maglia c’era stampato “Molteni”, la squadra di Merckx. Me ne prepararono subito un’altra»
L'intervista
Adriano Panatta: «Voglio morire 5 minuti dopo Bertolucci e fargli il gesto dell'ombrello. Sinner? Inscalfibile come le sue montagne»
di Lorenzo Fabiano
Il celebre tennista si racconta: «Il mio Wimbledon? Paolo Villaggio era il mio finto coach. Per vincere con Alcaraz Jannik deve servire almeno il 70-75% di prime palle»