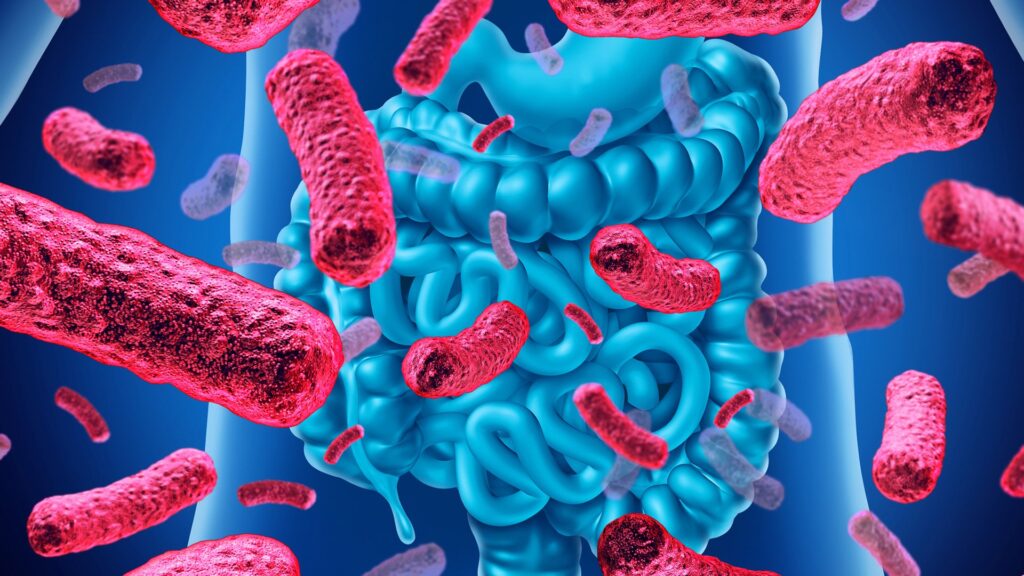giovedì 11 Maggio, 2023
Pratica sportiva e cultura cristiana
di Claudio Ferlan
I principali sport di squadra a Trento stanno vivendo un momento assai positivo: ma da dove nasce il professionismo? E come è stato affrontato nella cultura religiosa?

I principali sport di squadra a Trento stanno vivendo un momento assai positivo: finale scudetto per la pallavolo, playoff scudetto per la pallacanestro, mantenimento della categoria – pur con qualche patema – per il calcio. La punta dell’iceberg, quella rappresentata dal professionismo e giudicata quasi esclusivamente attraverso i risultati, sta funzionando bene. C’è però molto altro, un iceberg, appunto, sulle cui rotte ci si interroga da secoli: è giusto che lo sport sia parte integrante della vita di giovani e adulti?
L’immaginario prodotto dalla cultura greca, quello del mito di Olimpia, ha attraversato i millenni e ancora oggi lo abbiamo bene in mente. Molti di noi aspettano il grande evento di Parigi 2024. A un passo da casa ci sarà l’Olimpiade, che nella sua versione moderna fu riscoperta proprio da un parigino, il barone Pierre De Coubertin (1863-1937), passato alla storia anche per il mai troppo rispettato motto “L’importante non è vincere, ma partecipare”. Non troppo rispettato anche perché lui non la disse proprio così, quanto invece “L’importante è partecipare, perché solo partecipando avrai la possibilità di vincere”.
Che lo sport avesse un impatto notevole sull’educazione individuale e collettiva lo apprese presto la Chiesa cristiana. Dei pericoli del professionismo – all’epoca rappresentato non solo dagli atleti (maschi) che correvano veloce o lanciavano lontano, ma anche dai gladiatori che lottavano nelle arene – si accorse per esempio il potentissimo vescovo di Milano, Ambrogio (339/340-397), che chiese e ottenne l’interruzione delle Olimpiadi nel IV secolo. Il suo obiettivo era eliminare tutti i giochi pagani: non idolatrate i campioni, e non dedicate troppo tempo alla cura del corpo che sta lontano dall’anima. Ci vollero secoli prima che le alte sfere della Chiesa ricominciassero a fidarsi di pratiche agonistiche e di ragionare sulla mente sana in corpo sano. Protagonisti di questo rinascimento in salsa sportiva furono i gesuiti, ordine fondato da Ignazio di Loyola intorno alla metà del XVI secolo. I gesuiti indirizzarono presto la propria attività pastorale anche verso l’insegnamento, in particolare quello volto all’educazione della futura élite. Rettori e professori dei collegi inserirono con convinzione nel proprio programma nobili arti come la scherma, mettendo pure l’accento sui vantaggi di una adeguata preparazione alla competizione.
Un vero punto di svolta, però, si sarebbe verificato intorno alla metà del secolo scorso, in quegli Stati Uniti che furono al tempo (e per molti aspetti ancora sono) il luogo di origine delle più grandi innovazioni, anche nel mondo dello sport. Le università dei gesuiti (e non tra le minori del Paese: Georgetown, Boston College, Marquette, Gonzaga, Fordham, Saint-Louis, la serie dei college intitolati a Loyola, per fare solo qualche esempio) presero infatti a occuparsi in maniera professionale di sport dilettantistico. Organizzazioni accademiche sempre più ricche e potenti si impegnarono con estrema attenzione e competenza a ragionare sul valore socio-educativo dello sport studentesco.
Un articolo apparso sullo Jesuit Educational Quaterly nel gennaio 1951, per esempio, propose una riflessione su pregi e limiti dei programmi sportivi universitari, con un occhio di riguardo a basket e football. Tra le cose buone venivano elencate lo sviluppo di una sana rivalità, di un forte spirito competitivo e di “qualcosa di intangibile ma molto reale chiamato spirito di scuola” e spiegabile come un virtuoso scambio di energia tra atleti e spettatori. A onor del vero, pure distogliersi attraverso lo sforzo fisico da altre pulsioni meno nobili era un punto toccato dall’articolo, per scrivere bene dello sport e male dei costumi. Tra i rischi, invece, andavano menzionati quello di sopravvalutare il programma sportivo rispetto a quello accademico, di promuovere una eccessiva fiducia nelle abilità fisiche a scapito di quelle intellettuali, di distrarre gli atleti anche attraverso lunghi e faticosi viaggi. Si parlava, va sottolineato, esclusivamente al maschile.
Non c’erano comunque solamente i gesuiti, a ragionare di giochi e agonismo: pure dal Vaticano giunsero segnali importanti, grazie prima di tutto alla pionieristica voce di Pio XII (data 20 maggio 1945 un suo importante discorso agli sportivi, pronunciato nella solennità della Pentecoste) e in seguito anche al Concilio Vaticano II. Diversamente da quanto fatto da Ambrogio, si cominciò a guardare allo sport come a uno strumento importante per la formazione delle persone, in grado di trasmettere valori come la disciplina, la lealtà, la solidarietà e il rispetto per l’avversario. Non solo, si iniziò pure a credere che, grazie alla pratica sportiva, i giovani potessero acquisire competenze utili per la vita quotidiana e professionale, come la gestione dello stress, la capacità di lavorare in squadra e l’assunzione di responsabilità. Infine, ci si convinse che una sana competizione fosse in grado di favorire la creazione di buoni rapporti tra le persone, indipendentemente dalle loro differenze. Lo evidenziò a chiare lettere la Gaudium et Spes, una delle quattro costituzioni del Vaticano II, secondo la quale “esercizi e manifestazioni sportive … offrono un aiuto per stabilire fraterne relazioni fra gli uomini di tutte le condizioni, di nazioni o di razze diverse”.
Siamo oggi disposti a credere davvero a queste parole e a queste riflessioni? Se è così, vinca il migliore, altrimenti possiamo dare credito al motto scolpito in una targa che conservo tra i cimeli familiari più preziosi: “L’importante non è partecipare ma vincere. Magari per sorteggio”. Quindi senza neppure prendersi la briga di partecipare.
l'editoriale
La primatista e la perdente
di Marika Damaggio
A guadagnare l'attenzione, l'8 marzo e il resto dell'anno, sono le donne dei record. Se non si rientra in questa fattispecie altisonante, spesso gonfiata al rialzo, non resta che il silenzio, l’indifferenza, la colpa di essere un po’ così: modeste