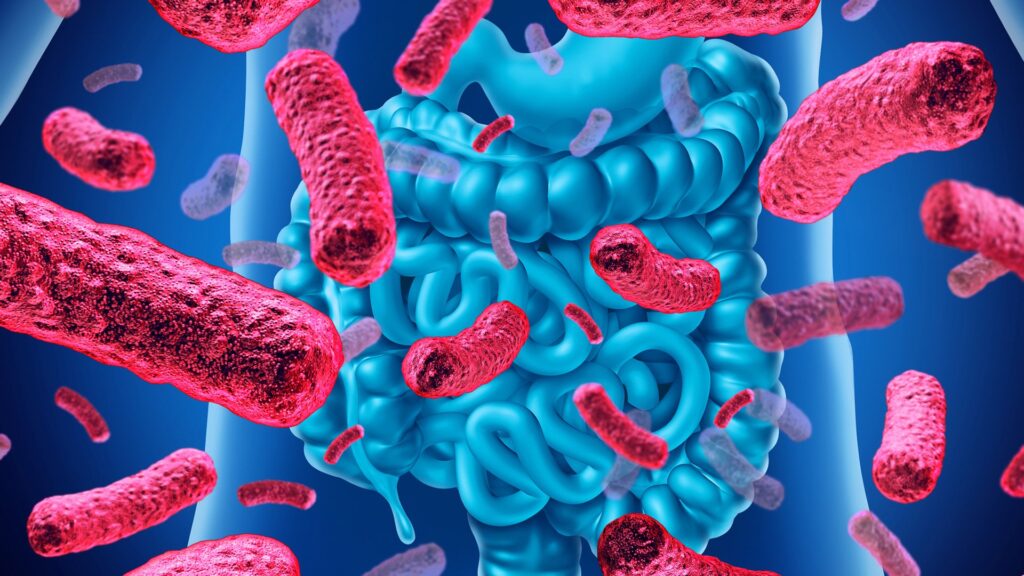Editoriale
lunedì 27 Marzo, 2023
Le cucine e i bagni popolari che davano una risposta ai bisognosi
di Elena Tonezzer
In piazza Garzetti, a Trento, dal 1906 al 1970 sono rimaste in funzione le cucine e i bagni popolari. Segnò il passaggio dalla beneficenza religiosa alla responsabilità pubblica

Chi si occupa dei bisogni dei poveri? Fino all’affermazione dello stato sociale e delle sue funzioni, gli aiuti venivano per lo più da organizzazioni filantropiche. Il passaggio dalla beneficenza religiosa e privata a quella dell’amministrazione pubblica, ha comportato la progressiva responsabilizzazione della politica e dei suoi rappresentanti nei confronti dei bisogni di tutta la cittadinanza.
A Trento c’è un edificio che più di altri segna una tappa locale dell’impegno del Municipio verso le persone meno abbienti. Oggi, chi passa in piazza Garzetti, in centro storico, tra il Tribunale e piazza Fiera, difficilmente immagina quanto quel palazzetto in stile liberty a due piani, dal 1906 – anno dell’inaugurazione delle cucine e dei bagni popolari – fino al 1970, quando chiude, sia stato centrale nella vita di migliaia di concittadini e concittadine.
A inizio Novecento, i liberali alla guida del Municipio di Trento iniziano a muoversi per risollevare le condizioni di vita della popolazione più bisognosa, animati da paternalismo, ordine e igienismo, come sollecitava la scienza dell’epoca. A proposito del progetto della cucina popolare, il consigliere comunale Giuseppe Stefenelli interviene il 15 luglio 1904, sostenendo che «sarà destinata a fornire ai meno abbienti un cibo semplice, sano e nutriente al prezzo di costo. Ogni idea di speculazione deve restare esclusa». La costruzione del nuovo edificio, progettato da Emilio Paor, risponde alle esigenze di razionalità e decoro tipiche di quel clima politico. Anche i socialisti salutano con soddisfazione l’apertura di quel nuovo servizio, dove si trova un pasto caldo economico e la possibilità di lavarsi.
Al momento dell’apertura, il Comune serviva un pranzo composto da mezzo litro di minestra in brodo, un pezzetto di carne lessa con l’«appresso» (cioè il contorno, patate o fagioli), tre grossi pani o polenta; la cena consisteva in un piatto di carne con due panini o polenta. Gli elenchi degli alimenti acquistati rimandano a una cucina molto diversa dalla attuale. L’olio d’oliva è surclassato dall’uso del burro e dello strutto, quasi non esistono la pasta e le verdure fresche (difficili da conservare senza frigoriferi). Compare il baccalà e impera fino al 1907 la farina di mais per fare la polenta, causa principale di una terribile malattia molto diffusa nel Trentino di quegli anni, la pellagra. Proprio a questo proposito, pochi mesi dopo l’inaugurazione della cucina popolare, il Municipio di Trento scrive alla Luogotenenza di Innsbruck con la richiesta di un finanziamento dal “fondo pellagra” per sostituire la somministrazione della polenta con il pane, molto più costoso. Nella lettera si legge che «la cucina popolare […] deve essere considerata come locanda sanitaria».
La cucina era stata progettata per garantire fino a 400 pasti in due ore di servizio, e dall’apertura nel 1906 fino al 1916 serve in media più di 85.000 pasti all’anno. Le cronache descrivono il ‘cliente’ tipo come un operaio, soprattutto edile, che si serviva alla cucina economica perché lontano dalla famiglia. La frequentavano anche le donne, alle quali era riservata una sala separata.
Il richiamo alla separazione fra maschi e femmine e alla decenza è costante e rigoroso soprattutto nei bagni. Ai clienti veniva consegnato il sapone e la biancheria pulita, da restituire alla fine dei venti minuti concessi a chi sceglieva la vasca (più costosa) e ai 15 minuti riservati alla doccia.
L’utilità della struttura non viene meno anche dopo il passaggio del Trentino al Regno d’Italia. I poveri degli anni Venti, i disoccupati degli anni Trenta, i reduci e gli sfollati del secondo dopo guerra, fino agli esclusi dal miracolo economico degli anni Sessanta, continuano a salire le scalette che portano dentro quell’edificio.
Le cucine e i bagni popolari furono la risposta ad un profondo e duraturo bisogno sociale che qualcuno, sei anni dopo la chiusura, ancora rimpiangeva. Il 26 maggio del 1976, un residente nelle Androne scrive al quotidiano Adige che dopo la chiusura degli ultimi bagni pubblici rimasti dopo quello di Piazza Garzetti, non sapeva più dove potersi lavare.