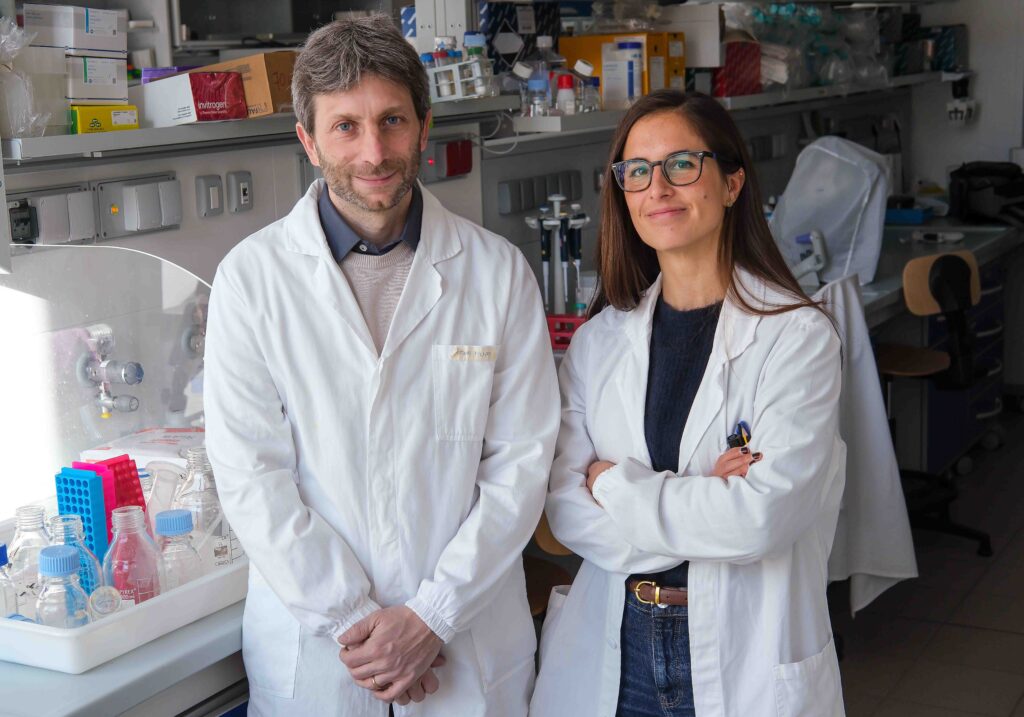l'editoriale
venerdì 1 Agosto, 2025
La montagna dell’emoji
di Fabio Gobbato
I social hanno modificato il nostro rapporto con la fruizione di qualunque tipo di esperienza. Documentare di esserci è a volte più importante che esserci.

La settimana scorsa, sul giornale altoatesino per cui lavoro, SALTO, Lisa Maria Gasser ha pubblicato una splendida riflessione personale scritta a partire dalla visione di uno spettacolare video di due influencer cinesi che arrivavano in Gardena alla ricerca della montagna emoji. Secondo loro la cresta seghettata del Seceda, ripresa frontalmente, corrisponde infatti all’emoji della montagna️.
Era quello quello lo scopo principale del loro viaggio, farsi un selfie davanti all’emoji. Un video, insomma, che meriterebbe una sorta di trattato sociologico dal titolo «Strani giorni», come il pezzo di Battiato.
Perché ciò che accade in quelle immagini è più di un viaggio: è un rito mediatico. Una narrazione digitale perfettamente costruita in cui la montagna non è più luogo di avventura, di conquista, di riposo, non è un posto in cui l’essere umano cerca di ripristinare un contatto con la natura, ma è semplicemente sfondo per i propri selfie. Per carità, l’ansia da autoscatto non deve sorprendere per nulla. È semplicemente lo specchio dei tempi: i social hanno modificato il nostro rapporto con la fruizione di qualunque tipo di esperienza. Documentare di esserci è a volte più importante che esserci.
I protagonisti del video non cercano rifugi né raccontano fatiche. La prima frase, tradotta con ChatGpt (ma validata da una ragazza cinese) suona così: «Questo è un parco giochi estivo senza soffitto. I prati fioriti sono tappeti, le cime montuose sembrano castelli dipinti». Per questo chi invita a non trasformare le montagne in Disneyland non si discosta dalla percezione di molti che vengono da fuori. E nel parco giochi ci si muove semplicemente per saltare da una giostra (i nostri impianti a fune) all’altra con biglietto cumulativo da 100 euro che permette un uso illimitato delle cabinovie per andare alla ricerca dei «punti foto» drammaticamente segnati anche sull’asfalto con l’icona della macchina fotografica. Tutti alla ricerca del luogo suggerito dall’algoritmo perfettamente guidati dal segnale Gps. I protagonisti del video lo dicono chiaramente, tra una risata e una battuta ben montata: «Questa è la lazy guide alle Dolomiti», una guida per persone pigre. E ciò che colpisce di più è il ritmo. Loro – come migliaia di altri – non si fermano mai. In un giorno: Seceda, Lago di Braies, Santa Maddalena. Tre «punti selfie», tre conferme visive alle aspettative fornite sempre dall’algoritmo. Nessuna sosta. Nessuna esplorazione. Come se il viaggio fosse una raccolta di figurine. Ce l’ho, ce l’ho, manca. Ma di tutto ciò al territorio cosa resta? Chi ci guadagna?
Il paesaggio dolomitico, intanto, diventa sfondo totalmente sradicato dal contesto, viene ridotto a «quinta» tipo The Truman Show. E quel che resta della montagna reale – i sentieri, i silenzi, e, soprattutto, le storie – non viene neppure messo ai margini, ma spinto giù dai margini, viene letteralmente fatto sparire nel baratro.
Non bastasse, questa idea della montagna emoji, è un ulteriore passo in avanti: se verso nuovi splendidi lidi del turismo come fonte di ricchezza o in direzione dell’orlo del precipizio, dipende dai punti di vista. Il Seceda, dunque, abbiamo scoperto, non è solo una tappa a cui mettere la spunta sulla mappa globale dell’Instagrammabile ma, per la fortuna di chi gestisce gli impianti a fune (un po’ meno per chi non vive di turismo) è la materializzazione di una delle centinaia di icone presente nei nostri smartphone, quella che rappresenta la montagna. Non una montagna. Ma «la» montagna. È come se chi si fa un selfie con dietro «il Seceda» trovasse una sorta di Graal, l’essenza della montagna.
Ma se una montagna «vera» fatta di terra, roccia, e erba viene identificata con un’icona da inserire nei messaggi Whatsapp bisogna prendere atto che il turismo digitale sta ridisegnando confini, ritmi e persino il senso stesso dell’esperienza alpina.
Il turismo che sta investendo l’Alto Adige in questi «strani giorni» non cerca più esperienza ma rappresentazione. Gli influencer seguono percorsi suggeriti dagli algoritmi e non dalle guide cartacee di una volta. E i turisti, soprattutto da Oriente, ma non solo, rispondono a quel richiamo. Non è un caso se in piena stagione sul Seceda si possono contare anche 5-6.000 presenze al giorno, molte delle quali concentrate attorno a pochi punti fotografici, come se tutto il resto potesse essere ignorato.
Una decina di anni fa Idm&friends ci avevano raccontato di voler puntare sul «turismo di qualità» proveniente anche da nuovi mercati e di voler «destagionalizzare» per evitare i picchi di afflusso che creano parecchi disagi tra luglio e agosto e tra Natale e Carnevale. Lo ricordate? Il risultato è quello che stiamo vivendo negli ultimi tempi: gli alberghi sotto le tre stelle sono praticamente spariti, gli Airbnb sono decuplicati e l’Alto Adige è preso d’assalto 11,5 mesi all’anno con frotte di turisti che in 4 giorni riescono a farsi circa 248 selfie in una quindicina di punti fotografici intelligentemente indicati con le icone sull’asfalto.
La causa prima di questa situazione è sicuramente dei tempi (bui) che corrono. La febbre da selfie guidata da hashtag e algoritmi imperversa ovunque, nelle città d’arte, nelle città normali che si trovano ad avere casualmente qualche attrazione, in mille altri posti naturali. Non è che si può pensare che l’Alto Adige possa non esserne contagiato. Ma dal momento che la natura è il più importante dei beni comuni, chi ci governa ha il dovere morale di agire, con qualcosa di diverso da leggi per ridurre i posti letto che in realtà li aumentano fino alla saturazione totale.
Perché non tematizzare finalmente – senza drammi, eh – l’impatto che tutto questo ha sulla comunità locale, che si ritrova ogni estate con il territorio trasformato in un gigantesco studio cinematografico a cielo aperto. L’impatto che ha sull’ecosistema, sotto pressione crescente. L’impatto che ha sulla cultura stessa del viaggiare, per non parlare di quello sulla «cultura dell’andare in montagna», rimasta tale per le poche migliaia di persone che sono iscritte al Cai e all’Alpenverein.
Quello che serve adesso non è solo una strategia turistica. Serve una visione politica. Serve qualcuno che dica, con onestà: basta, cambiamo rotta, applichiamo sempre più il modello di slow tourism che stanno faticosamente cercando di portare avanti in val di Funes. Ah, no, scusate, ci sono due piccoli problemi. Nel 2026 abbiamo le Olimpiadi invernali e nel 2031, la val Gardena, il luogo più overturistico dell’Alto Adige e forse dell’arco alpino, per i mondiali ospiterà i mondiali di sci alpino in quella data. Attenzione a non farsi ancora del male.
*Giornalista di salto.bz