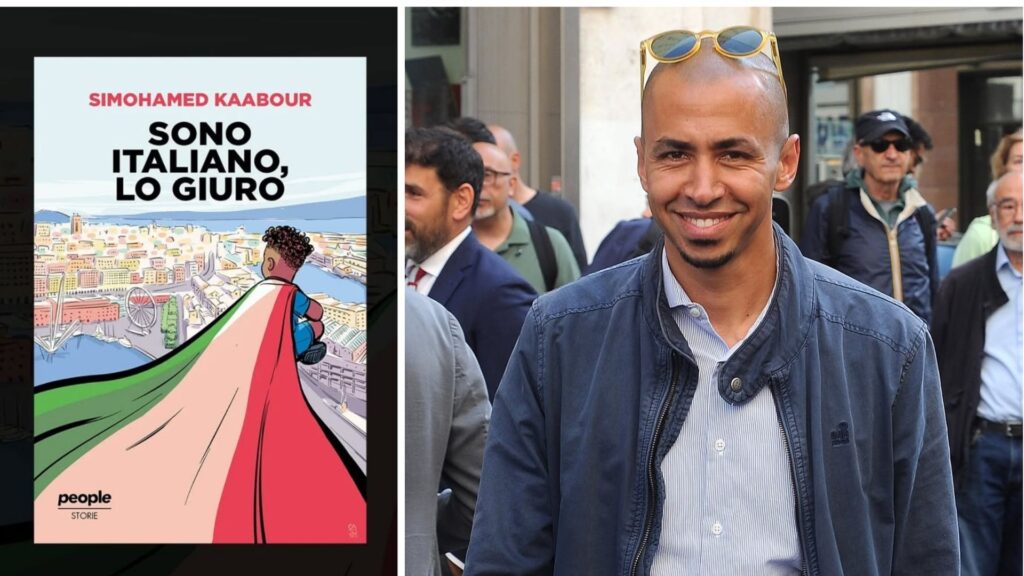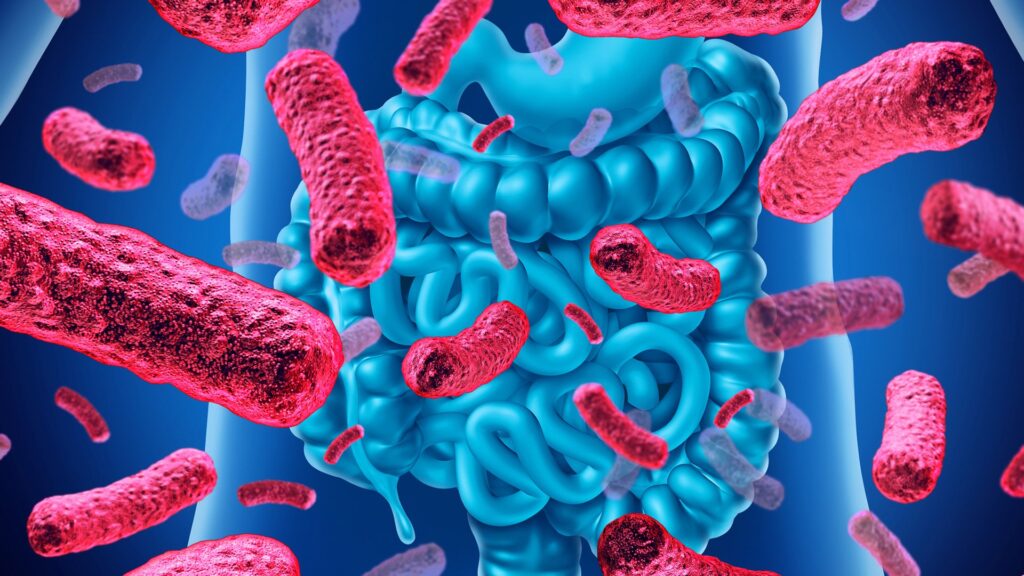La protagonista
mercoledì 22 Maggio, 2024
La grande filosofa Leela Gandhi è a Trento: «Mai come oggi è il tempo della non violenza»
di Sara Alouani & Simone Casciano
La filosofa del postcolonialismo si racconta: «Siamo tutti nipoti del mio bisnonno il Mahatma Gandhi. I giovani sono un faro di speranza»

I pensatori che lasciano un segno sono quelli che spingono le persone a mettere in discussione le loro idee, i loro principi. Chi ci porta verso il cambiamento o, come lo definisce nel libro omonimo Emanuele Coccia, verso una metamorfosi che è «il respiro che permette alle forme di legarsi tra loro e di passare l’una nell’altra». A questa categoria di pensatori appartiene Leela Gandhi, pronipote del Mahatma Gandhi, tra le prime intellettuali a concettualizzare il pensiero postcoloniale. Leela Gandhi, professoressa alla Brown University negli Stati Uniti, sarà protagonista oggi di una conferenza aperta al Dipartimento di Lettere di Trento in via Tommaso Gar. L’appuntamento è alle 18.
Professoressa Gandhi quale sarà il tema al centro della sua Lecture con gli studenti di Trento?
«Sarà una lezione concentrata sul tema della conoscenza e dell’azione non violenta. Come pensare secondo un pensiero non violento, come agire secondo precetti non violenti un tema oggi ancora più importante. Proprio in questi tempi di guerra, dobbiamo affermare l’importanza del pensiero non violento. Penso per esempio all’inaccettabile repressione violenta delle proteste degli studenti in America, ma anche in Italia, che lottano per la causa palestinese. Se quella repressione è inaccettabile, la protesta non violenta dei giovani è invece un faro di speranza. Queste nuove generazioni ripudiano la violenza e portano avanti un messaggio tanto rivoluzionario quanto semplice, perché alla fine chi può davvero dirsi a favore della violenza? Quindi si saranno davvero tempi di guerra questi, ma sono anche i tempi della non violenza».
Leela Gandhi, quanto pesa essere la pronipote di Gandhi nella sua vita e nella sua carriera. È sicuramente motivo di orgoglio ma è anche una grande responsabilità?
«Ci ho messo molti anni a capire come rispondere a questa domanda e forse mi sono avvicinata alla conclusione più corretta. Gandhi è nato in un contesto di “clashing cultures” dove il privilegio era frutto di una cultura imperialista e dove importava di chi fossi figlio, da quale quartiere provenissi, quali contatti avessi. Gandhi a 40 anni fece qualcosa di davvero decisivo e rilanciò il concetto di famiglia allargandola a tutto il mondo. Io certamente sono nipote di Gandhi ma anche tu, allo stesso modo, sei nipote di Gandhi. Siamo tutti nipoti di Gandhi».
Stiamo attraversando un momento storico in cui pare che il concetto di «orientalismo» coniato da Edward Said a fine anni Settanta stia tornando? Pensiamo agli slogan politici anti-migrante o alle polemiche contro le scuole chiuse per festeggiare la fine del Ramadan. O forse è un concetto che non abbiamo mai superato?
«Quello che mi disturba di più è l’islamofobia dilagante e non solo in Occidente ma anche in Asia. Per me è intollerabile in qualsiasi Paese succeda. Sta via via diventando una discriminazione di default. Tornando a Said, toccò una serie di temi come la guerra in Palestina e coniò moltissimi concetti che derivano dalla divisione chirurgica del mondo causata dal colonialismo. Parliamo di una tecnologia della separazione e l’orientalismo è uno di questi aspetti postcoloniali. Noi dobbiamo essere in grado di reinventare questa impresa coloniale che è stata ereditata nell’era postcoloniale».
Non solo islamofobia ma parliamo di un’idea di subalternità della persona migrante (di qualsiasi religione essa sia), che è sempre in una condizione di iniziale svantaggio rispetto al resto della società occidentale? Come possiamo superare questo stigma?
«Il problema è cosa è uno straniero? George Orwell parla di qualcuno che è diverso ma che allo stesso tempo intimo e non poi così lontano. E questa è la chiave. Possiamo e dobbiamo trovare altre forme di intimità che ci leghino. Abbiamo paura del diverso ma credo che la paura più grande sia l’attaccamento che proviamo a quello che già conosciamo. Non vogliamo lasciarlo ma esigiamo che gli altri lo conoscano affinché diventino come noi. Tolleriamo solo ciò che è nostro e questo è un grande limite. Dovremmo, invece, interrogarci sempre su tutto, come ci insegnano alcune scuole di pensiero indiane, e aprirci a nuove possibilità per scoprire ciò che è vero. Dobbiamo andare oltre lo scetticismo e distruggere questa subalternità condividendo ciò che sappiamo e investendo in nuove forme di intimità totalizzanti».
A proposito di nuove forme di intimità, pensiamo alle seconde e terze generazioni di migranti che progressivamente stanno dando vita a una nuova forma di linguaggio che sta nel mezzo. Come i rapper che utilizzano parole in arabo o urdu nei pezzi in italiano o inglese o scrittori vittime di una schizofrenia bilingue, siamo forse nella direzione giusta?
«Assolutamente sì. E questo è anche il mio lavoro (ride ndr). Ho distrutto le mie certezze indiane e urdu contaminandole con elementi occidentali, americani. Creare una nuova intimità è eccitante. Ma pensiamo anche alla Terra come una forma di intimità. La stiamo distruggendo insieme: migranti e non, occidentali e non. Usciamo da questa tediosa concezione binaria del noi e voi e concentriamoci sul costruire nuovi progetti per salvare la Terra, insieme».
Quanto sono importanti la letteratura e il linguaggio ibrido all’interno di un processo di interazione postcoloniale? Quanto è importante portare l’impronta della propria cultura d’origine in letteratura?
«Molto importante. Mi piace molto quest’idea di coniare neologismi, nuovi concetti. La narrativa ti permette di raccontare nuove storie, nuovi modi di pensare. È fondamentale condividere racconti e rinarrare momenti ed avvenimenti. La poesia, poi, ti aiuta a superare transizioni difficili, ti trasporta da uno spazio all’altro in pochi secondi e ti lascia vivere un’avventura linguistica anche in tre lingue diverse. C’è qualcosa di molto poetico ma anche politico in tutto questo».
Lei, assieme ad altri pensatori come Homi Bhabha, Gayatri Chakravorty Spivak, Amitav Gosh, è stata tra i pionieri del pensiero postcoloniale e della critica al colonialismo. Un pensiero non subito accettato a livello accademico. Quanto le fa piacere invece che sia oggi alla base delle lotte intersezionali dei giovani attivisti?
«Non so se li ho ispirati, ma posso dire che io sono molto ispirata da loro. Questa nuova ondata è iniziata con il movimento Black Lives Matter e la parola chiave è proprio quella che diceva prima: intersezionalità. E si riallaccia a un lungo filo di lotte. L’intersezionalità esisteva già ai tempi delle lotte per i diritti civili negli anni ’60, l’abbiamo persa dopo quando l’anticolonialismo si è concentrato sulla rivendicazioni di indipendenza di Stati nazionali e quindi avvicinandosi al nazionalismo. Sono felice se il pensiero postcoloniale ha contribuito a riaccendere la coscienza intersezionale».
Ha parlato di nazionalismo. La preoccupano i crescenti nazionalismi che sorgono in vari Paesi del mondo?
«Sì, dobbiamo trovare una soluzione. E credo che sia anche una responsabilità delle generazioni più giovani. La politica va riformata, dobbiamo riportare l’etica al centro del suo agire. Quello che vedo oggi è un’assenza di responsabilità da parte della classe politica e un disinteresse da parte delle persone. Ma non possiamo rinunciare alla politica, spero che le generazioni più giovani sappiano energizzarla, ripensarla e costringere i politici a essere responsabili delle loro azioni. Contro chi prova a dividere, soffiando sulle differenze dobbiamo creare una sottocultura di tolleranza e amore costante, che ci tenga al riparo dal cinismo e della divisione. Quello che mi piace dei giovani è che è una generazione che riconosce il proprio privilegio e non si identifica con esso».
La critica al colonialismo storicamente è stata una critica al modo di operare dei Paesi occidentali e ad una lettura della Storia in chiave occidentale. Oggi però vediamo anche Paesi di altre parti del globo applicare gli stessi schemi di sfruttamento.
«Sì, è vero, ci siamo resi conto che il colonialismo è una forma di potere mobile e modulabile. Al centro di esso c’è l’idea di lesione strumentale. L’idea di ferire qualcuno abbastanza da spezzare la sua volontà, ma tenendolo in vita in modo da utilizzarlo come uno strumento. È l’idea alla base del colonialismo ma che ora ravvisiamo in tanti Paesi e anche all’interno della nostra società, nei rapporti tra uomo e donna, tra cittadini e migranti, ovunque ci sia subalternità o la si crei artificialmente. Per questo dobbiamo sempre essere consapevoli della sua esistenza e denunciarlo in tutte le sue forme».
La storia
Stava, Alma Trettel sopravvissuta alla tragedia. «Ero a tavola con marito, figlio e mamma: sono morti tutti. Prima un sibilo poi il fango in bocca»
di Alberto Folgheraiter
Il figlio Marco oggi avrebbe 44 anni e il suo corpo non è mai stato ritrovato. Il ricordo della donna, 71 anni, che ha perso in un istante tutta la sua famiglia. «Qualcuno mi ha sollevata, mi hanno messa su un pezzo di legno, forse una porta»