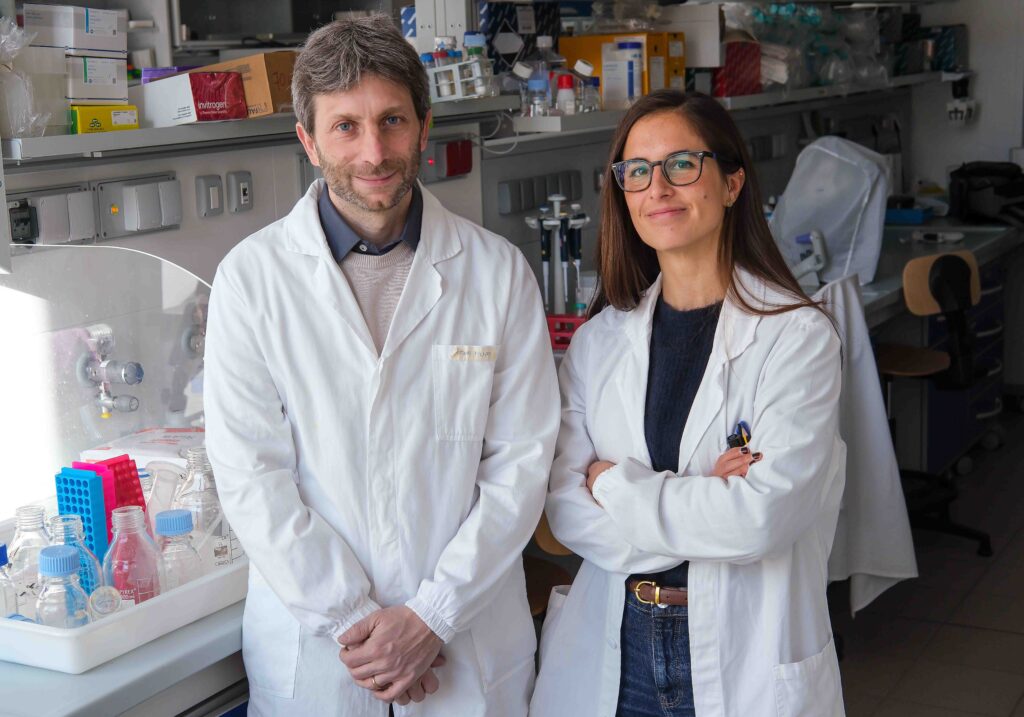L'editoriale
martedì 29 Luglio, 2025
Il colloquio disertato, una protesta senza obiettivo
di Maria Prodi
Gli studenti vanno ascoltati, non solo all’orale, ma per cinque anni. Un ascolto attivo, sollecito e sollecitante, che dia il gusto della sfida, del confronto, della costruzione ed espressione della propria maturità

Che bello quando i tormentoni dell’estate erano motivetti orecchiabili e un po’ assillanti che sbucavano da ogni radiolina. Mentre Israele bombarda vicini e lontani e Trump reinventa con penose improvvisazioni la commedia dell’arte minacciando il commercio mondiale, in questa estate qualunquista il tormentone è l’esame di maturità alla «famolo strano», come direbbe Verdone. La scena mediatica è offerta non al mezzo milione di ragazzi che si sono spremute le meningi per trovare collegamenti fra la foto della pecora Dolly, un poeta bucolico dell’antichità latina, la funzione che esprime la crescita demografica dei conigli e il cammello di Nietzsche.
Un imbronciato ragazzo padovano ha per primo guadagnato una visibilità confacente ad una felice carriera da influencer, annunciando la sua defezione dall’orale. Immediatamente altri due o tre tormentati eroi hanno prenotato i titoloni sui social esibendo con toni altrettanto impermalositi il loro esonero dal colloquio. Un tardivo protestatario ha richiamato i media sulla sua persona chiedendo a Valditara (che non ne ha il potere) la trasformazione del suo 83 in un minimale 60. Nessuno di loro ha rischiato la bocciatura. Tale accortezza ha permesso l’ottenimento di una enorme visibilità gratis e senza rischi. Nessuno di loro ha avuto l’avventatezza di esporre precise critiche o auspici di riforma del sistema (non sappiamo neanche se protestavano contro il colloquio, o contro l’esame, o contro il sistema scolastico nel suo complesso o contro la società). Tale ottimale decisione, di attuare una protesta senza una esplicita piattaforma rivendicativa, ha consentito loro di ricevere da innumerevoli intellettuali ed esperti, ma anche cantanti e psicologi in cerca di pubblico, investiture ed affiliazioni alle proprie convinzioni.
Chiunque poteva rivestire di significati cangianti la loro fulminea notorietà, proiettando su di loro il proprio pistolotto. Nessuno di loro, pur dicendosi risentito per la scarsa empatia o comprensione da parte dei suoi professori, ha reso noto se nel corso dei cinque anni aveva espresso obiezioni e segnalazioni, se aveva coinvolto il dirigente scolastico, sollecitato azioni comuni con i compagni di classe contro comportamenti scorretti dei docenti. Ci sono ottimi docenti, docenti dignitosi e docenti pessimi. I dirigenti non possono che provare a valorizzare i primi, far crescere i secondi e contenere i terzi. Possono poco, ma almeno qualcuno ci prova. Meglio farebbe chi di dovere a sceglierli meglio, i docenti.
Se il problema non erano i docenti ma l’assegnazione di voti, in generale, o la necessità di sostenere esami o lo stress correlato ad un qualsiasi tipo di valutazione cominciamo a denunciare la competitività del sistema del calcio o del tennis. La scuola è decisamente meno competitiva di un torneo amatoriale in parrocchia, e il tifo dei genitori spesso meno intenso. Siamo sicuri che spianare ai ragazzi il sentiero e liberarlo da qualunque ostacolo sia valorizzante?
L’esame di maturità, detto esame di Stato nella formula attuale, è stato sostanzialmente mantenuto da governi di sinistra, da governi di destra, dai governo di destra-sinistra-populista.
Le norme sui crediti (perché non semplicemente la media dei voti?) risalgono al 1997. Con tutti i relativi pasticci sui crediti formativi e crediti scolastici. Più punti al percorso scolastico, più punti alle prove di esame, colloquio su più materie, colloquio interdisciplinare, collegamenti interdisciplinari: sono state modifiche non molto profonde, la struttura è restata più o meno quella.
Quali sono i problemi mai affrontati dell’esame di Stato? Per esempio, che è un esame quasi pro-forma, essendo promossi più del 99 per cento dei concorrenti. Decisamente più ansiogeni saranno gli esami o i concorsi a cui dovranno partecipare i ragazzi a scopi selettivi, per il proseguimento degli studi o per lavoro. Ci si può domandare a cosa serva un esame il cui esito è quasi scontato. In realtà, io penso che un impegno conclusivo, anche abbastanza solenne, sia un buon viatico per formare la personalità e segnare l’uscita dalla scuola verso il mondo definitivamente adulto.
Il problema è che l’esame così come è, al di là del rito, non ha alcun altro utilizzo. Per la maggior parte dei casi il voto preso all’esame non entrerà mai più in gioco. Per chi farà l’università servono i test di ammissione, che non tengono conto dell’esito dell’esame di stato, e nel curriculum figurerà il voto di laurea, non certo quello della maturità. E ciò è quasi inevitabile posto che ampie ricerche dimostrano che i criteri di assegnazione dei voti di maturità sono coerenti con gli standard di valutazione abituali. I quali sono diversissimi, sia fra territori che da insegnante a insegnante, rendendo molto aleatorio il voto in uscita, quindi poco attendibile e utilizzabile comunque tale attribuzione, anche per il mercato del lavoro.
Abbiamo, quindi, la non facile situazione di un fronte tradizionalista che esalta il valore dell’esame, ma non ama i test oggettivi tipo Invalsi che sarebbero gli unici a dare almeno parzialmente un valore nazionale a qualche prova e ha solo nostalgia per prestazioni nozionistiche ed esecutive vecchio stile.
All’opposto c’è un fronte antivalutazione che, pur essendo sia il sistema dei crediti sia la legge che presiede oggi agli esami di Stato prodotti da governi di sinistra, solidarizza commosso con le proteste degli auto-esonerati.
Il ministro come sempre sull’onda dell’attualità mediatica prospetta un cambio di marcia, dopo aver minacciato la bocciatura per chi boicotta l’esame. Non servono norme-spot, e meno che mai circolari-spot che non normano nulla. Ci sono infiniti modi per boicottare un colloquio, qualsiasi sia la formula prescritta.
Pensiamoci bene a cosa vogliamo da questo benedetto esame.
Gli studenti vanno ascoltati, non solo all’orale, ma per cinque anni. Un ascolto attivo, sollecito e sollecitante, che dia il gusto della sfida, del confronto, della costruzione ed espressione della propria maturità. Per molti ragazzi abituati nelle interrogazioni a ripetere frasette o formule apprese il colloquio orale è la prima occasione da giocarsi per tenere il filo del discorso. Mi piacerebbe un orale in cui si offre una tesi e si dà tempo al candidato di organizzarsi una propria elaborazione, pro o contro, con relativa discussione. Qualcosa come la disputatio di quei medioevali tanto vilipesi, che inventarono l’università. E mi piacerebbe che non si aspettasse la fine della quinta per lasciare agli studenti l’uso della parola e del pensiero.
*Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo del Primiero