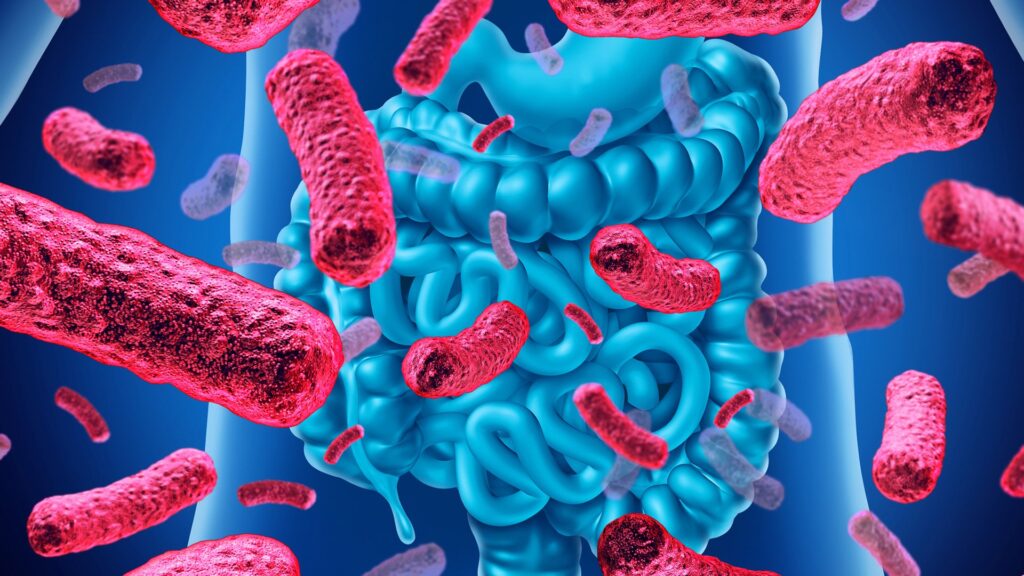campi liberi
sabato 9 Dicembre, 2023
I clown sociali tornano in ospedale dopo la pandemia: «Empatia fondamentale, il resto s’impara»
di Davide Orsato
Come funziona la clownterapia? A spiegarcelo Francesca Bonazza, alla guida dell'associazione di volontari «clown family»

In principio era Patch Adams, il leggendario medico americano: camice e naso rosso. Tutti e due gli elementi erano fondamentali: la divisa del medico, il segno distintivo del clown. Oggi i suoi eredi non danno tanto importanza al primo: nella maggior parte dei casi non sono dottori e non vogliono passare per tali. E poi non ci sono solo gli ospedali, ma anche le case di riposo, i centri diurni, le scuole… La clownerie «sanitaria» (o meglio, «sociale», definizione che ora viene preferita) può contare su un piccolo esercito di appassionati in Trentino, con tante associazioni che vi si dedicano. Dal primo dicembre, è tornata, ufficialmente anche nelle strutture dell’Apss. È un piccolo segno, tra i tanti, che l’«era Covid» ormai è finalmente, anche se lentamente, conclusa. La convenzione con una delle associazioni, infatti, era scaduta durante la pandemia e non era più stata rinnovata. Da inizio mese (e fino a novembre 2023) potranno tornare «stabilmente» nelle corsie degli ospedali con dipartimenti pediatrici i volontari di «clown family», realtà con sede ad Arco, ma attiva in tutto il Trentino. A guidarla c’è Francesca Bonazza, libera professionista, una laurea in biotecnologie alle spalle. In corsia si fa chiamare «clown Pinturicchio».
C’è l’accordo con la sanità trentina. Quando tornerete fisicamente in ospedale?
«Prima di Natale, il 23 dicembre saremo al Santa Chiara di Trento».
I destinatari, naturalmente, saranno i bambini…
«Sì, è quello che prevede l’accordo con l’Apss, ma nel frattempo la clownterapia è qualcosa che si è estesa ad altre fasce d’età, ad altre realtà. Siamo operativi anche negli hospice oncologici, ed è uno dei servizi più belli che si possa fare».
Negli ospedali i clown entrano in reparto con l’intenzione di dare un po’ di sollievo. Ma c’è sempre un elemento di sorpresa e qualcuno potrebbe non gradire. Come vi comportate?
«Si tratta di una parte fondamentale del nostro operato: si deve entrare in sintonia con le persone e saper reagire correttamente ai rifiuti è importante. Quando qualcuno non vuole vederci ci allontaniamo con discrezione, sicuri, però, di avere scalfito un po’ anche la sua superficie».
Il clown è una figura istrionica: se si vanno a guardare le vostre foto il look appare decisamente più sobrio.
«Proprio perché la cosa importante, per noi, è coinvolgere i pazienti, la “divisa” è sempre meno importante. Il trucco può spaventare, ne facciamo volentieri a meno o, se c’è, è molto leggero. Certo, c’è il naso rosso che ci contraddistingue, ma anche quello lo togliamo se c’è bisogno di discrezione, magari appoggiandolo sul letto del paziente, per stabilire un primo contatto».
La clownterapia in ospedale nasce negli anni ‘80. Da allora è passato molto tempo. Cosa è cambiato?
«La figura ha avuto un’evoluzione importante. Innanzitutto è uscita dagli ospedali toccando tutti i luoghi in cui c’è bisogno di sollievo. Infatti oggi preferiamo definirci “clown sociali”».
Passando alla vostra realtà: chi fa parte di «Clown Family». E se qualcuno vuole fare il volontario che percorso deve seguire?
«Siamo una quarantina, perlopiù di stanza tra la Busa e Rovereto. L’età media è di 35 anni, ma abbiamo volontari di 18 come di 64. Ogni anno organizziamo un corso di formazione in autunno, poi per chi si vuole avvicinare al nostro mondo c’è un colloquio conoscitivo»
Che caratteristiche deve avere un buon «clown sociale»?
«La prima è l’empatia. Il resto viene da sé. Non occorre essere bravi con i giochi di prestigio o con la giocoleria. Sono cose che si imparano. E poi cerchiamo di valorizzare sempre i talenti naturali. Anche la battuta pronta conta molto».
Un momento che ricorda?
«Eravamo in Kosovo. Abbiamo visitato i tre ospedali con reparti pediatrici e delle scuole. Poi siamo andati in una casa di riposo gestita dalle suore di madre Teresa. In questi frangenti conta molto la comunicazione non verbale, un aspetto che cerchiamo sempre di curare. Una donna presente mi ha preso la mano, me l’ha tenuta per tutto il tempo. Non so che dicesse, ma aveva bisogno di dirlo e a me basta questo».
La storia
Coppia di Fiemme in gara ai mondiali di trasporto moglie: al vincitore birra quanto il peso della compagna
di Samantha Deflorian
In Finlandia 18 nazioni al via, oltre 200 partecipanti. Tra loro anche Barbara Cornetti e Christian Deflorian, già famosi per i loro viaggi nel mondo a bordo del loro van
Il caso irrisolto
Spariti da Fiavè: dopo 13 anni Renato Bono e Carla Franceschi sono ancora nella lista degli scomparsi
di Benedetta Centin
Dovevano imbarcarsi per il Kenya ma di loro si sono perse le tracce esattamente tra il 2 e il 3 luglio 2012. Passaporti e valigie ancora da ultimare sono rimasti a casa
L'intervista
Adriano Panatta: «Voglio morire 5 minuti dopo Bertolucci e fargli il gesto dell'ombrello. Sinner? Inscalfibile come le sue montagne»
di Lorenzo Fabiano
Il celebre tennista si racconta: «Il mio Wimbledon? Paolo Villaggio era il mio finto coach. Per vincere con Alcaraz Jannik deve servire almeno il 70-75% di prime palle»