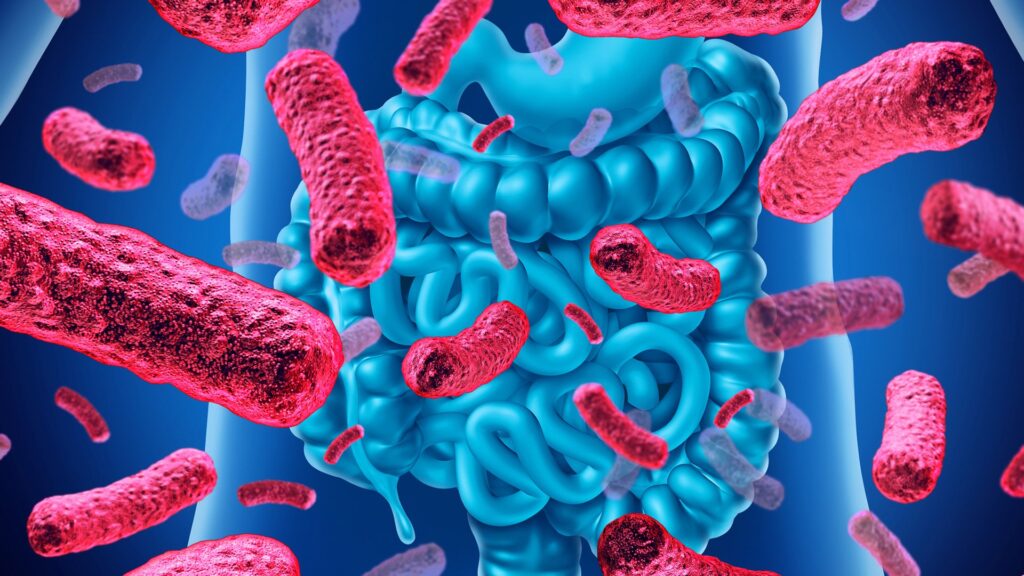Cinema
sabato 19 Novembre, 2022
Filippo Marzatico e l’arte della fotografia sul set: «Voglio portare la mia luce nelle periferie»
di Simone Casciano
Il giovane talento trentino racconta il suo amore per il cinema nato quasi per caso, i primi set e la luce come faro del lavoro artistico

Filippo Marzatico risponde al telefono dal suo appartamento a Roma, zona Furio Camillo. «È un bel quartiere – ci dice – come spesso succede nelle grandi metropoli è a suo modo una piccola città con una sua identità ben precisa». Si trova a metà strada tra Cinecittà e Termini, Marzatico è quindi equidistante dal suo obiettivo finale e quei treni che lo portano in giro per lavorare sui tanti set che segue, le ultime tappe sono state Ostuni e Riva del Garda.
Classe 1992, Marzatico è di Trento ed è uno dei più promettenti giovani direttori della fotografia in Italia. Alcuni suoi lavori sono già stati in concorso al festival di Venezia e uno di questi, Inchei, per la regia di Federico Demattè, già intervistato sulle pagine de Il T, ha vinto il premio come miglior film.
E come Federico si è prima cimentato nella musica e nella scrittura, anche per Filippo il cinema è arrivato quasi per caso, con una laurea triennale in lettere antiche già in tasca e il progetto di continuare gli studi.
È andata davvero così?
«Mi fa un po’ ridere come sono andate le cose. Dopo essermi laureato in triennale in lettere classiche a Bologna ero felice dei miei studi e sicuro di continuare su quella strada. L’unico problema è che volevo andare in Francia, ma per farlo mi serviva una certificazione impossibile da ottenere in tempi brevi. Mi sono ritrovato quindi con un anno sabbatico e ho deciso di sfruttarlo iscrivendomi a una scuola di cinema a Bologna. Era un modo per soddisfare la curiosità che nasceva dalla mia passione per la pellicola ma non avrei mai pensato che sarebbe diventata la mia professione. Quando ho iniziato a seguire le lezioni non conoscevo nemmeno il ruolo di direttore della fotografia. Ma proprio quando abbiamo fatto il corso specifico su quel ruolo me ne sono innamorato, mi sono innamorato di quante cose si possono fare con la luce».
Ecco riesce a spiegare qual è il ruolo del direttore della fotografia? Perché credo che molte persone non lo conoscano precisamente.
«Penso che neanche la mia famiglia abbia ben presente cosa faccio (ride) me lo chiedono tutti. È un ruolo che al di fuori del cinema si conosce poco, ma è fondamentale. Se dovessi spiegarlo in poche parole direi che il direttore della fotografia è l’occhio e la mano del regista, si occupa dell’immagine a 360 gradi. È contemporaneamente capo del reparto macchina e architetto delle luci di una scena che, insieme all’inquadratura, sono i mezzi principali di narrazione scenica e costruiscono l’estetica di un film. È un ruolo ibrido che porta dentro di sé tante conoscenze tecniche (proiettori, luci, illuminazione), ma anche tanta sensibilità artistica e gusto estetico».

Dopo essersi innamorato di questo ruolo, quindi, decide di iscriversi al Centro Sperimentale di cinematografia di Roma?
Si esatto, tra l’altro nemmeno lo conoscevo il centro, ma in quel periodo (2017 ndr) rimasi molto colpito dalla fotografia di “Salto nel vuoto” di Marco Bellocchio fatta da Giuseppe Lanci, scoprì che insegnava al Centro e decisi di iscrivermi. Anche perché se si vuole fare cinema in Italia bisogna stare a Roma».
Come andarono le selezioni?
«Dure, tostissime, per la prima selezione bisogna portare 20 foto statiche, 10 con luce naturale e 10 con luce artificiale. Io non avevo quasi nessuna formazione tecnica, ma un forte gusto letterario che arrivava dai miei studi. Presentai 20 lavori che sembravano già quasi delle messe in scena e piacquero molto. La vera sfida arrivava dopo la prima selezione, sono dovuto andare a Roma e lì ti mettono davvero sotto pressione per testare come reagisci. Hai 20 minuti per realizzare due foto. Ricordo un enorme timer appeso al muro che ti ricordava costantemente quanto poco tempo avevi. Mi chiamò proprio Lanci per dirmi che ero entrato e solo allora gli dissi che lui era una delle ragioni per cui avevo scelto la scuola».
Ha fatto il triennio nel Centro dal 2018 al 2021 cosa ricorda di quegli anni?
Non per ripetermi ma Lanci è stato fondamentale, ci ha insegnato ad amare il nostro lavoro. Mi porto ancora con me alcune delle sue massime come: “per illuminare bisogna avere gioia”. Trovo sia una frase molto bella perché, in un ambiente lavorativo molto stressante tra aspettative su sé stessi e sugli altri molto alte, lui sottolineava l’importanza di metterci la gioia. “Meglio fare una fotografia espressiva ma pure un po’ imprecisa, piuttosto che un lavoro preciso ma freddo” è un’altra frase che non dimenticherò mai.
Poi era anche uno che sapeva essere duro eh, era l’uomo che quando un compagno di corso ha spostato la telecamera di 5 cm è uscito dall’aula urlando “l’inquadratura è sacra”».
Finito il triennio si è lanciato nel mondo del lavoro, con che prospettiva?
«Fondamentalmente ci sono due strade: o inizi da macchinista su grandi produzioni e poi cerchi di crescere di ruolo fino ad avere una chance oppure parti direttamente da direttore della fotografia su progetti piccoli, ma facendoti già conoscere per le tue capacità. Io ho scelto questo secondo percorso. La fortuna di aver fatto il centro è che ti costruisci già una serie di conoscenze tra i ragazzi che stanno seguendo negli stessi anni i corsi di regia o di recitazione. È così che ho conosciuto Simone Bozzelli con cui abbiamo realizzato Amateur che è andato in concorso a Venezia e ha avuto un buon successo».
Ecco: quali sono stati fino ad ora alcune dei suoi lavori più importanti?
«Sicuramente Amateur di Simone Bozzelli, poi naturalmente Inchei con Federico Demattè con cui ho lavorato recentemente anche sul set di Battima il corto realizzato con Indigo Film per Emergency e presentato alla Festa del Cinema di Roma. Però non ci sono solo i corti ho lavorato anche nel mondo della musica realizzando alcuni videoclip per artisti come Guè Pequeno e Marracash».

Uno dei lavori di Filippo Marzatico
Abbiamo sentito il lato della storia di Federico Demattè, ma come è stato per lei il set di Inchei?
«Mi ricordo che all’inizio non avevo capito subito che fosse trentino (ride), adesso ci scherziamo su e diciamo che “la nuova capitale del cinema italiano è Trento”. Mi ricordo che mi propose una sceneggiatura che poi all’incontro con Armando, il protagonista del film, e con la sua famiglia cambiò radicalmente e questa è stata una delle bravure di Federico. È stato molto bello vedere la storia maturare assieme ai suoi protagonisti. È stato un set bellissimo, girato durante il primo anno di covid, a fine estate e fu davvero liberatorio. Poi devo dire che non mi aspettavo di incontrare una realtà così forte da essere trascinante, parlo del mondo di questi ragazzi della Milano periferica. È stato un set girato tutto di un fiato in cui si perdevano i confini di ciò che era vero o falso».

Un’immagine dal set di Inchei
Da quello che racconta sembra che la relazione tra regista e direttore della fotografia sia fondamentale?
«Sì, ed è una delle cose più belle di questo lavoro, instaurare un rapporto di profonda fiducia reciproca. Conoscere così a fondo qualcun altro da capirsi senza nemmeno bisogno di parlarsi a volte. Molto banalmente il direttore della fotografia durante la produzione ha in mano una delle risorse più preziose: il tempo. La prima cosa che si fa su un set è illuminarlo e finché non è pronto non si gira. Bisogna diventare il compagno più fedele del regista perché spesso lui ti porta a leggere una sceneggiatura che ha scritto in un anno o in tanti mesi. Quando arriva, il direttore della fotografia, sa poco o nulla del grande lavoro che c’è già dietro ed è importante portare in vita la visione del regista. Quando le cose funzionano è la cosa più bella, rapporti di lavoro in cui basta uno sguardo per capirsi e realizzare la scena. Quel tipo di fiducia è una delle cose che cerco di più nel mio lavoro. Lo stimolo di quella fiducia ti spinge anche a provare cose che non faresti, a uscire dalle tue abitudini, e così facendo a scoprire dentro di te nuove sensibilità artistiche».
Nel suo lavoro cosa vorrebbe raccontare?
«Secondo me c’è un obiettivo da parte di un direttore della fotografia, l’obiettivo di dimenticarsi della tecnica e entrare in un discorso narrativo. Assorbirla così a fondo da non pensarci più e metterla al servizio della narrazione. Voglio mantenere vivo lo spazio della mia sensibilità e comunicarlo».

Guardando i suoi lavori sembra che lei non abbia paura del buio in una scena, anzi che spesso cerca le ombre?
«È una cosa vera, sicuramente mi piace tantissimo mettere una sola fonte di luce, riuscire a essere chiaro così e sottolineandone le ragioni. La scelta del buio può dipendere dalla scena, ma un unico punto luce è un modo per sottolineare gli elementi narrativi».

Cosa le piacerebbe raccontare, che luoghi le piacerebbe illuminare?
«Bella domanda, una delle cose per cui mi piace la fotografia è che mi immergo con l’estetica in mondi diversi. Si passa rapidamente dai film in costume ai ragazzi di borgata. Però sicuramente il gusto o le immagini che sento mie sono quelle delle atmosfere più periferiche e più urbane. Proprio illuminando i luoghi di Inchei mi muovevo naturale lo sentivo mio. Ecco se dovessi scegliere direi che vorrei portare la luce in quei luoghi che non vediamo spesso o proprio non vogliamo guardare».

Adesso l’obiettivo è lavorare a un lungometraggio?
«Si si l’obiettivo è quello, ci sono cose che aleggiano in aria e sono fiducioso. Non vedo l’ora di potermi misurare su una narrazione lunga perché lì le scelte fotografiche assumono un valore narrativo ancora più lungo. Per arrivarci però molto dipende sempre dal proseguo che hanno i cortometraggi: se vanno bene ne fai altri e prima o poi uno di quei registi farà un lungometraggio e ti chiama».
Insomma, l’Italia non è un paese per giovani?
«No non lo è, ma le cose stanno cambiando, oggi è più facile esordire».
La rubrica
Il silenzio punitivo, come riconoscerlo per evitare il conflitto tossico. «È una forma di manipolazione: serve a farti sentire in colpa»
di Stefania Santoni
La nuova puntata di «PsicoT» con Maria Rostagno per educare ragazze e ragazzi all'affettività consapevole. «Dopo un litigio, è normale aver bisogno di un po’ di tempo per calmarsi. Ma attenzione: c’è una grande differenza tra prendersi una pausa e usare il silenzio per ferire l’altro»
L'intervista
Federica Morelli e le radici del razzismo di oggi: «Fascismo e colonialismo arrivano dopo, l'origine è la tratta atlantica degli schiavi»
di Francesco Barana
Docente dell’Università di Torino e ricercatrice all’Istituto Storico Italo-Germanico della Fondazione Bruno Kessler di Trento, assieme al suo gruppo di ricercatori ha avviato il progetto «BlackItaly». «Raccontiamo una storia dimenticata»
L'intervista
Pergine, Iacozzilli porta l'Alzheimer sul palco. «Quando la malattia arriva all’interno di una famiglia, va in pezzi. Il punto è trasformare il dolore in bellezza»
di Ilaria Bionda
Con il «Il grande vuoto» parte l'edizione 2025 di Pergine Festival. «La volontà è stata quella di portare a teatro un tema di cui si parla ancora troppo poco»
L'esposizione
Cles, le opere di Tamanini in mostra per celebrare l'arte di sbagliare. «L'errore? È possibilità, un'occasione per mettersi in discussione»
di Stefania Santoni
L'esposizione «Se non sbaglio» dell’artista visiva e multidisciplinare, curata da Marcello Nebl, è visitabile alla Galleria Batibōi