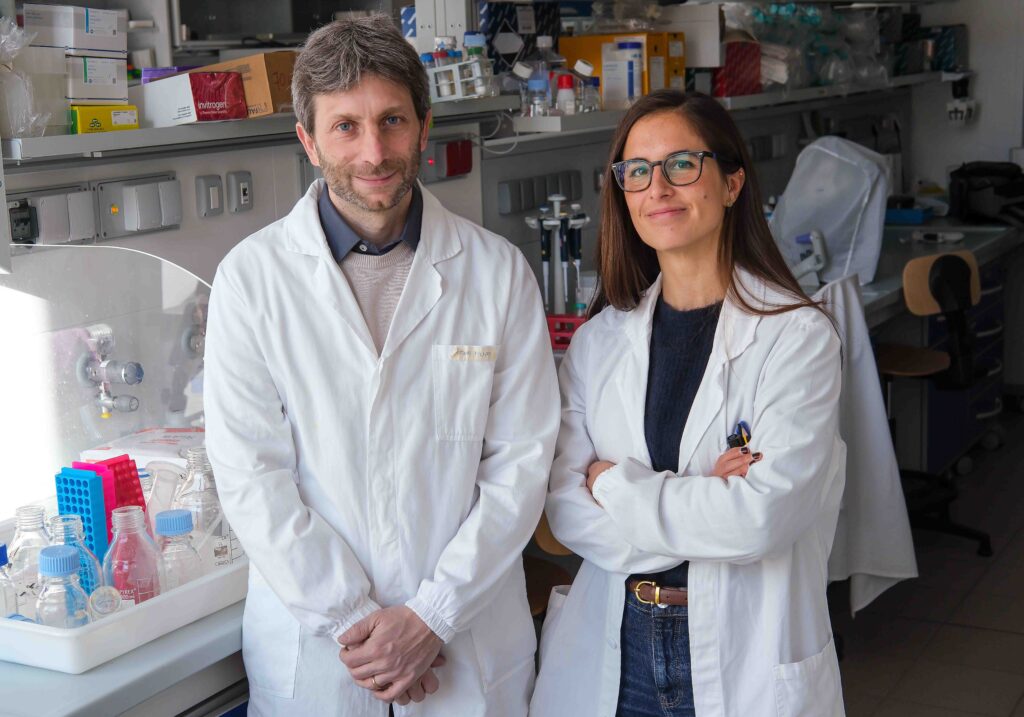L'editoriale
sabato 16 Agosto, 2025
I tempi lenti della villeggiatura
di Elena Tonezzer
In tempi di overtourism e di vacanze misurate in ore, il turismo quasi stanziale e «interno» al Trentino nato nel Secondo Dopoguerra è andato perdendosi insieme al suo significato

La villeggiatura estiva trascorsa dagli abitanti delle città nelle vallate trentine inizia a diffondersi in modo massiccio a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso. Il boom economico, la presenza di mezzi di trasporto privati – le prime Cinquecento – insieme con una struttura familiare in cui la donna ancora non lavorava fuori casa, facevano sì che con l’inizio della vacanza scolastiche ci fossero veri e propri traslochi verso le vallate. I mariti potevano raggiungere le famiglie nel fine settimana, mentre figli e figlie rimanevano con la mamma «ai freschi» per periodi oggi quasi incredibili, alcuni mesi da giugno a settembre.
Le direzioni di queste migrazioni dai centri alle valli risentivano della vicinanza: se da Rovereto si andava soprattutto verso l’Altipiano di Folgaria o la zona del lago di Cei, da Trento le mete erano per lo più l’altopiano di Baselga di Pinè e il Bondone, che si sviluppa anche grazie alla costruzione delle case delle vacanze. Inizialmente poteva capitare che nei paesi i proprietari si trasferissero nei fienili o nelle soffitte, per affittare le loro stanze e appartamenti ai nuovi inquilini stagionali. Dopo i primi anni un po’ all’avventura, con il crescere delle disponibilità economiche e l’ambizione di raggiungere lo status della seconda casa, i «zitadini» non si accontentano più di abitare nelle stanze contadine di Serrada o Miola, ma acquistano terreni e costruiscono nuove abitazioni modellate sulle loro esigenze. I tornanti che da Candriai si susseguono fino a Vason, iniziano a essere sempre più punteggiati di case, villini, chalet, in uno stile architettonico che unisce il gusto urbano a quello alpino.
L’incontro tra villeggianti e residenti non è sempre semplice, le aspettative e le abitudini erano diverse, ma sicuramente dal punto di vista economico i guadagni estivi iniziano presto ad essere importanti per i bilanci delle famiglie contadine. La mentalità, i consumi e le abitudini urbane arrivano nei paesi in anni di cambiamenti forti e veloci, che coinvolgono in particolare l’emancipazione delle ragazze e la nascita dei «giovani», intesi come nuovo gruppo con esigenze culturali e sociali proprie. Difficile ricostruire l’impatto di questa presenza stagionale, che va interpretata nelle due direzioni, perché se i giovani di città potevano innestare comportamenti inediti nei paesani, non va trascurato l’effetto che le relazioni e la conoscenza di stili di vita rurali può aver avuto sui vacanzieri.
Questo fenomeno di un turismo quasi stanziale e «interno» al Trentino, che rimescolava le provenienze e i rapporti tra valli e centri urbani, è andato perdendosi negli ultimi anni. Chi non ha vissuto quelle estati trascorse nei paesi può solo immaginare cosa poteva dire lasciare la città per costruire relazioni di amicizia in luoghi che diventavano speciali. È nella memorialistica che inizia ad affacciarsi nelle librerie che è possibile rivivere quelle estati epiche: «Il 26 giugno si affrontava il viaggio» – così venivano vissuti dalla famiglia di Francesca Rocchetti i 45 chilometri che dividevano Trento da Salter («Salter. Da sempre. Anzi, da prima», Edizioni del Faro, 2024). Il suo racconto dei mesi trascorsi nella casa fatta costruire dalla nonna in val di Non è capace di far rivivere i tratti di una vera seconda vita. Vacanza, paesaggio, relazioni si ritrovano in una comunità che unisce persone che trovano a Salter uno spazio sentimentale irripetibile. Il racconto di Rocchetti si unisce con le voci di amiche e amici che hanno vissuto nella sua comunità d’elezione, ma si tratta di situazioni in cui possono riconoscersi anche altri che hanno trascorso i mesi estivi in paesi e valli trentini.
Le seconde case rimangono ancora nei paesi e nei prati, talvolta sono diventate prime case dei nipoti di chi le ha costruite, spesso sono ancora le case del cuore, costruite per famiglie numerose e che ora ospitano i ben più piccoli nuclei familiari degli eredi, per lo più nei fine settimane o nei giorni di Ferragosto. Molte sono state riscoperte e apprezzate nei mesi dell’epidemia di Covid. Di solito si trovano nel Trentino bello ma «minore», in realtà in cui il turismo è solo uno degli aspetti economici e sociali, non quello determinante. In tempi di «overtourism» concentrato in pochi «hot spot», di vacanze che si misurano in ore e non i giorni, di «immersive holidays» e «selfie» condivisi in diretta, ripensare ai tempi lenti dei paesi della villeggiatura popolare fa quasi tenerezza. Per chi ha avuto la fortuna di vivere quella stagione turistica, sono – per usare le parole di Rocchetti – «il posto buono che forse tutti dovremmo avere, nascosto in qualche angolo di mondo, il posto degli affetti lontani ma vicini, delle persone amiche che ti saranno amiche per sempre. Il luogo dove l’aria che respiri ti conosce, così come ogni silenzio è tuo fratello, dove stai male se non ci torni».
*Ricercatrice della Fondazione Museo storico del Trentino