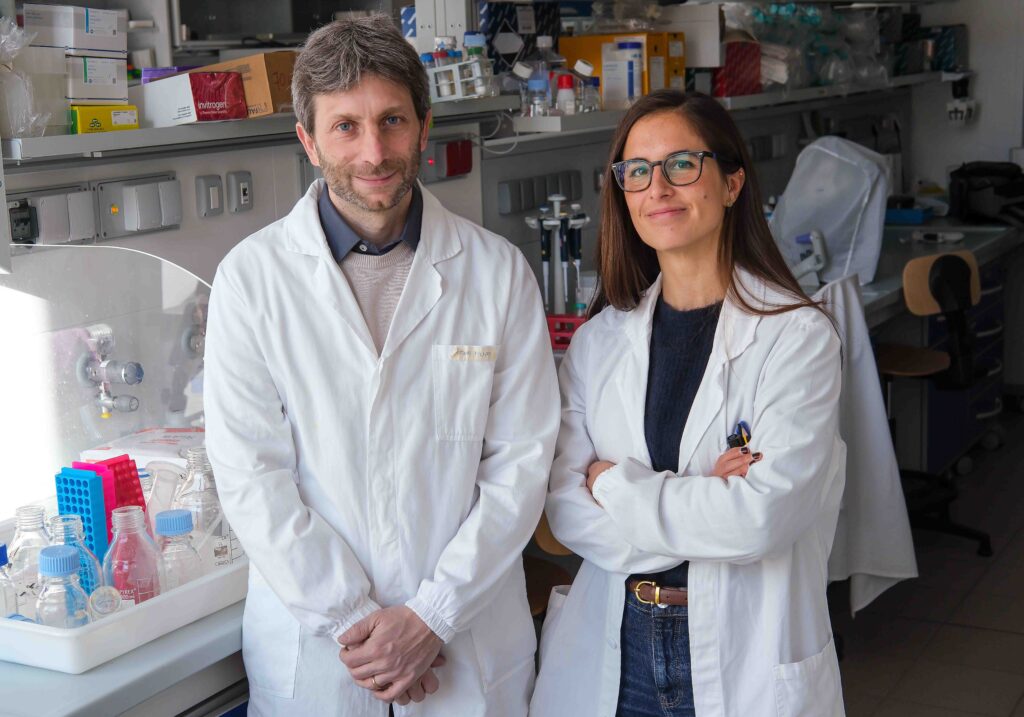L'editoriale
venerdì 15 Agosto, 2025
L’intelligenza artificiale a sostegno dei medici di base
di Alessandro Quattrone
L'editoriale di Alessandro Quattrone, professore ordinario di Patologia generale dell'Università di Trento: «I nostri medici di famiglia non sono X-Men e X-Women»

Pensate a un lavoro nel quale vi si pongono di fronte 1500 persone, e dovete confrontarvi ogni giorno con una decina o più di loro tramite incontri brevi di persona, oppure con decine di loro tramite incontri brevissimi per via telefonica. Di ciascuna, all’impronta, dovete ricordare perfettamente aspetti salienti del passato, anche perché molti daranno per scontato che lo facciate. Da loro comunicazioni spesso sconnesse, brevilogiche, o «inquinate» da opinioni formate in fretta attingendo a mezzi di informazione non verificabili, dovete estrarre degli indizi che vi aiutino ad aiutarli. Sul vostro versante avete un corpus dottrinario di oltre 30 milioni di studi, a cui ogni anno se ne aggiunge un milione e mezzo ulteriore, dove si trovano le nozioni, talora incerte e contraddittorie, che vi servono per dare un senso al vostro incontro. E, dimenticavo: non potete proprio sbagliare.
Questa professione distopica è il lavoro che in Trentino, come in altre parti d’Italia, viene chiamato «medico di medicina generale». E sappiamo quanto sia importante: è la prima interfaccia fra il sistema sanitario e il paziente, la prima occasione di tentare una diagnosi, o di suggerire accertamenti specialistici, oppure di tranquillizzare l’interlocutore finendola lì, tenendo conto anche delle note ristrettezze economiche in cui versa il sistema stesso. Se si fa eccezione dei pochi, purtroppo, studi epidemiologici attivi, è davvero il fulcro centrale della macchina che dovrebbe consentirci di scoprire precocemente una patologia, in modo poi da doverla curare al minimo della sua gravità e del suo costo.
Ma c’è un problema: anche se non possiamo darlo per certo, i nostri «330 trentini» medici provinciali di famiglia non risultano essere X-Men, o ambire all’universalità culturale di Leonardo da Vinci. Sono bravi, spesso eccellenti, professionisti sono anche persone che sanno bene quanto pazienza, disponibilità ed empatia contino, oltre alla competenza, nel rapporto col paziente. Ma sono umani, e in quanto tali anche fallaci.
Sappiamo che stiamo vivendo da una decina d’anni a questa parte forse la più importante rivoluzione tecnologica dell’umanità, assieme a quella industriale di fine diciottesimo secolo. L’intelligenza artificiale dei «deep network» e dei «large language model» sta velocemente cambiando il mondo, non sappiamo dire verso dove. A febbraio di quest’anno è uscito in sordina un articolo scientifico dove si mostra come il modello GPT-4o di OpenAI raggiunga il 93,3% di risposte esatte in un test di un migliaio di domande di medicina basato su casi. Non sarebbe una notizia se un campione di medici esperti totalizzasse allo stesso test il 61,9%: una risposta su tre sbagliata. Com’è normale, e umano, d’altronde. In questi giorni GPT-4o è stato sostituito da GPT-5, e probabilmente scopriremo che allo stesso test quest’ultimo è vicino al 100% della precisione. I GPT appartengono a un novero ristretto di modelli linguistici molto potenti al cui impiego, com’è noto, si arriva oggi con degli abbonamenti a costi irrisori, equivalenti a quelli delle piattaforme di streaming. Allora perché non addestrare ulteriormente questi modelli a «presenziare» in qualche modo ai colloqui degli assistiti con i medici, e con loro collaborare nella decisione go/no-go che potrebbe voler dire, mesi o anni dopo, la vita o la morte del paziente e risparmi ingentissimi in spesa sanitaria? C’è un’intera scienza multidisciplinare, per questo, lo studio delle interfacce uomo-macchina, che oggi possono essere minimamente ingombranti e non fare da «terzo incomodo» fra medico e assistito.
È inutile ribadire qui che nella storia che si profila la parola finale spetta sempre e comunque al medico; oltre ciò, tuttavia, ogni ulteriore distinguo o resistenza ha un nome preciso: si chiama luddismo. Vi fidereste dello stesso vostro medico, col quale avete forse un rapporto di fiducia, ma che abbia sull’indice, oltre alla sua esperienza, i 35 milioni di articoli di ricerca pubblicati fino ad oggi, e la possibilità di dialogare, per raggiungere la verità, con un «collega» di silicio a cui non è sfuggito nulla, proprio nulla, della interazione con voi?
Con un poco, veramente poco, di ricerca in più, e soprattutto un piano di aggiornamento ben fatto che tenga conto di importanti aspetti psicologici, potremmo trasformare i nostri primi interlocutori sullo stato di salute in veri X-Men e X-Women della medicina. E risparmiarci tante sofferenze e tanti soldi. Il tutto pressoché ora, non fra 3 o 5 o 10 anni. Perché non lo si sta facendo?
Prima di abbandonarci a qualche teoria del complotto, attendiamo fiduciosi un altro po’.