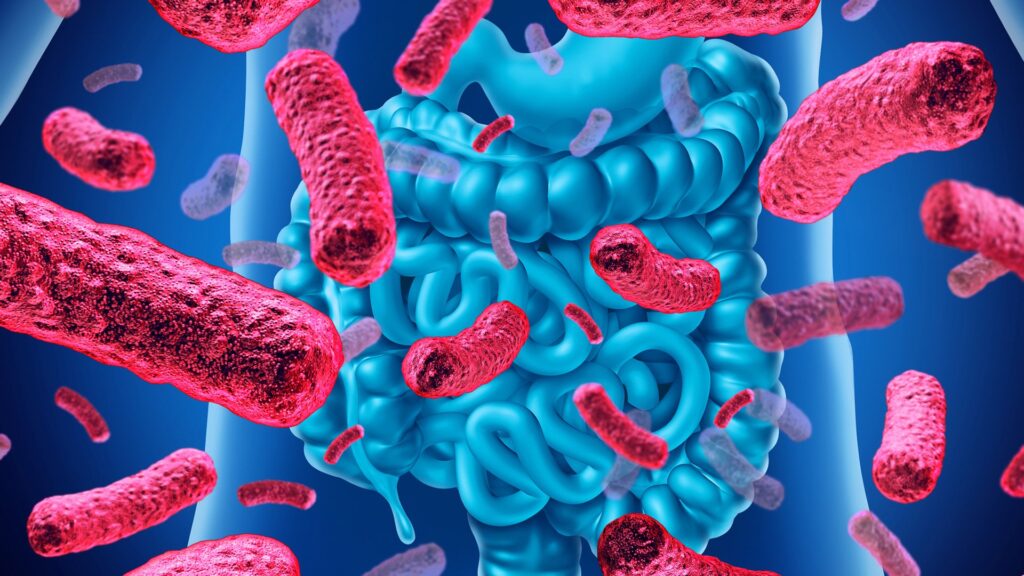L'editoriale
venerdì 12 Gennaio, 2024
La fragilità degli uomini
di Simone Casalini
L’esecuzione di Ester Palmieri, i femminicidi che guadagnano l'attenzione mediatica. E una parte (maggioritaria) che è silente, indifferente o a disagio. È quella maschile. La fragilità dell’uomo, che può diventare violenza o afasia, è il punto d’ingresso di qualsiasi discorso di mutamento

L’esecuzione di Ester Palmieri riporta ancora i femminicidi al centro del racconto sociale. Come se questa infinita sequenza di fotografie di donne nella loro dinamica di vita espropriata non potesse avere un termine. Come se l’infinita sequenza del privilegio maschile di stabilire il calendario delle stagioni affettive e quello delle piogge monsoniche fosse un dispositivo ineliminabile. La cultura è, in effetti, un dispositivo molto resistente ai cambiamenti. Le società, anche quelle che si pensano progressiste, rimangono essenzialmente in una dimensione di marcata tradizione.
Quando si compie un femminicidio c’è una parte dell’opinione pubblica che rivendica la sua emancipazione, il diritto ai sentimenti, la libertà di scegliere e scegliersi. Ed è l’esperienza sensibile delle donne, costruita negli incastri dell’esistenza, nei pesi e nelle leggerezze che ci destina o che ci destiniamo. Poi c’è una parte che aderisce all’emozione e che esprime una reale empatia, per il dolore e il desiderio sociale di essere altro. E questa parte è mista. Infine, c’è una parte (maggioritaria) che è silente, indifferente o a disagio. È quella maschile.
Perché c’è chi è cresciuto (tanti) credendo che lo squilibrio di genere, l’accurato dislivello che ciascuno di noi coltiva con la propria compagna sia nell’ordine naturale delle cose.
Per molti uomini le relazioni di genere, nel loro senso esteso e aperto, rimangono un non detto. Qualcosa di non decifrato e proprio per questo soffocato e in attesa di emergere. Non mi riferisco a chi ha un chiaro orientamento gerarchico, ma a chi manifesta il suo contrario ma non riesce a praticarlo. A chi vorrebbe condividere l’educazione delle figlie e dei figli e si trova a delegare. A chi vorrebbe scegliersi in amore tutti i giorni, ma accetta solo l’orizzonte infinito del sentimento che è il punto d’ingresso della prigione affettiva. A chi vorrebbe rovesciare i ruoli, ma teme il giudizio sociale o, più paurosamente, di perdere il ruolo stesso. A chi seleziona parole di emancipazione e di liberazione, ma alla fine ne ha timore perché scopri il mal di mare solo quando hai lasciato la certezza della terraferma. A chi osserva cedere i suoi enunciati di libertà di fronte all’esercizio della libertà stessa.
La fragilità dell’uomo, che può diventare violenza o afasia, è il punto d’ingresso di qualsiasi discorso di mutamento. Ma la sua rimozione prevale ancora, procede per inutili e sotterranee rivendicazioni. La fragilità è, invece, un esercizio di sensibilità. Non è debolezza, ma comprensione dell’esperienza umana e sua ricostruzione in una forma equilibrata, corretta, simmetrica. Certamente può essere dolorosa.
Questa esitazione, questa lunga traversata dell’uomo nel deserto del suo potere evaporato, la ritroviamo nella politica. Nell’impossibilità di esprimere una condivisione, anche di linguaggio. Quella c’è solo sui migranti che sono l’altra sensibile rimozione del nostro paesaggio. Una parte della politica, anche nella sua dimensione femminile, non ammette che la violenza possa essere innescata dal genere. E nega un’educazione non solo al rispetto – saremmo sotto il minimo sindacale – ma protesa alla ridefinizione dei ruoli nella società. Non esiste la paternità obbligatoria (è limitata a dieci giorni) per ridistribuire i pesi familiari. Non esiste una normativa del lavoro che ancori in modo indissolubile le donne all’emancipazione economica. Ogni anno registriamo dimissioni per maternità, part time involontari, (auto)demansionamenti per tenere in equilibrio un’idea di famiglia e di società. Non esiste un ripensamento complessivo dell’organizzazione del lavoro e della progressione delle carriere che assicura ancora agli uomini il controllo dei processi.
Non è ammissibile che il cambiamento culturale, o la sua speranza, possa derivare solo dalla sequenza di violenza maschile e dall’emozione che può suscitare. Almeno per qualche ora. Come quella per Ester, per i suoi bambini che si ritroveranno a dover riscrivere un altro libro della loro vita.
l'editoriale
La primatista e la perdente
di Marika Damaggio
A guadagnare l'attenzione, l'8 marzo e il resto dell'anno, sono le donne dei record. Se non si rientra in questa fattispecie altisonante, spesso gonfiata al rialzo, non resta che il silenzio, l’indifferenza, la colpa di essere un po’ così: modeste