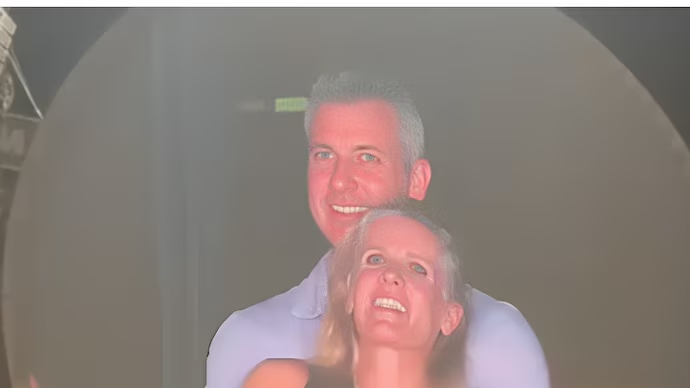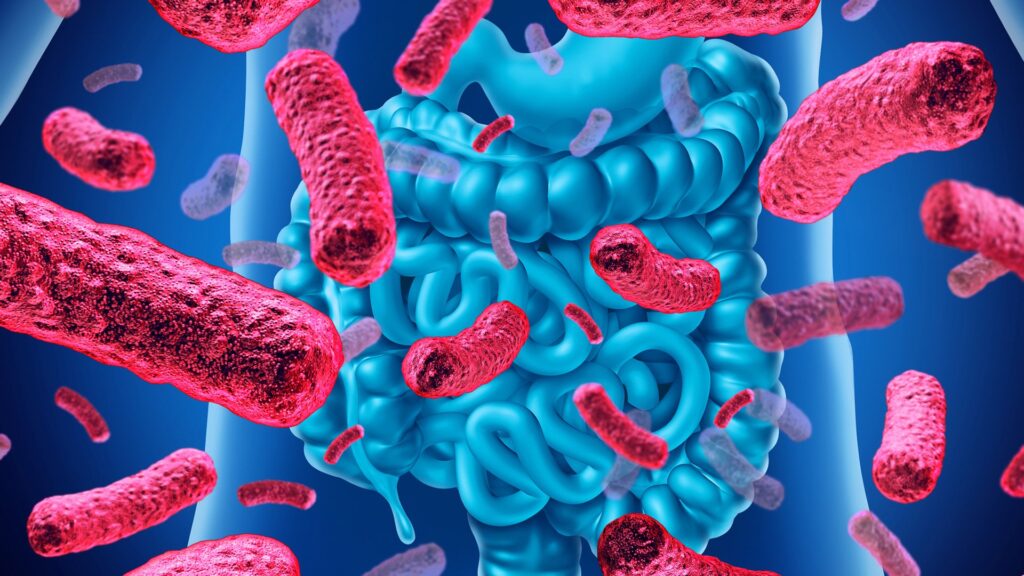L'intervista
mercoledì 10 Aprile, 2024
John Mpaliza, marciatore della Pace e ingegnere: «Ora cammino più di Ghandi»
di Francesco Barana
«Ho perso papà e sorella per la guerra in Congo. Sono stato in carcere con Mobutu»

John Mpaliza ha 55 anni e qualche vita alle spalle. A vent’anni studente universitario e prigioniero politico nell’allora Zaire del dittatore Mobutu, oggi Repubblica democratica del Congo, il suo Paese di origine. A 22 di nuovo studente d’ingegneria in Algeria. A 23, nel 1992, migrante in Italia e bracciante, prima in Calabria e poi in Puglia. Poi, laureatosi ingegnere informatico a Parma, per 15 anni ha lavorato come programmatore nel Comune di Reggio Emilia. Fino a dieci anni fa, quando si licenziò e decise di essere un marciatore della pace. «Era il 30 maggio 2014, lasciai il lavoro, diedi indietro le chiavi di casa al proprietario e partii a piedi per la Finlandia. Marciavo già da quattro anni, quindi ero organizzato, infatti mi ospitò sempre qualcuno» ricorda l’attivista italo-congolese, che oggi risiede a Trento, ma che è nato a Bukavu, la zona dei grandi laghi nell’est della Repubblica democratica del Congo, dal 1996 martoriata da un sanguinario conflitto. Ed è dal Congo che «Peace walking man» – così è chiamato Mpaliza – parte per spiegare la sua genesi: «Ho cominciato a marciare in nome del mio Paese, vittima di un conflitto economico alimentato dall’Occidente e dalla Cina con le loro multinazionali, le quali, attraverso il vicino Ruanda, controllano i giacimenti congolesi di coltan, un minerale che serve per gli smartphone e la tecnologia. Per colpa della guerra è morto mio padre, poi ho perso mia sorella, dispersa che aveva 15 anni. Era il 1999 quando lo venni a sapere…».
Lei, Mpaliza, studiava a Parma…
«Quelle tragedie mi hanno spinto a rivoluzionare la mia vita. Anche se ci ho messo qualche anno a prenderne coscienza. Non molli un posto fisso e un ottimo stipendio da un giorno all’altro, devi avere una causa più grande. Ho cominciato a marciare nel 2010 e a farlo a tempo pieno nel 2014, rinunciando a lavoro, amici, insomma alla vita normale. E pregiudicandomi la possibilità di tornarci, in Congo».
Là è persona non desiderata dal regime…
«Rischierei la vita o di essere arrestato, come è accaduto ad altri attivisti e giornalisti. Ho dovuto rinunciare al doppio passaporto, dovrei chiedere un visto per tornare e mi rintraccerebbero subito».
Ricorda la prima marcia?
«A Santiago di Campostela. Rompevo le scatole ai pellegrini chiedendo se sapevano del Congo. Ovviamente no, però mi resi conto che quel sistema di attivismo funzionava. Decisi che avrei continuato».
Come Gandhi e Martin Luther King…
«Esempi inarrivabili anche se, a differenza loro, io marcio su itinerari più lunghi e per mesi. Siamo arrivati a Ginevra all’Onu, a Strasburgo e Bruxelles al Parlamento europeo per caldeggiare una legge per la rintracciabilità dei minerali. Poi a Roma al Parlamento italiano e in Vaticano, dove abbiamo incontrato due volte il Papa. La marcia è lo strumento più potente che esista, è non violento, attraversi lentamente i territori, conosci le persone e lasci un messaggio in ogni luogo che vai ad associazioni, studenti, società civile, ma anche a sindaci e amministratori. Con la marcia dei bruchi, con cui attraverso pezzi d’Italia ogni anno, raggiungo decine di migliaia di persone. A Trento l’ultima volta avevo duemila ragazzi delle scuole».
Nella marcia dei bruchi, accanto alle grandi questioni dei diritti umani, della pace e della giustizia, si approccia anche a tematiche locali. Come mai?
«Ho una filosofia: per prendere coscienza del mondo, è necessario innanzitutto occuparsi di cosa non va vicino a casa propria. Per questo in Puglia abbiamo lanciato una proposta su come riutilizzare gli edifici e le aziende confiscate alle mafie; mentre in Val di Non si è discusso dei pesticidi. Ovunque ci soffermiamo su ambiente, cambiamenti climatici, consumo del suolo etico, marginalità».
«Lotto per la questione panafricana» ha detto in un’intervista. Nel concreto?
«Non sarà l’Europa o l’Occidente a risolvere i problemi dell’Africa, loro lo hanno creato con il colonialismo e lo sfruttamento delle nostre immense risorse. Ottica panafricanista significa mettere insieme più realtà africane per cambiare l’Africa. Lavoriamo per un risveglio africano. L’Africa è un continente con 800 milioni di persone sotto i 25 anni di età, con infinite risorse energetiche e minerarie. È attraverso il cambiamento politico che possiamo emanciparci».
Da noi domina invece una narrazione compassionevole e caritatevole della questione africana, senza mai davvero approfondire le cause anche politiche della povertà…
«È verissimo e sono stanco di questo modo di raccontare. In Congo è in atto un genocidio tra i più gravi nella storia: in trent’anni sono morte o scomparse dieci milioni di persone, ma nessuno ne parla. C’è un motivo: l’Africa ha subito quattro secoli di tratta, un secolo di colonialismo, 60 anni di multinazionali, chi la domina economicamente non vuole perdere il bottino, così preferisce che se ne parli come un continente povero e da aiutare con un po’ di carità».
Mentre la questione è politica…
«Avremmo bisogno di pace e istituzioni forti, il benessere arriverebbe. Il Congo è ricco da morire e sarebbe da traino per tutto il continente: ma a chi vanno queste risorse? Non ai congolesi, ma a Cina, Usa ed Europa, che foraggiano queste dittature criminali per accaparrarsi in cambio le materie prime energetiche».
Non crede, a volte, di essere un Don Chisciotte contro i mulini a vento?
«Me ne rendo conto. Però forse sto gettando un seme».