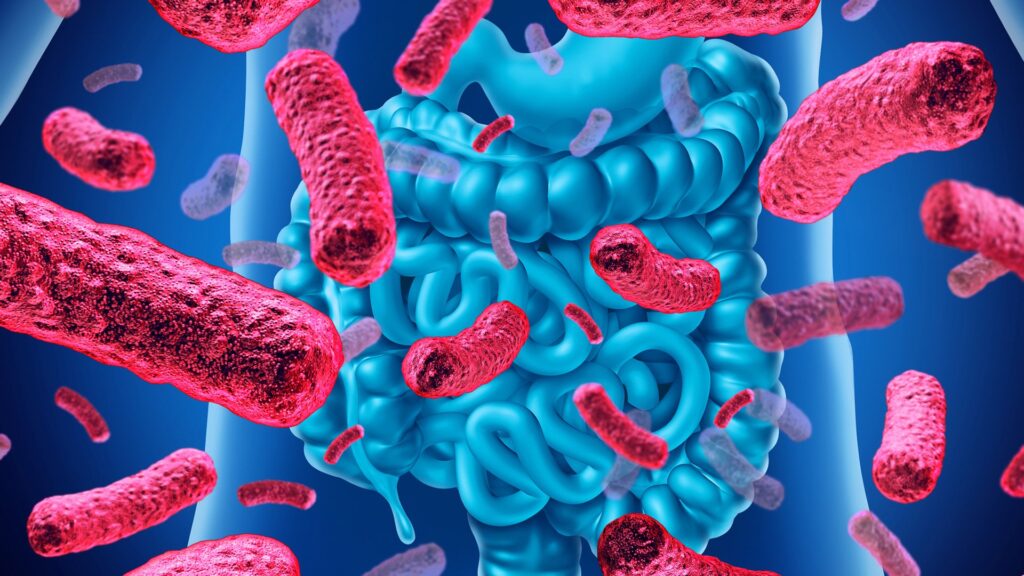L'intervista
sabato 19 Novembre, 2022
«Il colosso Google e il progetto Meta: dietro ai nuovi media»
di Davide Orsato
Paolo Magaudda ha scritto una storia dei media digitali. «I social hanno reso tutti cittadini del mondo»

In principio fu la parola scritta. Il codice informatico di quelle che lo storico (e «futurologo») Yuval Harari, autore del bestseller «Sapiens. Da animali a dei» definisce «ordine immaginario», ossia quel patrimonio di convinzioni e credenze immateriali condivise da una comunità. Un modo di comunicare elitario, che divenne di massa con il torchio di Gutenberg. Una lunga stagione dell’umanità che sembrava tramontata al ritmo incessante della radio, il «tamburo tribale» nella metafora tagliente di Marshall McLuhan. Archiviata dalla tirannia dell’immagine decretata dalla tv. E invece, eccola lì di nuovo, a correre, sotto forma di bit, tra le praterie del digitale, ancora più forte di prima, grazie all’apporto del multimediale: suoni, immagini e realtà aumentata. È una delle contraddizioni di quella rivoluzione che, negli ultimi vent’anni, ha travolto i media: si tornano a leggere gli articoli e non più, solamente, a guardare i servizi, ci si connette a siti con milioni di accessi in contemporanea ma, allo stesso tempo si cercano persone «vicine», dialogando nei gruppi dedicati a Comuni, frazioni, quartieri, in pieno spirito «glocal». Un fenomeno che i nuovi storici della rete stanno indagando da tempo e che, in parte avevano predetto. Tra loro c’è Paolo Magaudda, origine sarde, trapiantato in Emilia, sociologo all’ateneo di Padova, autore, a quattro mani con Gabriele Balbi, di una «Storia dei media digitali» edita da Laterza. «In Italia – afferma – c’è un grande domanda culturale di media in grado di raccontare le comunità».
Professor Magaudda, la contatto da un neonato giornale locale: per molti un media a rischio d’estinzione. Che ruolo possono avere queste voci nell’Italia di oggi?
«La trasformazione dell’industria culturale in Italia è evidente, soprattutto negli ultimi due decenni. Come è accaduto nel resto del mondo a cambiarla sono state le tecnologie, che ne hanno trasformato i contenuti. E, insieme a loro hanno cambiato il modo in cui le persone vivono all’interno di uno spazio pubblico. Un tempo c’era un’appartenenza molto forte alla dimensione nazionale e alla propria città: le edicole rispecchiavano il tutto, con testate locali – cittadine – e nazionali. Ora i social media hanno reso tutti cittadini del mondo, ma al contempo hanno rafforzato le identità, anche a livello di quartiere. Con conseguenze macroscopiche, politiche, la Brexit nasce anche da questo fenomeno. Ecco, credo che i media locali abbiano delle grandi potenzialità nella misura in cui si sapranno riconfigurare su questa trasformazione».
L’impressione è che se, soprattutto online, siano disponibili molte «forme di racconto» per la dimensione globale, quelle locali scarseggino…
«Esattamente. E ciò non riguarda solo i fatti, la cronaca, giornalisticamente parlando. Riguarda anche l’interpretazione di quanto accade. Una società più globale, come quella del nostro presente, ha ancora più bisogno di produrre un senso, un’interpretazione a livello locale. Un senso comune e condiviso che si è perso un po’ con la globalizzazione. C’è bisogno, certamente, di riportare le notizie, ma anche di fornire chiavi interpretative. Faccio un esempio: la guerra in Ucraina è coperta benissimo dai media nazionali, ma solo quelli locali sanno spiegare quale sia l’impatto reale sulla nostra società».
Negli ultimi anni, anche i giornali stranieri con una lunga tradizione hanno rivisto le proprie formule, anche in modo apparentemente controintuitivo. Qualcuno ha ridotto la foliazione per puntare sulla qualità. Altri insistono a mantenere i contenuti online gratuiti, nonostante i costi che lievitano. C’è una ricetta per rapportarsi al meglio con il pubblico d’oggi?
«In questi anni a livello italiano abbiamo visto molti tentativi differenti di approccio alla stampa locale. Molti sono falliti. Penso alle sperimentazioni gratuite e basate esclusivamente sulla raccolta pubblicitaria, proposte allo stesso modo ovunque. Ma forse non c’è un modello unico valido per tutti: le caratteristiche locali sono troppo impattanti e la proposta dovrebbe variare a seconda della zona, soprattutto in un Paese così culturalmente vario come il nostro. Anche per questo motivo la stampa locale può avere un futuro forte, in particolare una forte identità culturale, penso al Trentino come alla mia Sardegna».
Un’interfaccia irrinunciabile, per qualsiasi testata, resta l’online. Lei ha dedicato un’ampia riflessione alla storia di internet, che ha suddiviso in sei periodi, da quello militare, con Arpanet, al web 2.0. Che trasformazione è in corso?
«Abbiamo raggiunto una settima era: quella delle piattaforme. Con i social gli utenti hanno cominciato a produrre contenuti, ora quei contenuti si sono riconfigurati in realtà complesse, con analisi dei dati e capacità di profilazione. E in questo contesto emergono, accanto ai player storici, nuovi sfidanti come Tik Tok che, al netto dei tanti dubbi sulla privacy degli utenti, stanno spostando il baricentro verso aree che finora erano ai margini della cultura digitale, come certi Paesi asiatici ma anche africani».
In gran parte internet è ancora in mano a grandi gruppi, sono il convitato di pietra con cui tutte le realtà, anche piccole, che lavorano con i contenuti online devono confrontarsi. Il rischio monopolio è sempre dietro l’angolo. Ciò è destinato a cambiare, prima o poi?
«Sono quelli che nel mondo digital si chiamano comunemente Gafam, un acronimo che mette insieme Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Sono megaziende attive in più settori. Google non è più un semplice motore di ricerca ma un immenso concessionario pubblicitario. Il rischio monopolio continua ad esistere, ma la storia recente ha dimostrato che l’Europa può avere molta voce in capitolo, rappresentando uno dei principali mercati globali. Il problema, in questo caso, è la scarsa capacità decisionale dovuta alla frammentazione politica».
Nelle ultime settimane si è tornato a parlare di Meta: un investimento colossale, 15 miliardi di dollari, che al momento risulta essere un deserto di utenti. Da studioso del digitale che feeling ha al riguardo?
«È vero, per un certo verso, che siamo abituati a cambiamenti rapidissimi sul fronte dei media digitali, ma bisogna considerare che Meta è un investimento sul lungo termine: chi ci sta lavorando guarda agli anni Trenta del nostro secolo. Attenzione: non è detto che sarà proprio questo lo scenario che prenderà definitivamente forma, potrebbero esserci nuovi attori pronti ad emergere. Ma è interessante notare che il termine metaverso, che ora dà il nome all’intera azienda che possiede Facebook e Instagram, oltre a Whatsapp, cioè Meta, è stato preso da un’opera di fiction, Snowcrash di Neal Stephenson, uno dei grandi classici del cyberpunk. È la prova che tutto quello che viene immaginato ha conseguenze reale e che persino il prodotto che si dichiara maggiormente all’avanguardia nell’ambito del digitale è debitore di un media ben più anziano: il caro, vecchio romanzo».
L'anniversario
Srebrenica, l'11 luglio indelebile che in Europa si prova a negare: il massacro di trent'anni fa e la marcia per la pace
di Nicole Corritore e Marco Abram*
Al Memoriale di Potočari la commemorazione annuale: saranno tumulati i resti di sette vittime. Tra questi anche una donna, Fata Bektić, uccisa all’età di 67 anni
l'intervista
Alessandra Campedelli: «La nostra libertà è un valore per cui lottare sempre. Io, donna occidentale, arrivata in Iran e Pakistan ero limitata come loro»
di Sara Alouani
La coach di pallavolo trentina ha allenato le nazionali femminili di due Paesi islamici. Sabato presenterà il suo memoir «Io posso»