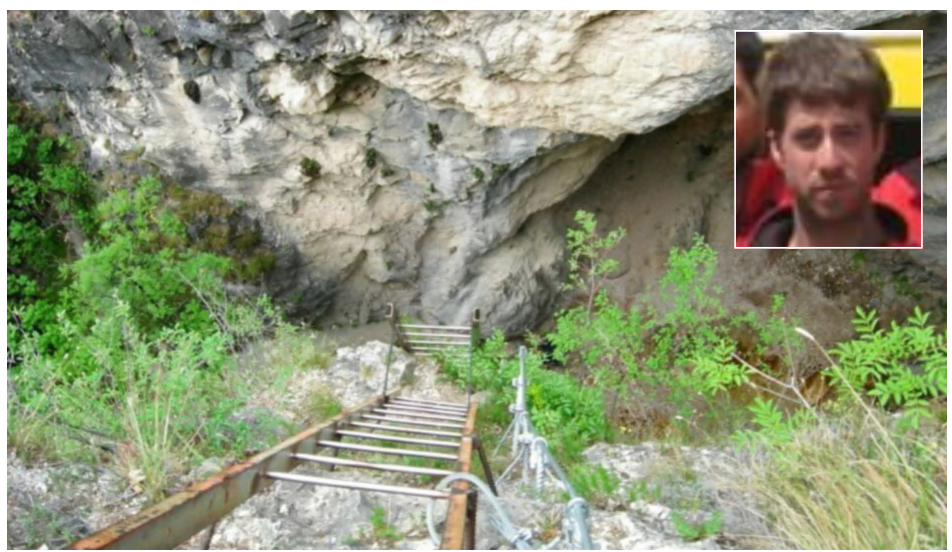L'intervista
sabato 13 Settembre, 2025
Armando Punzo e il teatro nel carcere di massima sicurezza: «La speranza è realizzare qualcosa che sembra irrealizzabile»
di Anna Maria Eccli
Attore, drammaturgo e regista, 37 anni fa ha fondato all’interno del carcere di Volterra la Compagnia della Fortezza

Forse nasce da suggestione narrativa, ma che “il prossimo” di evangelica memoria, da guardare in faccia, da amare, da curare, possa non riguardare solo l’altro, ma il “sé” sconosciuto che alberga in ciascuno di noi, sorta di sé bambino che deve ancora emergere, vale sicuramente più d’un racconto. Sulla fiducia nella possibilità di miglioramento dell’umanità ha puntato tutto Armando Punzo, attore, drammaturgo, regista che 37 anni fa ha fondato all’interno del carcere di massima sicurezza di Volterra la Compagnia della Fortezza. Una rivoluzione con cui ha affermato un concetto di arte lontano dall’esercizio retorico di un’estetica stufa di se stessa, diventando pratica trasformativa, nella convinzione che il male assoluto stia proprio nel «negare la possibilità d’essere altro da sé». Il regista è approdato a Rovereto per «Concrescenze», incontro promosso da Scienze Cognitive che lo ha visto interloquire con il filosofo Vito Mancuso.
Maestro, quando dice che “il teatro deve essere una possibilità di abbandono definitivo di sé, un morire a sé”, esprime la stessa potenza rigeneratrice che ispira la Compagnia fondata nella fortezza medicea di Volterra, ma anche il concetto di “conversine” di Vito Mancuso.
«Non conoscevo Mancuso di persona, prima. Incontrarlo a Rovereto mi ha reso felice perché ho sempre apprezzato molto i suoi libri. Inizialmente erano letture che non sembravano connesse con il mio lavoro. Invece Mancuso è diventato mio compagno di strada».
Lei considera il teatro una “pratica laica” di tolleranza e libertà, il che richiama una sorta di liturgia dell’uomo moderno.
«Il teatro è una pratica nella quale l’essere umano ha la possibilità di sperimentare diversi aspetti di se stesso: razionalità, emotività, psichismo… È una pratica completa, in cui l’uomo si mette in gioco con sé e nei confronti del mondo. E questo è davvero straordinario, è proprio una pratica laica».
Fondare la Compagnia di Volterra ha significato scavallare montagne di difficoltà. Al di là del noto sovraffollamento e delle strutture fatiscenti, qual è la situazione delle carceri italiane in quanto a recupero di capitale umano?
«Posso dire che la Compagnia ha dato il là alla nascita di molte altre esperienze simili. Ad esempio, siamo capofila del progetto “Per aspera ad astra”, una rete di esperienze teatrali. In quasi tutti gli istituti di pena italiani, ormai, esistono».
Due anni fa la Biennale di Venezia le ha assegnato il Leone d’Oro alla Carriera, riconoscimento arrivato dopo tutta una serie di premi prestigiosi come due medaglie della Presidenza della Repubblica…
«Il senso del fare teatro sta nell’incontro con gli altri ed è importante che il nostro lavoro sia stato riconosciuto; di recente il presidente Sergio Mattarella mi ha conferito l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica; è importante come conferma che non siamo da soli».
II sottotitolo della conferenza promossa da Scienze Cognitive alludeva alla speranza…
«La speranza viene sempre intesa come tensione verso un risultato finale da ottenere; in sé è qualcosa di poco concreto, lontano. Io credo che prima della speranza di cambiare ci sia “il bisogno” di credere di poter cambiare, di scoprire altri aspetti di sé, del mondo e degli altri. È questo il mio concetto laico di speranza, è un bisogno molto elementare perché rappresenta l’unica possibilità di crescita dell’essere umano. C’è chi ha bisogno di non accontentarsi del proprio stato, chi sente il bisogno di movimento, di mettersi alla ricerca.
Una condizione che io auspico sempre».
Distese d’acqua, scale gigantesche, sudari, geometrie in movimento… lei è anche creatore delle incredibili scenografie dei suoi lavori?
«Sì, mi interesso della parte scenografica, ma dal 2001 lavora con me anche uno scenografo, Alessandro Marzetti».
Parliamo di autori: Shakespeare, Pasolini, Sartre, Brecht… non sono da poco gli autori affrontati. Ma qual è stato il lavoro più provocatorio, forse “Marat-Sade” di Peter Weiss, che ha guadagnato il Premio Ubu?
«Mah, con Weiss siamo agli albori della nostra storia. Eravamo nel 1993. Di sicuro è stato il primo testo impegnato, ma poi ne vennero molti altri, “I Negri” di Genet, “I Pescecani”, sulla figura di Bertolt Brecht… Però, Il mio obiettivo non è mai stato quello di provocare. Anzi, diciamo che io “mi provoco”, tanto. Mi metto in difficoltà, in disequilibrio. Non vado mai per strade già battute che conosco e che mi rassicurano. È il non prevedibile che ci porta al confronto con noi stessi e alla scoperta di cose prima precluse. E per questo i lavori degli ultimi dodici anni della Compagnia hanno un segno molto diverso».
Vale a dire?
«Oggi credo sia più importante creare la realtà che rincorrerla. Non sono più tanto convinto che serva metterne in mostra gli aspetti negativi; sento il bisogno di uscire dalla rappresentazione di temi dominanti, preoccupazioni quotidiane che sono già passate su TV e giornali. Infatti siamo reduci da “Cenerentola”, lavoro lungo, impegnativo, ispirato a Ernest Bloch, il filosofo che credeva nella possibilità di incidere sulla realtà. La sua idea non è utopistica, è realizzabile con il lavoro quotidiano sorretto da una visione. La speranza è questo: realizzare qualcosa che sembra irrealizzabile».
Il suo “Hamlice” – crasi di Amleto e Alice – “la fine d’una civiltà”, del 2010, era profetico della stagione di follia odierna?
«No, quel lavoro voleva mettere proprio in crisi l’idea che il mondo sia dato per sempre e che non lo si possa cambiare. Certamente, questo è anche il dramma che stiamo vivendo oggi; ogni realtà, per proteggersi e auto confermarsi vuole suggerire l’idea di essere “per sempre”. Ma io so bene che non è così. Nel carcere lo si capisce e sperimenta pienamente».
Si è formato alla scuola del polacco Grotowski, cosa le è rimasto di quell’insegnamento?
«Grotowski e il suo “Per un teatro povero” sono il motivo stesso per cui ho incominciato a fare teatro. Per me resta una figura di riferimento, non dal punto di vista estetico, ognuno ha la propria linea di lavoro, ma perché la sua profondità rappresenta una sfida perenne».
Sostiene che la disciplina è ciò che permette di costruire una vita orientata. Quanta fatica fa a comunicarlo all’interno di un carcere?
«Nel carcere vivo tutto il giorno, lavoro con le persone e la disciplina è concreta; non la si comunica, la si vive, la si pratica nell’azione quotidiana».